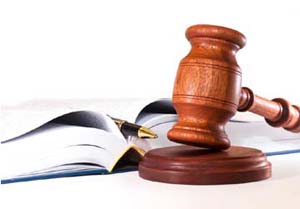Perdita
della libertà ed autonomia individuale.
Come affermato in
precedenza la vita del detenuto è regolata dalle imposizioni
dell'amministrazione penitenziaria, essa ne organizza la vita quotidiana e ne
stabilisce i ritmi, ogni attività corrisponde ad un dato orario e all'interno
di uno schema prefissato, i detenuti vivono un'esistenza dove le sorprese sono
rare ed ogni evento è largamente pianificato in anticipo; ad aggiungersi a
questa condizione totalizzante, subentra un altro aspetto del regime carcerario
difficilmente descrivibile a chi non ne ha provato gli effetti. Ai detenuti
viene negata la possibilità di amministrare personalmente le proprie esigenze,
essi non hanno appunto autonomia né nell'influire sulle decisioni in merito
alle disposizioni circa la vita istituzionale a livello generale, né per quanto
riguarda le scelte relative alla dimensione personale, per soddisfare la
totalità delle loro esigenze devono fare affidamento al corpo di custodia o
agli agenti dell'amministrazione per conoscere e far valere i loro diritti "uno dei modi più espliciti di rompere l'economia
d'azione di un individuo, è obbligarlo a chiedere il permesso o a domandare
aiuto per attività minori che, fuori dall'istituzione, potrebbe portare a termine
da solo[.] il chiedere non soltanto mette l'individuo nel ruolo, " innaturale"
per un adulto, di essere sottomesso e supplice, ma mette anche le sue azioni in
balia del personale" ( Goffman, 1961, p. 69).
La perdita di autonomia
dell'individuo detenuto è pressoché totale, la realtà detentiva implica che il
detenuto perda la facoltà di gestire secondo criteri personali le proprie
necessità, egli è assoggettato ai meccanismi imposti dall'amministrazione, e si
può affermare che normalmente i punti di vista e le priorità dei detenuti non
coincidano affatto con gli scopi e obbiettivi ritenuti prioritari dalla
Direzione "gli oggetti nominali dei custodi
non sono in generale, gli obbiettivi dei prigionieri". ( Sykes, 1958, p. 74,
traduzione mia) Questo sistema è dunque fonte ulteriore di sofferenza in
quanto il detenuto si accorge che la propria vita è regolata in base a
disposizioni che spesso sono percepite come illogiche se rapportate alle sue
strette esigenze quotidiane: le decisioni prese dalla Direzione secondo una
logica finalizzata a mantenere efficiente il livello di sicurezza all'interno
dello stabilimento (sicurezza necessaria al fine di raggiungere gli obbiettivi
istituzionali secondari, come il trattamento che può aver luogo solo in un
istituto dove l'ordine interno è efficacemente implementato), tendono a
sottolineare la forte contrapposizione esistente tra controllori e controllati:
i primi detengono il potere gestionale nella sua totalità ed i secondi ne
subiscono gli effetti. Il controllo degli individui secondo canoni e procedure
burocratiche comporta al detenuto un ulteriore senso di precarietà, infatti le
regole e le effettive pratiche che gestiscono l'individuo durante la giornata
all'interno di un istituto di pena fondano le proprie logiche sul controllo
razionale delle persone, di conseguenza i prigionieri non solo delegano
forzatamente la loro amministrazione a terzi, in aggiunta le logiche che
governeranno le loro esistenze avranno come priorità non l'individuo, ma
l'efficienza del suo controllo. Dopo aver delegato
la propria gestione, il detenuto è relegato in
una posizione numerica che lo caratterizza come parte di un sistema la cui
solidità si costituisce e si rafforza su
procedure burocratiche e quindi di natura depersonalizzante; secondo il
principio dell'indifferenza burocratica infatti, eventi che sembrano importanti o vitali per le persone che sono alla
base del gruppo sono visti con una
maggiore mancanza di interesse man mano che si sale di un gradino verso l'alto.
Le regole, i comandi, le decisioni che scendono verso le persone controllate
non sono accompagnati da spiegazioni sulle basi del fatto che sono considerate
"non pratiche" o portatrici di " troppi problemi" (Sykes, 1958, p. 74);
il detenuto dipende da un sistema che non gli attribuisce che secondariamente
la considerazione che egli necessita in quanto essere umano, a parte
l'assistenza che egli può trovare nel personale addetto a seguirne le
problematiche psicologiche relative all'ambientamento, tutto il funzionamento del
sistema contribuisce a rafforzare il suo senso di spaesamento e di insicurezza
in relazione alle proprie sorti, le decisioni prese spesso non vengono spiegate
ed al detenuto non rimane che accettare la situazione istituzionale, cercando
di mantenere un territorio personale il più possibilmente intatto da queste
procedure mortificanti.
Vorrei portare ad esempio
di questa dinamica di relazione le parole di Shola, 28 anni, (intervista n.4),
detenuta presso la Casa circondariale di Genova Pontedecimo per un periodo di 7
anni, con un totale di 2485 giorni di detenzione; nelle sue parole si può
leggere la frustrazione di una persona che dovendo attenersi a pratiche che
circuiscono la propria realizzazione individuale, negano la possibilità di
disporre a piacere delle proprie risorse: "Non
riesci a fare niente per te stessa, solo sofferenze senza dignità e lavaggio
del cervello" Il non poter far niente per se stessa implica appunto questo
grado di separazione tra le attività che supportano la persona come autonoma e
portatrice delle necessarie possibilità di auto controllo ascritte
all'individuo portatore di diritti e le
effettive possibilità operazionali lasciate al detenuto dall'amministrazione;
la sofferenza per la perdita di dignità in questo caso si declina come perdita
della potestà e controllo delle proprie azioni.
Come ho affermato in
precedenza, il detenuto/a vive nell'immediato contesto pratico questa perdita
di autonomia in relazione alla dipendenza totale nei confronti degli agenti di
custodia: per potere soddisfare le proprie necessità egli/ella deve chiedere il
permesso e spesso - dicono gli ex detenuti intervistati - ciò che dovrebbe
essere garantito per diritto è negato sulla base della priorità conferita alle
logiche di sicurezza e del mantenimento del potere. Di questo parere sono le
parole di Cris ( intervista n.4) che racconta la generalità della su esperienza
in riguardo a questo senso di impotenza in questo modo non riesci mai ad ambientarti perché le guardie non ti
lasciano stare tranquillo. Quando domandi qualcosa che è nei tuoi diritti
domandare minacciano di farti un rapporto, quindi non c'è serenità, tutto
diventa un odissea. Ho fatto 10 giorni di isolamento per un rapporto
disciplinare, la guardia mi aveva rubato due pacchi di sigarette con un
pretesto ed io le avevo detto se stava facendo il furbo, neanche dopo 2 ore
dopo sono venuti 4 o 5 agenti e mi hanno portato in isolamento, lasciato in
mutande per 10 giorni in inverno, se non c'era il lavorante che mi ha dato un
giornale sul quale dormire avrei dovuto dormire sulla branda senza materasso,
né coperte."; secondo Cris nel regime totalizzante che vige all'interno del
sistema carcerario il detenuto che domanda di far rispettare i propri diritti
viene bollato disciplinarmente come insubordinato, come recalcitrante alla
condivisione delle regole imposte: questo comporta a vari livelli la sua
punizione, tramite rapporti disciplinari che inscrivendosi nel curriculum
detentivo causano difficoltà nell'ottenere i benefici, o tramite punizioni di
natura psicologica come l'isolamento o di natura fisica come le percosse.
Entrambi hanno comunque lo scopo di smussare questa propensione del detenuto/a
a non accettare passivamente ed in totum le pratiche di controllo alle
quali è sottoposto: l'analogia con l'odissea descrive efficacemente
quest'aspetto della detenzione, infatti per quanto riguarda le esigenze non
considerate primarie dall'amministrazione il detenuto non può raggiungere
quello di cui ha bisogno se non attraverso un periglioso percorso nel quale
egli si affida alla volontà dei suoi controllori, come Ulisse affidò al mare la
propria imbarcazione e la propria vita.
Inoltre, a seconda del
periodo che una persona trascorre sotto questo regime privativo, l'influenza di
questi meccanismi che delegittimano l'individuo come portatore di una propria
volontà autonoma e performante perdono in certa misura la loro valenza artificiale e acquistano la
parvenza di realtà naturale; questo ha
delle conseguenze anche dopo la liberazione della persona: spesso infatti, e in
maggior grado per i detenuti che hanno affrontato una lunga esperienza
detentiva, si verifica una situazione di disagio al momento del reinserimento
nella vita di tutti i giorni. Gli ex detenuti/e incontrano difficoltà a
riadattarsi alla libertà della vita quotidiana, hanno difficoltà a ricomporre
la propria immagine come persona autonoma che non deve chiedere il permesso per
ogni singola necessità; questa sensazione è sottolineata nelle parole di Cinzia
( intervista n.6) che afferma: "Per un po' di tempo la libertà mi sembrava
strana, poter far le cose di nuovo di mia volontà, poi tutto è ritornato
normale"; la libertà percepita come strana indica l'adeguamento di Cinzia ad
altri canoni di esistenza, quelli della detenzione, quando i canoni della
libertà sono nuovamente ristabiliti è necessario del tempo affinché essi
vengano nuovamente percepiti come naturali e costituiscano nuovamente la
dimensione propria dell'agire individuale.