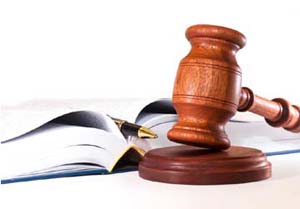Le garanzie relative alla giurisdizione
Solamente per atto motivato dell'autorità giudiziaria si possono
restringere le libertà personale, di domicilio, di corrispondenza e di stampa.
Rispetto agli organi dell'esecutivo le autorità giudiziarie offrono in tal
campo maggiori garanzie nell'applicazione delle previe norme di legge. Accanto
alle riserve di giurisdizione, però, ulteriori e più generali garanzie sono
evidenziate dalle stesse disposizioni costituzionali sui "rapporti civili": a
cominciare dal primo comma dell'art. 25, in cui si afferma che "nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Il principio del
giudice naturale non si risolve nel divieto di istituire "giudici
straordinari"; bensì concerne le modalità di "designazione del giudice in
relazione a ciascuna regiudicanda". Per mezzo di esso si concreta la certezza
del giudice, con riguardo a qualsiasi tipo di giudizio. In dottrina si è anzi
ragionato di un "diritto al giudice naturale", mettendo in tal modo l'accento
sul nesso riscontrabile fra tale garanzia e la tutela delle libertà
fondamentali.
Giudice naturale è in linea di massima sinonimo di giudice in vista del
quale la legge effettui una "previa determinazione della competenza, con
riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro". Essenziale in tal
senso appare il requisito della precostituzione, da verificare rispetto al
momento in cui l'azione viene esercitata. Così definita la regola non manca di
subire importanti eccezioni. La corte costituzionale ha sostenuto in diverse
occasioni che l'art. 25 primo comma non esclude del tutto le norme processuali
retroattive. D'altro canto, la corte non ha mai negato che possa aversi un
qualche "spostamento della competenza" dall'uno all'altro giudice. Di qui
derivava e tuttora deriva un problema ricorrente, che può esser prospettato nei
seguenti termini: la scelta del singolo magistrato nell'ambito di un composito
ufficio giudiziario mette o meno in gioco il principio del giudice naturale? La
corte costituzionale ha tendenzialmente risposto nel secondo senso, esigendo la
preventiva individuazione del giudice, che deve postularsi legata a criteri di
obiettività ed imparzialità"; ma nel concreto essa ha largamente ammesso che i
dirigenti di ciascun ufficio possano e debbano ripartire il lavoro fra i vari
magistrati. È in questa prospettiva che occorre chiedersi se la naturalità del
giudice debba essere distinta dalla precostituzione. Ma le scelte discrezionali
che la corte ha finito per giustificare incrinano l'assunto che la
precostituzione s'imponga in maniera assoluta. Nel campo della giurisdizione
non trovano posto le sole garanzie di diritto oggettivo, sul tipo di quella
concernente il "giudice naturale", ma veri e propri diritti soggettivi. È
questo soprattutto il caso del diritto-potestà di agire in giudizio; nonché il conseguente
diritto di difesa. Le due componenti, l'azione e la difesa, concorrono anzi a
formare un comune diritto alla tutela giurisdizionale. Quanto all'azione essa
abbraccia la tutela di qualunque situazione soggettiva si vantaggio che abbia
un "carattere sostanziale". Inoltre essa "deve trovare attuazione per tutti" -
cittadini o stranieri o apolidi - "indipendentemente da ogni differenza di
condizioni personali o sociali". È quindi venuta meno l'antica esclusione degli
atti politici del governo dal novero dei provvedimenti impugnabili presso i
giudici amministrativi; formano infatti eccezione i solo "atti costituzionali"
del potere esecutivo. Tuttavia, il precetto dell'art. 24 non si risolve
nell'assicurare l'accesso ad un giudice; bensì comporta che sia garantita
"l'effettività" della tutela, togliendo di mezzo "qualsiasi limitazione che ne
renda impossibile o difficile l'esercizio da parte di uno qualunque degli
interessati". Così la giurisprudenza costituzionale è costante nell'assumere
che i termini processuali per l'esercizio dell'azione non debbano essere tanto
brevi da vanificarlo, ma ragionevoli e congrui, "in relazione alla funzione
assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico". La corte
ha sempre richiesto che le parti abbiano conoscenza degli eventi dai quali può
dipendere l'estinzione del processo. Con questo fondamento sono stati eliminati
vari ostacoli che precludevano il ricorso alla tutela giurisdizionale: quale la
cautio pro expensis, per cui l'attore non ammesso al gratuito patrocinio poteva
venire obbligato a prestare cauzione; o quale il solve e repete, onde il
contribuente doveva versare il tributo in questione, prima di poterlo
contestare innanzi al giudice. La corte stessa ha ripetutamente sostenuto che
anche in questo campo si possono imporre esigenze di economia processuale, tali
da escludere un immediato avvio del giudizio; ed ha tenuto ferme svariate
ipotesi di giurisdizione condizionata, nelle quali l'esercizio dell'azione è
subordinato al previo esperimento di rimedi extragiudiziali. Più in generale,
la giurisprudenza costituzionale ha sempre insistito nel senso che il
legislatore ordinario possa differenziare le discipline riguardanti i vari tipi
di processi. E questa giusta premessa ha talvolta generato conseguenze assai
discusse.
Nei processi di parte vige tendenzialmente il principio della
cosiddetta parità delle armi fra i soggetti della controversia; ed è notevole
che in questo quadro rientrino non solamente i giudizi civili ed
amministrativi, ma anche quelli penali. Il perno della difesa è infatti
costituito dal contraddittorio fra le parti stesse: cioè dalla concreta
"possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni", proponendo a tal fine
domande ed eccezioni, ovvero opponendosi a quelle avanzate dalla controparti,
prima che il giudice si pronunci sul punto. Il che non vieta che il
contraddittorio sia talvolta differito. Ancora una volta, ciò presuppone che i
termini processuali siano congruamente stabiliti; che l'interessato "sia posto
in grado di potersi difendere", avendo tempestiva conoscenza degli atti
processuali e che soprattutto gli sia garantito il diritto alla prova circa i
fatti sui quali le sue ragioni si fondano.
In linea di massima invece la corte costituzionale ha negato che le
garanzie dell'azione e della difesa abbiano implicitamente costituzionalizzato
il principio del doppio grado di giurisdizione. Ma il diritto di impugnazione
tende pur sempre ad affermarsi sulla base del principio di eguaglianza: giacché
la sistematica configurazione dell'appello prova sovente di giustificazione
quelle isolate norme da cui rimane esclusa qualunque possibilità di gravame. A
tutti questi effetti l'art. 24 secondo comma non garantisce la sola difesa
personale bensì la difesa tecnica, consistente nell'assistenza del difensore.
La particolare complessità delle questioni esige infatti che patrocinatori
professionali provvedano "alla corretta e completa prospettazione, in termini
giuridici, delle ragioni e richieste della parti". Il gratuito patrocinio
dovrebbe, in verità, formare un'essenziale componente della parità delle armi.
È sempre in questi termini che possono inquadrarsi le notevolissime pronunce
adottate dalla corte, quanto alla difesa dell'imputato. La corte ha ritenuto a
vari effetti necessaria la presenza del difensore in sede di istruzione
sommaria, di interrogatorio istruttorio in genere, di acquisizione di prove e
persino di indagini di polizia giudiziaria. Di più: nel momento in cui certi
imputati per fatti di terrorismo rifiutarono la difesa tecnica, la corte
obiettò che tali assistenza può essere non solo consentita ma imposta dal
legislatore ordinario. L'interesse dell'imputato ad ottenere il riconoscimento
della propria innocenza rappresenta il valore primario da proteggere. E sulla
presunzione di non-colpevolezza si fondano ben determinate regole di
trattamento e di giudizio: sia perché la carcerazione preventiva dev'essere
coordinata con il precetto dell'art. 27; sia perché ne deriva il diritto al
silenzio, usando del quale non si viene costretti ad autoincriminarsi in sede
processuale; sia perché, a questa stregua, il nuovo codice di procedura penale
ha potuto eliminare la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove,
disponendo che l'alternativa alla condanno sta solo nel pieno proscioglimento
dell'imputato.