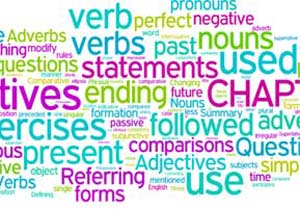Neorealismo
Il Neorealismo è una tendenza affermatasi nel secondo dopoguerra.
Gli autori neorealisti intendevano rappresentare la realtà contemporanea della
guerra, della Resistenza e del dopoguerra, per dare una testimonianza artistica
di un'epoca che segnò tragicamente la vita di tutto il popolo italiano. Proprio
il bisogno di rappresentare direttamente storie di vita vissuta in prima
persona comportò la scelta della prosa a scapito della poesia, l'adozione di un
linguaggio tendenzialmente chiaro e comunicativo, il rifiuto della tradizione
letteraria della pagina ben scritta, che era di moda negli anni Venti e Trenta.
Gli scrittori guardavano ora all'esperienza letteraria del verismo e in
particolare all'opera di Giovanni Verga, ma il termine 'neorealismo'
rinvia oltre al realismo di fine Ottocento, anche al contemporaneo movimento
tedesco della nuova oggettività (Neue Sachlichkeit). La letteratura concepita
dagli autori neorealisti era una letteratura 'impegnata': non opere
di svago, ma libri che aiutassero a prendere coscienza della situazione
contemporanea meditando sulla recente storia nazionale. Vennero fondate alcune
riviste sulle quali condurre il dibattito e diversi scrittori si impegnarono
nel mondo dell'editoria per tradurre in pratica la loro visione della cultura.
La rivista più importante fu 'Il Politecnico' (1945-1947) di Elio
Vittorini, che aveva un'apertura di interessi internazionale. Lo stesso
Vittorini fu insieme a Cesare Pavese tra i più influenti collaboratori della
casa editrice Einaudi di Torino. La parola che dà il nome alla tendenza apparve
per la prima volta nel 1931 in un articolo di Umberto Barbaro, e proprio a quel
periodo risalgono alcuni romanzi che la critica fa spesso rientrare nella prima
fase del neorealismo: Gli indifferenti di Alberto Moravia (1929), Tre
operai (1934) di Carlo Bernari. Questi assumevano come nucleo di interesse
la società italiana contemporanea, descritta con un linguaggio realistico.
Negli Indifferenti una prosa volutamente disadorna fa emergere la
grettezza e il vuoto di valori della borghesia italiana nell'epoca del
fascismo; in Tre operai emergono le vite non meno dure degli operai,
ritratti in modo oggettivo nel mondo della fabbrica.
Una tappa
altrettanto importante verso l'affermazione del neorealismo fu certamente la
pubblicazione in Italia di un'antologia di narratori statunitensi curata da
Vittorini, intitolata Americana (prima edizione 1941). Sempre nel
1941 vengono pubblicati due romanzi che possono essere considerati i diretti
modelli di riferimento per la narrativa neorealistica: Conversazione in
Sicilia di Elio Vittorini e Paesi tuoi di Cesare Pavese. Il
primo racconta del viaggio di un intellettuale dal Nord in Sicilia per far
visita alla madre. Il viaggio è simbolico: chi racconta incontra personaggi
emblematici, portatori di una saggezza antica che ha il compito di riscattare
il 'mondo offeso' dei poveri. Proprio per la forte componente
lirico-simbolica il romanzo di Vittorini non può essere assimilato alle
successive opere neorealistiche (anche dello stesso Vittorini, come ad esempio Uomini
e no, 1945), caratterizzate dallo stile asciutto e referenziale. Paesi
tuoi, invece, narrano di un uomo di città, un operaio, che a contatto con
l'arcaico mondo di una famiglia contadina, scopre drammaticamente la profonda
diversità e incomunicabilità delle due culture. Nonostante la diversità delle
scelte stilistiche, le due opere dal punto di vista tematico e ideologico
(identificazione comunicativa tra autore e pubblico; adesione sentimentale e
morale a soggetti popolari) costituiscono un imprescindibile punto di
riferimento per le opere narrative che, a partire dall'indomani della fine
della guerra, daranno vita alla vera e propria stagione del neorealismo.
A partire dal 1944
è densissima la produzione narrativa, cronachistica e diaristica che riflette
gli eventi della guerra e in particolare della Resistenza: fogli clandestini e
quotidiani pubblicano testimonianze che vengono espresse quasi per una
necessità fisiologia da chi le ha vissute drammaticamente. A guerra terminata
gli editori ricominciano a pubblicare romanzi: del 1945 è Uomini e no di
Vittorini e Cristo si è fermato a Eboli (1945) di Carlo Levi, del 1947
tre delle principali opere narrative contemporanee, come le Cronache di
poveri amanti di Vasco Pratolini, Il sentiero dei nidi di ragno di
Italo Calvino e Il compagno di Pavese. Ma altrettanto rappresentative
della poetica neorealistica sono decine di opere che avranno fama meno
duratura: E in effetti, se si eccettuano rare e tardive espressioni, che
peraltro già si scostano dai modelli originali (un nome su tutti: Beppe
Fenoglio), il neorealismo può dirsi esaurito già intorno alla metà degli anni
Cinquanta. E, infatti, convenzionalmente, il neorealismo si ritiene chiuso con
la polemica che accompagnò la pubblicazione del romanzo di Pratolini, Metello
(1955), storia della formazione umana e politica di un operaio sullo sfondo
delle lotte sociali in Italia fra 1875 e 1902, da alcuni difeso come opera
esemplare di un nuovo realismo, da altri considerato un romanzo fallito
soprattutto per la rappresentazione idealizzata e sentimentale della classe
operaia.
Il neorealismo è un
movimento che si sviluppa soprattutto nel cinema: esso è volto a recuperare
un'aderenza tra immagine, narrazione e realtà. Nonostante le differenze tra gli
stili peculiari di ogni regista, è possibile estrarre alcuni elementi comuni
come, ad esempio, l'abbandono della struttura narrativa romanzesca, la
preferenza accordata alle riprese in esterni, la presenza di attori non
professionisti e il tentativo di rendere conto in modo obiettivo della realtà
politica e sociale del paese in un momento di grandi cambiamenti. Pare che il
termine neorealismo sia stato impiegato per la prima volta nel 1943 dal
montatore Mario Serandrei per riferirsi a Ossessione (1942) di Luchino
Visconti. Visconti, che si era ispirato al romanzo Il postino suona sempre
due volte di James Cain. Ma 'l'école italienne de la Libération',
come i francesi definirono il neorealismo, esplose con il film-simbolo della
rinascita cinematografica del paese, Roma città aperta (1945) di Roberto
Rossellini. Il film era stato girato per le strade di Roma, durante gli ultimi
giorni dell'occupazione tedesca, con pellicole spesso recuperate tra i
materiali di scarto dei documentari di propaganda cui lo stesso Rossellini
aveva dovuto collaborare negli anni precedenti. A Roma città aperta fece
seguito una fioritura che, nel giro di pochi anni, produsse alcuni tra i più
grandi capolavori del cinema italiano del dopoguerra: Paisà (1946) e Germania
anno zero (1947) dello stesso Rossellini; La terra trema (1948,
tratto dal classico verista I malavoglia di Giovanni Verga) e Bellissima
(1951) di Visconti; Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1949) e
Miracolo a Milano (1951) di De Sica, che si avvalse, per le
sceneggiature e i soggetti, della straordinaria collaborazione di Cesare
Zavattini; Riso amaro (1949) di Giuseppe De Santis, melodramma
ambientato tra le mondine del Nord Italia, che lanciò Silvana Mangano e
Vittorio Gassman.