 |
|
| Appunti tecniche |
|
 |
|
| Appunti tecniche |
|
| Visite: 3492 | Gradito: |
Leggi anche appunti:La lotta alla mafia - non solo gli uomini delle istituzioniLA LOTTA ALLA MAFIA - NON SOLO GLI UOMINI DELLE ISTITUZIONI La storia della Normalita' e devianzaNORMALITA' E DEVIANZA 1 IL CONCETTO DI DEVIANZA E LE La Detenzione nelle Dimensioni Psicologiche del Reo: Emozioni, Disagio, PersonalitàLa Detenzione nelle Dimensioni Psicologiche del Reo: Emozioni, Disagio, Personalità Introduzione Il cosiddetto |
 |
 |
Il cosiddetto 'Ordinamento penitenziario', sistema basato sulla Legge 354 del 26 luglio 1975, dichiara esplicitamente di non volere emarginare totalmente i detenuti all'interno degli Istituti carcerari, facendo di essi delle mere strutture di difesa della 'parte sana' della società, ma di volere stabilire dei ponti che prevedano l'apertura del carcere attraverso l'istituzionalizzazione di una vasta serie di legami e di rapporti strutturali e funzionali con il territorio.
Nonostante il Regolamento, è necessario tenere presente che nella realtà dei fatti il carcere rappresenta una Istituzione chiusa e confinata a sé stessa, che ha la capacità di sconvolgere tutto: i rapporti con la famiglia possono indebolirsi, si riducono le possibilità di trovare un lavoro e le speranze di essere accettati nella società senza pregiudizi. È quindi facile immaginare come la personalità di molti detenuti possa risultarne sconvolta. "Il carcere pervertisce, aliena, disgrega, è un momento di vertigine dove tutto si proietta lontano"[1].
Esistono pochi spazi per la dimensione umana, fisica e affettiva. Paura di aggressioni, incertezze del proprio futuro, stati depressivi e di rovina, sindromi psicosomatiche, manifestazioni disforiche, crisi di ansia, possono rendere la sopravvivenza in carcere ancora più difficile.
Si aggiungano poi altre forme di sofferenza psichica, disturbi della personalità e, in rari casi, forme di patologia mentale a carattere reattivo psicogeno.
Il proposito del presente
capitolo è illustrare gli aspetti carcerari strettamente legati al disagio
fisico e psicologico, che giocano un ruolo fondamentale nella mancanza di
benessere nel detenuto: l'isolamento, la
depersonalizzazione e la sindrome da prigionizzazione, il sovraffollamento, le
varie forme di violenza, l'omosessualità. Si cercherà poi di dimostrare come
tali aspetti incidano profondamente sullo stravolgimento delle emozioni e sulla
personalità del reo e come solo la possibilità di ricevere un trattamento
individualizzato e di mantenere delle relazioni significative con l'esterno,
prime fra tutte la famiglia, possa essere un fattore di protezione importante
che si inserisce nel trattamento terapeutico-riabilitativo che l'Istituzione
prevede.
Nell'immaginario comune il carcere è un pianeta: lontano, autonomo, sganciato dalla società e popolato da individui totalmente alieni da essa. In realtà il carcere, così come la sua popolazione, è il prodotto e lo specchio della nostra società, riflette il suo tempo e le sue dinamiche, anche se in modo più intenso. Analizzando storicamente la sua popolazione, si riscontrano non solo il rapporto della società con la devianza, ma anche le grandi problematiche sociali e politiche attraversate dall'Italia: dalla stagione della delinquenza comune, quella povera, si è passati a quella dei terroristi, dei tangentisti e dei mafiosi, mentre attualmente tossicodipendenti e stranieri rappresentano complessivamente buona parte della popolazione detenuta. Il carcere è una nicchia della società ed il suo prodotto, un microcosmo che ne riflette le problematiche, e luogo di osservazione privilegiata delle stesse.
E' un dato di fatto che ogni Istituto penale abbia caratteristiche proprie architettoniche e gestionali, e che molto spesso le prime influenzino le seconde[2], come anche che l'amministrazione imprima il proprio marchio sul carattere dell'Istituto, e che ogni detenuto abbia una propria storia, personalità e delle motivazioni non generalizzabili; tutti questi elementi si intersecano tra di loro influenzando fortemente la gestione del periodo di permanenza del detenuto, e determinando delle dinamiche che si ripercuotono fortemente sulla sua personalità.
Le condizioni di isolamento dalla società che caratterizzano le carceri italiane sono soltanto uno dei problematici aspetti che definiscono questo universo dalle molteplici sfaccettature; a ciò si aggiunga la mancata aderenza ai principi previsti dall'Ordinamento, che va fatta risalire alle condizioni di altissimo sovraffollamento in cui si trovano le strutture che ospitano i detenuti.
L'elaborazione effettuata dall'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, sezione statistica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, aggiornata al 30 giugno 2004 e resa pubblica dal Ministero della Giustizia[3], ha evidenziato che in Italia ci sarebbero 56.440 detenuti, di cui 2.660 donne e 53.780 uomini. Tra questi, 20.151 pari al 35,65% sono in attesa di giudizio, di cui 1.046 donne (39,32%) e 19.105 uomini (35,46%); 36.381 pari al 64.35% hanno subito una condanna definitiva, di cui 1.614 donne (60,68%) e 34.767 uomini (64,54%).
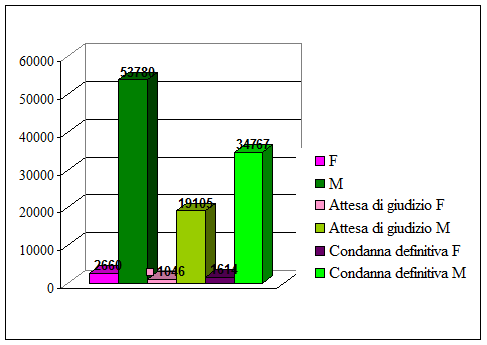
Quanto risulta essere però più problematico è il rapporto tra la numerosità dei detenuti e il numero dei posti disponibili nelle varie strutture penitenziarie italiane; dalla precedente indagine statistica, infatti, emerge come in 201 Istituti in tutta Italia vi siano: 42.313 posti disponibili per 56.440 uomini detenuti, con un indice di affollamento del 133.39%; per le 2.660 detenute vi sono 2.167 posti disponibili, con un indice di sovraffollamento del 101,64%.
Ciò dimostra come la situazione complessiva non sia delle migliori, in quanto ogni 3 posti disponibili vi sono quattro detenuti presenti; si aggiunga inoltre come tale numerosità si ripercuota fortemente sia sulla mancanza di spazi concreti per il soggetto detenuto, necessari per il compimento delle sue attività principali, sia sulla impossibilità di effettuare dei trattamenti riabilitativi che fungano da strumento di prevenzione contro le recidive. Si ricordi, a questo proposito, quanto detto nel precedente capitolo, ovvero che il rapporto tra operatori e detenuti è di 1:250. Una disparità numerica così alta dà un'idea dei limiti pratici che tali esperti hanno nella strutturazione di un lavoro efficace. L'opera di questi ultimi si rivolge ad un trattamento individualizzato, cioè basato sulla valutazione delle specifiche condizioni del soggetto attraverso l'osservazione scientifica della personalità, necessaria per rilevare le carenze fisiologiche e psichiche e le altre cause del disadattamento sociale, e culminante nella stipulazione di un programma che abbia come obiettivo il futuro reinserimento sociale del soggetto. Entro i limiti ferrei di queste proporzioni numeriche non è possibile una corretta applicazione delle previsioni delle Leggi: esse rimarranno sostanzialmente sulla carta se non si arriva a rapporti numerici meno proibitivi.
Si può concludere citando la parole di Turco, Relatore del Parlamento europeo sui diritti dei detenuti nell'UE: "Su 56.440 detenuti presenti nelle carceri italiane al 30 giugno 2004 49.529 detenuti, pari all'87,76%, vivono in Istituti le cui condizioni di detenzione, dal punto di vista della capienza delle strutture, a detta del Ministero della Giustizia, non sono regolamentari.
L'Italia, rispetto ai 25 Paesi membri dell'Unione europea, ha una densità penitenziaria (133.9%) tra le più alte, superata solo dalla Grecia (156%) e dall'Ungheria (159%)"[4].
A queste problematiche, si aggiunga l'enorme aumento di detenuti stranieri, avvenuto negli ultimi decenni nel nostro Paese, che ha portato alla necessità di dare vita ad una attenta analisi del comportamento deviante riferito alle variabili socio-culturali e religiose del Paese di provenienza del soggetto[5]. Il sito della rivista "Ristretti Orizzonti" di Padova ha pubblicato un inserto che suddivide i detenuti stranieri per nazionalità, aggiornato al 30 giugno 2004; senza scendere nei dettagli, basti pensare soltanto che gli immigrati in carcere sono 17.783, di cui 1.143 donne e 16.640 uomini, pari al 31,5% della popolazione detenuta italiana.
Grafico 2: Popolazione detenuta italiana e straniera
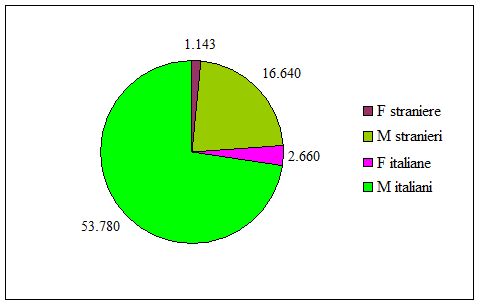
Ciò ha contribuito a promuovere l'integrazione sociale dell'immigrato e la tutela della sua identità attraverso lo studio scientifico dei problemi più frequenti legati alla detenzione di uno straniero; essi nello specifico sono:
Difficoltà di comprensione linguistica;
Difficoltà di relazione sociale intra ed extramuraria;
Difficoltà economiche, soprattutto in riferimento all'impossibilità di usufruire del patrocinio a spese dello Stato per il pagamento del difensore, visto che la normativa prevede la residenza dell'utente;
Appartenenza a religioni diverse;
Impossibilità di usufruire di misure alternative alla detenzione per la mancanza di una rete sociale idonea o per la mancata presentazione di istanza entro i 30 giorni così come previsto dall'attuale normativa;
Tossicodipendenza;
Difficoltà di identificazione all'ingresso in carcere per i soggetti privi di identificazione;
Problemi sanitari;
Difficoltà di ubicazione del soggetto;
Difficoltà di mantenimento delle usanze religiose e della dieta attuale[6].
Il sovraffollamento implica inevitabilmente la tendenza a mescolare gruppi di età, provenienze etnica e razziale diversi, ed amplifica le problematiche di adattamento dei detenuti stranieri, i quali, nello sforzo di mantenere uno stile di vita consono ai propri costumi ed alle proprie tradizioni, possono provocare la diffusa sensazione tra i detenuti di sentirsi contaminati dal contatto con compagni indesiderati; paradossalmente, non sarebbe neanche corretto promuovere la tutela delle minoranze etniche attraverso la concentrazione di esse in determinate celle o sezioni, poiché in tal modo si rischierebbe di segregarli ulteriormente.
Alle precedenti condizioni si aggiunga infine l'aumento, negli ultimi anni, della percentuale di detenuti tossicodipendenti o sieropositivi.
La loro condizione non è senz'altro tra le più facili, soprattutto se al problema della dipendenza si accompagna quello della sieropositività.
Il tossicodipendente e/o sieropositivo è emarginato e disprezzato dal resto della popolazione carceraria, a causa di un motivo culturale e di uno funzionale[7]; la sieropositività, infatti, è vista come punizione per il comportamento riprovevole che si è assunto: dunque il soggetto non è meritevole della solidarietà e della comprensione per il suo drammatico stato di salute
Il detenuto che arriva in carcere in condizioni di tossicodipendenza, a sua volta, non si percepisce alla stregua degli altri detenuti, in quanto giustifica i suoi reati come funzionali al reperimento della droga e non come scelta di devianza.
Detenuti ed agenti sono inoltre accomunati dalla seconda ragione, quella funzionale, per cui i soggetti sieropositivi vengono emarginati: la paura del contagio. Frequentemente i soggetti sieropositivi, infatti, esprimono disagio e richieste tagliandosi, o comunque facendo uso del proprio sangue. Il sangue infetto diventa così un'arma capace anche di capovolgere i rapporti gerarchici tra agente e detenuto.
Tuttavia l'emarginazione è perpetrata anche dall'ignoranza sui modi di trasmissione dell'AIDS: infatti, temendo qualsiasi tipo di contatto, i detenuti che vengono a sapere che il nuovo arrivato in cella è un tossicodipendente o un sieropositivo, frequentemente chiedono di essere spostati. Si tende quindi a mettere insieme i soggetti sieropositivi, sia per evitare continui spostamenti che per impedire una coabitazione forzata che potrebbe provocare dei disordini nella sezione.
Tutte queste condizioni strutturali, demografiche, giuridiche, presenti in percentuali diverse ma comuni a tutti gli Istituti carcerari italiani, sono alla base delle dinamiche psicologiche che si instaurano in un luogo che favorisce il degrado, la categorizzazione e la stigmatizzazione sociale di chi ne viene a contatto; per capirne adeguatamente gli aspetti più reconditi, bisogna analizzare le problematiche psicologiche che ne derivano, partendo innanzitutto dallo stravolgimento che essi hanno sulle emozioni e sulla loro percezione nel detenuto stesso.
Lo studio delle emozioni definisce le emozioni come risposte ad eventi caratterizzate da tre componenti di base:
Un'esperienza soggettiva con una qualità edonica di diversa intensità (piacevole-spiacevole), che implica un vissuto o un feeling;
Degli effetti percepibili di reazioni fisiologiche, soprattutto del sistema nervoso autonomo;
Dei comportamenti strumentali o adattivi, espressione della mimica facciale e di atteggiamenti posturali, nonché della predisposizione e della prontezza dell'organismo ad agire in forma appropriata[8].
Su questa definizione pre-teorica, legata alla psicologia del senso comune, la psicologia scientifica ha provato a costruire il suo oggetto.
L'emozione è stata così definita una risposta complessa, esperenziale, motoria, corporea e fisiologica, considerata a prescindere dai suoi effetti sull'esperienza.
Nello studio dettagliato si suddividono le emozioni in primarie o semplici e complesse, tra cui le primarie sarebbero le componenti di base.
Sono identificate come primarie quelle emozioni la cui espressione, particolarmente mediante la mimica facciale, è universale e spontanea, quindi innata; esse sono: felicità, sorpresa, paura, tristezza, collera, disgusto, interesse e disprezzo[9].
Tra le emozioni secondarie, nonostante le difficoltà legate all'identificazione di un criterio stabilito e valido per tutti, si riconoscono generalmente: imbarazzo, vergogna, senso di colpa e orgoglio, ovvero tutte quelle emozioni che richiedono sia la coscienza e la conoscenza di sé, che il riferimento all'altro, reale o virtuale, esterno o interiorizzato.
Le emozioni sono dunque delle sindromi reattive multidimensionali distinte, interagenti ed inseparabili; esse si strutturano a partire da componenti che concorrono a formare una risposta emotiva; nello specifico sono:
Risposte fisiologiche: attivazione dei sistemi nervoso autonomo, endocrino ed immunitario che producono risposte fisiologiche caratteristiche (alterazioni della frequenza cardiaca e respiratoria, della pressione sanguigna, della conduttività elettrica della pelle, etc);
Risposte motorie-strumentali: mordere, colpire, scappare, etc, che possono rappresentare sia uno stato di prontezza ad attuarle, che una tendenza ad un livello puramente mentale,
Risposte tonico-posturali: tensione o rilassamento del corpo nel suo complesso;
Risposte motorie espressive: mimica facciale, gesti, vocalizzi come gridi, sospiri, indici paralinguistici, etc,
Risposte linguistiche espressive: varianti stilistiche e sintattiche del discorso della persona in preda ad emozione;
Componente esperenziale soggettiva: cioè il vissuto o tono fenomenologico, determinato dalla percezione dello stato interno, che fa riferimento alla qualità edonica, all'intenzionalità, alla focalizzazione attentiva ed alla coscienza del soggetto[10], e che richiama, oltre a quanto ha vissuto nel presente, anche riferimenti del passato, che hanno concorso alla determinazione delle sue credenze.
Le diverse reazioni emozionali contribuiscono ad esercitare le diverse funzioni delle emozioni.
Una prima funzione è quella di azione; con essa si intende sia l'azione vera e propria, la preparazione dell'organismo all'emergenza, la prontezza ad agire e la preparazione ad agire; le emozioni sono dunque azioni automotivate.
Le emozioni hanno ancora la funzione di segnalazione intersoggettiva, cioè hanno l'effetto di comunicare all'esterno lo stato dell'organismo.
Infine la dimensione esperenziale assolve la funzione di segnalazione intrasoggettiva ed informa l'organismo in maniera globale ed immediata del suo stato rispetto ai suoi bisogni, desideri, scopi, aspettative.
Le emozioni dunque sono anche un linguaggio, poiché esercitano una duplice funzione informativa, e questa, a sua volta, comporta una funzione rappresentativa.
Va ricordato, infine, come le emozioni abbiano anche la funzione di motivazione ad agire attraverso la dimensione di esperienza: non si attuano dati comportamenti per sfuggire ad un pericolo soltanto come parte della risposta di paura; la sensazione penosa di paura dà la spinta per escogitare comportamenti che allontanino o prevengano il pericolo[11], ed essi risultano talmente immediati da non avere il tempo per pensare alla correttezza o meno dell'azione che si sta per compiere; la cosa importante è che quello specifico comportamento sia funzionale allo scopo per cui è stato messo in atto.
Da ciò si capisce come le emozioni, in situazioni specifiche, proprio perché hanno come fine ultimo la sopravvivenza, possano risultare disadattive per chi le mette in atto. Studi effettuati da Darwin hanno dimostrato che, salendo per la scala zoologica, aumenta la quantità di comportamenti non costituiti da schemi fissi d'azione ed aumenta il repertorio emozionale.
Quando un soggetto risponde emotivamente ad una situazione particolare, che implica mettere in atto dei comportamenti nuovi, l'emozione dominante può esprimersi in paura ed in giudizio di pericolo; ciò può determinare la messa in atto di comportamenti che allontanino quel senso di paura indipendentemente dal fatto che essi possano risultare fortemente disadattivi, poiché rappresentano l'unico modo per gestire la situazione, dunque per sopravvivere.
L'applicazione di queste dinamiche è riconducibile anche al comportamento dei detenuti; alcune ricerche, infatti, hanno indagato il perché i soggetti devianti mettano in atto delle risposte affettive anormali; in specifico lo studio di Patrick del 1994, che ha rivisto tutta la letteratura sull'argomento presente fino a quel momento, ha dimostrato come il reo abbia un deficit nella risposta di paura in seguito ad un fallimento nei segnali legati alle prime azioni di difesa, e risponda attivando in maniera estrema ed anticipata il sistema di prevenzione dal pericolo poiché non ha imparato ad aspettare il potenziamento del riflesso allarmante che normalmente si produce conseguentemente all'emozione di spavento[12]. Il soggetto deviante dunque mette subito in atto dei comportamenti di difesa personale, che possono rappresentare una variante estrema del temperamento normale, proprio perché ha imparato che aspettare potrebbe significare un pericolo eccessivamente alto per la propria incolumità.
La tendenza ad attuare risposte emotive estreme è quanto accade in carcere, in cui l'obbligo di stare tra quattro mura non attiva solo il desiderio di libertà come effetto primario della deprivazione, ma molte emozioni connesse ad essa, che a volte diventano morbose come una malattia.
La reclusione comporta un'inevitabile sensazione di spavento, paura e pericolo per sé, con una conseguente valutazione cognitiva della situazione, che mette in atto delle difese fisiologiche, espressive, linguistiche ed esperenziali; proprio per non soccombere e non perdere la propria identità, il reo abbandona determinati valori precedenti all'internamento, espressione del disprezzo per la società che lo ha rinchiuso in una gabbia di ferro, per adattarsi al nuovo contesto di carcerazione. Ciò avviene nonostante si sia consapevoli del fatto che il carcere implichi la perdita della conoscenza di sensazioni, emozioni, sentimenti importanti che fino a quel momento avevano accompagnato la vita di quel soggetto, poiché quel "bozzolo" che è il carcere porta a sviluppare deprivazione sociale, sensoriale ed umanitaria in genere.
"Il carcere riesce a strapparti persino la dignità, si vive come degli zombie al comando della volontà altrui, che non sono rieducatori come dovrebbero essere, bensì cercano in tutti i modi di sopprimere l'essere che esiste in ogni persona umana, quindi non si può più dire sono in carcere, perché carcere per l'Ordinamento Penitenziario significa ben altro. Si dovrebbe dire sono in un contesto strappa-anima.
Io penso che finché il carcere sarà quello che è, mai si riuscirà ad ottenere risultati positivi per le persone che ci si ritrovano.
Siamo come animali in cattività, rinchiusi lontani dal mondo perché come dei felini siamo pericolosi, e mentre per i felini è l'istinto animalesco che li rende tali, per noi non si capisce bene che cosa è che ci porta a fare certe cose .
Sono le parole di Fabio Pellegrino, un detenuto che ha pubblicato questa riflessione nella rivista "Il filo di Arianna" e che riassume benissimo l'insieme delle frustrazioni, delle privazioni e dei disagi che accomunano i detenuti del vigente Ordinamento penitenziario e che si discuteranno più dettagliatamente nei prossimi paragrafi.
Sebbene lo Stato Italiano abbia promulgato una visione preventivo-riabilitativa riguardo l'applicazione delle misure punitive carcerarie, di cui la massima espressione è la non approvazione della pena di morte per chi commette reati efferati, in realtà la detenzione si presenta essenzialmente come privazione, segregazione e stigmatizzazione. Il carcere, nonostante i suoi buoni propositi, è di fatto un'Istituzione totale ed assolve principalmente due funzioni: la deterrenza e la neutralizzazione dell'individuo.
La nozione di Istituzione totale più conosciuta è quella proposta dal sociologo Erving Goffman, il quale si riferisce nello specifico agli ospedali psichiatrici e alla loro interazione con i degenti.
Si intende in tal senso un "sistema chiuso, soggetto ad un potere inglobante, in cui vi sia impedimento allo scambio sociale e all'uscita verso il mondo esterno: il suo carattere inglobante è continuo, permanente, non poroso, soggetto ad un potere" .
Questa definizione è perfettamente in linea con quanto si verifica nel sistema carcerario, ed esprime la caratteristica principale di tutte le Istituzioni totali, ovvero la rottura delle barriere che abitualmente separano le tre sfere principali della vita di ogni individuo: la famiglia, il lavoro e il divertimento; all'interno del carcere tutte le espressioni della vita si svolgono nello stesso luogo, calcolate nel tempo, sotto il controllo della stessa autorità e in mezzo agli altri detenuti, i quali sono trattati tutti allo stesso modo[15]: la privacy e l'autonomia vengono così soppresse.
Si può dedurre da ciò che la pena detentiva sia molto spesso oggettivamente contraria al senso di umanità, poiché si svolge in luoghi e condizioni incivili che non promuovono il reinserimento ed una maggiore responsabilità sociale da parte del condannato, ma producono invece disperazione crescente, sofferenza ed emarginazione.
La detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli individui che ne vengono coinvolti. Al detenuto non è dato decidere con chi coltivare rapporti e gli affetti rimangono drammaticamente fuori da ogni possibilità di scelta. La solitudine, la lontananza, l'impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari sono spesso l'origine di un crollo psicofisico, con la conseguenza di un'inevitabile frantumazione dei progetti di vita del soggetto. L'individuo è costretto ad abbandonare tutti quegli elementi che costituiscono le sue certezze, per questo il carcere può rappresentare una seria minaccia per il suo sistema difensivo, per la sua autostima ed il suo senso di sicurezza, una minaccia che nel tempo si concretizza in una progressiva disorganizzazione della sua personalità[16].
Totalmente amministrata dal carcere, in modo autoritario e pianificato, in tempi e spazi limitati, scandendo un ritmo impersonale, la vita dell'individuo rischia ciò che Clemmer definiva la "depersonalizzazione progressiva": un processo di identificazione con il carcere, in cui viene ridotto il mondo del detenuto, le sue caratteristiche fisiche e psicologiche, i suoi valori, le sue credenze, la sua volontà ed i suoi desideri[17].
Il detenuto appare fortemente limitato nella gestione della propria immagine e di quella altrui, impotente nella manipolazione dell'ambiente a proprio vantaggio poiché consapevole di rivestire un ruolo "obbligato" e stabilito da altri, a cui attenersi scrupolosamente per potere ottenere quella libertà e quel legame con l'esterno che le Leggi attuali consentono.
L'agire esclusivo nel contesto carcerario e la mancanza di contatti con l'esterno, portano poi l'individuo a manifestare prevalentemente aspetti emotivi connessi con la condizione detentiva.
Quando un uomo viene istituzionalizzato, infatti, non solo viene privato della propria libertà e delle proprie esperienze relazionali, ma viene anche passivizzato: non può disporre liberamente dei propri beni personali oltre che di sé stesso, viene continuamente sorvegliato e privato di ogni sua autonomia. Inizia la spersonalizzazione: varcato il portone di ingresso del carcere, l'uomo non è più individuo, ma cosa. Secondo la teoria di Goffman, i reclusi sono infatti sottoposti ad un processo di spoliazione del sé a seguito della separazione dal loro ambiente originario e da ogni altro elemento costitutivo della loro identità. Ciò avviene "attraverso successive riduzioni del sé": dall'iniziale barriera che li separa dal mondo, si passa alla cosiddetta morte civile, tramite la perdita dei diritti sul denaro, l'impossibilità a votare, e altri meccanismi che fanno cessare di essere un cittadino comune. Inoltre le successive umiliazioni e profanazioni del sé, le punizioni e la vita di gruppo obbligata, contribuiscono a creare ansia per la propria sicurezza.
Iniziano così alcuni cambiamenti nella cosiddetta carriera morale del detenuto, determinata dal progressivo mutare del tipo di credenze che l'individuo ha su di sé e su coloro che gli sono vicini[18].
Questo processo di adattamento forzato alle condizioni carcerarie è stato definito da Donald Clemmer "processo di prigionizzazione"[19]. L'autore, all'interno del carcere di massima sicurezza dell'Illinois del sud, studiò le relazioni tra i detenuti e la loro organizzazione sociale e riscontrò un "processo di progressiva assunzione da parte del ristretto dei valori, dei principi e della cultura, oltre che degli atteggiamenti e delle abitudini tipiche del clima carcerario". Con il termine intese dunque l'effetto globale dell'esperienza carceraria sull'individuo, indicato dall'assuefazione allo stile di vita detentivo; quasi un percorso di adattamento progressivo alla comunità carceraria culminante nell'identificazione più o meno completa con l'ambiente, con i suoi usi e costumi, con le sue singolari abitudini, con la sua cultura, con il suo codice d'onore, con i suoi esempi da imitare.
Alcune dinamiche sono il risultato di una lenta assimilazione, da parte dei detenuti, dei ritmi e delle esigenze di ordine, di controllo e di sicurezza imposte dal sistema penitenziario, il quale incentiva un'uniformità di comportamento e di identità che è accettato inconsapevolmente dalla quasi totalità dei reclusi: l'assunzione di un ruolo inferiore, l'adozione di alcuni nuovi modi di mangiare, vestire, lavorare, dormire, l'adozione del linguaggio locale e il riconoscimento che niente è dovuto all'ambiente per la soddisfazione dei bisogni, sono aspetti della prigionizzazione che possono essere riscontrati in tutti i detenuti. Vi è così una fagocitosi da parte dell'Istituzione e i bisogni e desideri personali sono annullati, sostituiti da altri eteroindotti e più coerenti con le finalità dell'Istituzione.
È vero però che non tutti i detenuti rispondono allo stesso identico modo: il grado di prigionizzazione è infatti funzione della sensibilità del recluso alla cultura di provenienza, del tipo di relazioni intraprese prima dell'incarcerazione, dei suoi trascorsi di vita, della sua personalità e della durata di esposizione alla cultura carceraria.
Il reo può dunque diventare prigionizzato per diversi aspetti, ma la maggior parte di essi subisce questa situazione, in pochi cercano di opporsi all'ambiente.
Nel sistema penitenziario si verifica così un paradosso: tale Istituzione avrebbe il compito di insegnare al detenuto il modo di vivere e di comportarsi nel mondo libero, ma nello stesso tempo lo obbliga a vivere in un modo che di quel mondo è l'antitesi. Alcuni studi hanno infatti evidenziato ulteriori effetti dell'ambiente carcerario sull'individuo, quali la perdita dei valori che il soggetto aveva prima dell'internamento - fenomeno che viene anche chiamato dis-cultura, ovvero "incapacità momentanea o definitiva di gestire situazioni tipiche della vita quotidiana[20]" - e l'estraniamento, cioè l'incapacità di adattarsi al nuovo contesto dopo la scarcerazione.
Per riuscire a sopravvivere ad un ambiente che scarnifica fino all'osso e destruttura quanto è stato creato in precedenza da un Io che risulta già di per sé fragile, il detenuto tende a mettere in atto dei comportamenti che proteggano dalle innumerevoli situazioni di sofferenza create dal carcere: la privazione della libertà personale, di beni e servizi usuali, delle relazioni eterosessuali, dell'autonomia e della sicurezza nei confronti degli altri detenuti. Ciò favorisce l'adozione di meccanismi di difesa contro il sistema: avere una cultura comune protegge dalle pressioni dell'ambiente.
A questo proposito si ricorda il teorema di William Thomas che enuncia: "L'individuo agisce in funzione dell'ambiente che percepisce e della situazione alla quale deve far fronte. Egli può definire ogni situazione della vita sociale attraverso la mediazione dei suoi atteggiamenti preliminari che l'informano su questo ambiente e gli permettono di interpretarlo". Alla considerazione si aggiunge anche la Field Theory di Kurt Lewin, secondo cui "il comportamento (C) è funzione della persona (P) e dell'ambiente (A), ovvero C = f(P A)[21]".
Per reclamare una propria autonomia ed individualità, nonché per sfuggire ad un'azione deresponsabilizzante e spersonalizzante che frustra ogni iniziativa personale, l'unica alternativa possibile messa in atto dal detenuto è quella di aderire ad una sottocultura carceraria, cioè una subcultura che porta ogni individuo a divenire un membro caratteristico della comunità penale.
Essa racchiude un patrimonio di conoscenze, usanze, codici non scritti, strategie che nascono dalle esigenze iniziali della "mala" di rispettare, anche dentro una Istituzione punitivo-preventiva come quella carceraria, delle gerarchie esistenti al di fuori della stessa.
Con questa sottocultura non si confrontano solo i detenuti, ma anche tutti gli altri soggetti che con il carcere, per ragioni diverse, condividono una parte della loro vita: polizia penitenziaria, operatori, sanitari, volontari.
Per aderire a tale sottocultura è necessario abbandonare i codici comunicativi convenzionali ed abbracciare una comunicazione di tipo simbolico con cui, all'interno di rapporti orizzontali obbligati, si possa salvaguardare la propria identità personale e guadagnare il proprio rispetto. Si comincia dunque una lenta ricostruzione del Sé[22].
E' dentro questa ottica che possono essere compresi gesti, sguardi, silenzi, movimenti e posture del corpo, abiti, oggetti come collane, anelli, cappelli, tatuaggi, vocalizzazioni e comportamenti.
In una intervista, pubblicata dalla rivista "Ristretti Orizzonti" di Padova, un detenuto afferma i quattro principi cardine necessari per essere giudicato un "bravo ragazzo" ed essere accettato dalla comunità carceraria per confrontarsi con questa. Essi sono:
Non essere un infame, ovvero non avere fatto entrare nessuno in carcere in seguito alle proprie dichiarazioni;
Non comportarsi in modo tale da mettere a rischio gli altri detenuti;
Dare sempre una mano a chi ha bisogno;
Non avere mai commesso reati come atti di pedofilia, stupri e roba del genere.
La trasgressione delle regole comporta l'intervento degli "azionisti", ovvero di quelle persone addette ad occuparsi di risolvere il problema con la violenza e la repressione del trasgressore [23].
Tale forma di "giustizia fai da te" può essere compresa considerando che in carcere c'è gente che vi ha trascorso o vi trascorre tutta la vita, per cui tale sistema ha significato all'interno di un mondo con dei bisogni che creano una sovrastruttura che può definirsi cultura a pieno titolo. Inoltre la realtà carceraria vive un isolamento sociale così forte che la creazione di una personale subcultura è quasi inevitabile.
Il carcere è infatti una sindrome, in cui si verificano la privazione della libertà, l'isolamento in ambienti molto ristretti e con limitazioni di ogni genere, il rischio di esclusione sociale e la mancanza del rispetto dei diritti di cittadinanza ed integrazione lavorativa. Ed in questo contesto ogni detenuto ha bisogno di sentire di appartenere a qualcosa, per non far soccombere la propria integrità personale.
Con la Legge Gozzini ed attraverso l'introduzione dei benefici e delle offerte trattamentali si è riusciti ad ottenere un accantonamento della "giustizia azionista", per cui ogni detenuto tende ad aderire a delle regole formali e a non usare violenza contro altri per beneficiare della "buona condotta" necessaria per richiedere le misure alternative, ma questo è ben lontano dal processo di rieducazione promulgato dalla Legge per impedire la messa in atto di recidive e consentire la risocializzazione del reo e non implica nemmeno che la sottocultura carceraria non esista e che non sia un processo fortemente devastante per chi la vive .
Nell'impossibilità di una reale sottrazione a questa realtà mortificante, il detenuto crea così mondi di senso, universi di segni in cui proteggersi e tentare una riunificazione delle parti dissociate intorno ad una nuova identità. Questi altrove sono costruiti dai detenuti anche attingendo dai simboli pre-detentivi, e spesso coincidono con la cultura delinquenziale di provenienza; il codice carcerario in questo caso ne mutua simboli e comportamenti.
In un ambiente fortemente ostile, in cui risulta necessario mettere in campo ogni genere di comportamento e risorsa per sopravvivere come uomo, è fondamentale sviluppare i provvedimenti terapeutico-riabilitativi che l'Ordinamento prevede. L'isolamento e la solitudine possono essere contrastati da un trattamento individualizzato sui bisogni del singolo e dal mantenimento di relazioni interpersonali esterne all'Istituzione, che possono riportare in vita i propri legami sociali ed il proprio passato; esse rappresentano un fortissimo strumento di resistenza contro tutto quello che il processo di prigionizzazione comporta.
Da quanto detto finora si può considerare come la pena si caratterizzi essenzialmente come privazione; essa contiene in sé la sospensione dei rapporti umani e delle relazioni personali. Il soggetto che oltrepassa il portone di un carcere perde la sua dimensione di uomo, la sua identità sociale e la sua dignità; la sua volontà viene chiusa a chiave come il suo corpo ed i suoi desideri[24]. Ovviamente questi cambiamenti investono anche la sfera sessuale, che subisce pesanti contraccolpi.
La privazione delle relazioni eterosessuali ostacola il processo di definizione della propria identità: in un individuo quest'ultima è infatti anche il riflesso dell'immagine di sé che gli altri gli rimandano. Il detenuto, "privato della polarità femminile, è costretto a cercare la propria identità solo dentro sé stesso, in quanto metà della sua audience gli è negata: l'immagine che lo stesso si fa rischia così di diventare completa solo per metà, dimezzata, una monocromia senza i colori della realtà. L'identità specchio del carcerato è in breve soltanto quella porzione della sua personalità che è riconosciuta e apprezzata dagli uomini, e questa identità parziale è resa confusa dalla mancanza di contrasto"[25]. Ad essere mancante, in una società monosessuale come quella del carcere, è dunque la polarità femminile e ciò lo priva della percezione del suo essere, in quanto maschio.
Nell'ambiente carcerario il desiderio verso quanto è negato, dunque anche di avere delle relazioni eterosessuali, è molto forte; ciò porta ad una espressione di emozioni capaci di spingere all'azione per placare tali bisogni; la sessualità inibita erotizza così tutta la vita del recluso e ne accentua gli aspetti. Clemmer[26] per primo analizzò l'adattamento sessuale all'interno delle carceri e ne individuò tre tipi:
Normale: il più diffuso, tipico dei detenuti condannati a pene brevi e che hanno una compagna all'esterno del carcere. Essi ricorrono alla masturbazione occasionalmente giustificando il loro comportamento su basi biologiche e le loro fantasie sono sempre rivolte al mondo femminile.
Quasi normale: tipico dei detenuti più anziani o di quelli più giovani, anagraficamente parlando, in quanto essi non hanno relazioni significative all'esterno del carcere. La masturbazione non fornisce più l'appagamento delle proprie soddisfazioni, in quanto il ricordo della donna si affievolisce con il procedere della detenzione. I reclusi reagiscono allo stato di continenza coatta creandosi nuovi mondi virtuali nei quali vivere e ritrovarsi e la sessualità non è esente da questo processo di elaborazione. La loro attenzione, sessuale o meno, sarà rivolta, pertanto, per intero alla comunità carceraria: il rapporto omosessuale sarà dunque vissuto da questi soggetti come un palliativo, come dimostra il fatto che le fantasie messe in atto sono rivolte alle donne.
Anormale: è la pratica omosessuale vissuta con consapevolezza. Il detenuto è sempre più vincolato a qualcosa di visivo e tangibile per eccitarsi e si trova a poter desiderare un rapporto omosessuale. Questo adattamento è messo in atto da pochi e comunque molti di essi lo apprendono proprio in carcere. A causa della promiscuità, del linguaggio scurrile ed osceno, delle narrazioni spesso fantastiche tra detenuti riferite alla vita sessuale pre-dentiva, i freni inibitori e i principi morali possono allentarsi e lasciare il posto ad un istinto incontrollato: la maggior parte dei detenuti, infatti, prima della carcerazione manifestava un comportamento sessuale cosiddetto normale.
I problemi psicologici derivanti dalla negazione della sessualità e dell'affettività in carcere sono stati affrontati in alcuni studi di medicina penitenziaria; alcuni medici hanno sostenuto che il processo di adattamento al carcere può provocare disfunzioni nel complesso dei meccanismi biologici che regolano le emozioni, generando sindromi morbose di varia intensità che appartengono alla già citata "sindrome da prigionizzazione". In specifico nello studio intitolato "Les rèactions psychopathologiques de captivitè", pubblicato da Carot, Peraire, Carlinga e Bacche, si sosteneva che la mancanza di privacy cui sono sottoposti i detenuti, costretti in situazioni di continua e forzata promiscuità, unita all'ansietà causata dalla separazione dalla famiglia, potessero rivelarsi agenti fortemente patogeni e tendessero a sviluppare un atteggiamento patologico di sospetto e senso di persecuzione[27].
Permettere ai ristretti di vivere i propri affetti, aprire le carceri alla sessualità è un tentativo concreto di umanizzare la detenzione ed è un segnale importante di prospettiva per i detenuti e per i loro familiari. Interrompere il flusso dei rapporti umani ad un singolo individuo significa separarlo dalla sua stessa storia personale, significa amputarlo di quelle dimensioni sociali che lo hanno generato, nutrito e sostenuto. Il carcere demolisce, anno dopo anno, quella che si potrebbe definire l'identità sociale del detenuto[28].
Tra le innumerevoli emozioni che giocano un ruolo fondamentale nell'espressione della prigionizzazione e dei processi che essa comporta, vi sono sicuramente la collera, il disgusto ed il disprezzo alla base dell'aggressività e della violenza che dominano in carcere.
L'aggressività è considerata un tratto positivo della mascolinità ed espressione del machismo del soggetto; essa diviene il mezzo di comunicazione con cui il detenuto approccia con l'ambiente che lo circonda. Tra le cause scatenanti di questo comportamento si può pensare alle continue frustrazioni a cui il detenuto va incontro e che producono un senso di insofferenza e di frustrazione che, accumulate, esplodono in aggressività.
Tale linguaggio si manifesta innanzitutto contro una società da cui si è stati allontanati bruscamente ed in maniera assoluta, per difendersi dalla sofferenza che la lontananza comporta; in secondo luogo con le autorità penitenziarie; agenti, operatori, educatori, che tengono in una condizione di privazione dalla libertà e che rappresentano anche la società che si disprezza perché allontanati traumaticamente da essa; ciò si estrinseca attraverso una sfida continua con gli agenti o con i professionisti interni al carcere, o attraverso un rifiuto di ogni contatto con l'Istituzione penitenziaria. La prigione è percepita dagli stessi detenuti come una fabbrica di animali, "il luogo dove alligna e cresce il mito dell'uomo forte e violento, del prevaricatore, nel quale a volte "per avere rispetto ti devi comportare come un animale: "pochi mesi di carcere e impari a essere un duro", afferma un detenuto, "uno che se ne frega di tutto e di tutti" .
In realtà spesso questa ostentazione di forza è solo una corazza per sopravvivere. L'alone di impenetrabilità e di inavvicinabilità che circonda alcuni detenuti, serve a nascondere in realtà un'insicurezza di fondo, e può dissolversi una volta che la nuova situazione stressante smette di esercitare la sua pressione.
Può succedere, infatti, che interventi concreti di espressione dei propri sentimenti, attraverso gruppi-terapia, o anche semplicemente con attività ricreative che consentano di esprimere i propri sentimenti, la propria rabbia ed aggressività, sviluppino una maggiore consapevolezza dei propri vissuti ed inducano a ripiegare taluni comportamenti. Tuttavia queste sono sporadiche manifestazioni, in quanto dalle relazioni sia con gli agenti che con i propri compagni, è comunque generalmente bandita ogni manifestazione di fragilità, per senso di dignità ma anche per un latente senso di colpa che impedisce di auto-commiserarsi.
La tenacia nel mantenere la propria dignità in carcere può dunque sfociare in aggressività, la quale può a sua volta degenerare in violenza. Molti detenuti, infatti, rifiutano cure farmacologiche o psichiatriche, ma anche una semplice parola di conforto, in quanto devono dimostrare ai compagni di detenzione di sapersi fare la galera: essi cercano in tutti i modi di nascondere la propria sofferenza, finché il dolore esplode.
A questo proposito è particolarmente indicato citare la teoria della frustrazione/aggressività di Dollard: una delle cause dell'aggressività può essere rintracciata nell'impossibilità a raggiungere degli scopi. Tale relazione è il frutto di un meccanismo emotivo, detto spostamento, e di uno comportamentale, la ridirezione, per cui l'iniziale rabbia viene indirizzata verso target più sicuri: questi possono essere soggetti più deboli o la propria persona.
Questa carica di energia distruttiva accumulata viene così scaricata da qualche parte: su se stesso, con l'autolesionismo ed il suicidio, ma anche sugli altri, con il sopruso e l'intimidazione; un esempio ne sono le "squadre punitive di altri detenuti . regolano conti in sospeso servendosi dei coperchi delle scatole di tonno . Di questa violenza non ci si scandalizza mai abbastanza. Essa, multiforme, della quale sono vittime e protagonisti i detenuti, in ogni attimo e in ogni angolo, raramente si manifesta in modo esplicito, ma passa attraverso gli sguardi, le parole dette e quelle taciute, le malignità che condizionano la vita in carcere. Del resto, ogni detenuto è costantemente oggetto di violenza già da parte dell'Istituzione, attraverso la miriade di piccole e grandi ingiustizie che subisce, tra ritardi, rifiuti e incomprensioni, e anche botte, le quali passano", come afferma un detenuto, "ma rimangono dentro"[30].
Sono queste le condizioni che determinano uno stato di disagio psicologico nel detenuto e che si risolve in aggressività auto ed etero diretta, di cui la cui massima espressione è l'autolesionismo.
L'impossibilità e l'incapacità ad esprimere delle condizioni disagevoli molto forti sviluppa un silenzio pericoloso, di cui si può veramente morire. Senza scendere nei dettagli e considerare l'enorme aumento negli ultimi anni dei decessi nelle carceri, per violenza o per atti suicidari, basti semplicemente pensare che il nuovo Ordinamento penitenziario ha dovuto provvedere all'istituzione di "celle a rischio", ovvero di celle adibite appositamente per ospitare persone detenute che non mostrano di essere idonee al vivere collettivo del carcere, che stanno male o che si ritiene potrebbero tentare, o ritentare, il suicidio.
La particolarità di queste celle è che sono completamente svuotate da tutto ciò che non è ben saldato al muro, per evitare che il soggetto rinchiuso faccia gesti che potrebbero danneggiare la sua persona. Ciò comporta di conseguenza anche il divieto di tenere con sé oggetti di uso quotidiano e che lo rendono completamente dipendente dagli agenti addetti alla sorveglianza. Tali celle, dette anche "celle lisce"[31], lisce perché prive di tutto, causano un fortissimo disagio che si somma a tutti i processi già menzionati nonché alle eventuali problematiche che possono essere presenti in precedenza nel soggetto.
Un ambiente notevolmente frustrante e degradante, costruito per rimediare ai danni di quello dell'Ordinamento vigente, non solo scarnifica la persona detenuta e va oltre i principi che l'Ordinamento prevede, ma va anche contro i provvedimenti successivi all'attuale Regolamento, tra cui il "Servizio Nuovi Giunti", che rappresenta un'ennesima sconfitta e che non riesce a prevenire quel disagio esistenziale che può esasperarsi in carcere, e per cui esso stesso è stato istituito.
Sebbene la Legge Gozzini abbia bloccato lo stato di violenza che si esprimeva con omicidi, rivolte, accoltellamenti, agguati, aggressioni, grazie all'introduzione dei benefici sulla base del comportamento, essa non è comunque riuscita a raggiungere il suo scopo, ovvero quello di rendere operativi quegli strumenti umani ed umanizzanti garantiti dalla legge; gli ospiti delle patrie galere, cittadini di serie B anzi non-cittadini, rimangono così in balia d'un potere dispotico e assoluto, sottratto alla livella del diritto.
Sperimentare le sensazioni e le emozioni che sono state descritte nei precedenti paragrafi determina inevitabilmente degli stati di disagio psicologico molto forti, che divengono ancora più pronunciati se si considera che esse permangono in maniera continuativa per tutto l'arco della detenzione.
Ciò determina la strutturazione di processi cronici che vanno ad incidere fortemente anche sulla personalità del reo, la quale già di per sé non si compone di caratteristiche evolutive molto elevate.
Lo studio di Patrick[32], già citato, ha infatti dimostrato come i soggetti devianti non abbiano una buona base percettiva a livello emotivo, la quale risulta con una soglia di attivazione più bassa, per cui le esperienze vengono percepite drammaticamente e si tende a rispondere ad esse in modo amplificato. Ciò dipende anche dal fatto che tra il cervello e l'ambiente vi è una continua interazione, per cui si può considerare come tali soggetti abbiano vissuto delle esperienze che hanno modificato significativamente la soglia di percezione del pericolo e l'attivazione di risposte difensive.
Inoltre, tali esperienze possono aver determinato delle vere e proprie manifestazioni psicopatologiche, che hanno un effetto diretto sulla personalità del soggetto.
La personalità può essere definita il complesso delle qualità proprie di un uomo, che ne fanno un individuo distinto dagli altri. È la sintesi del modo di essere di un soggetto. Nella personalità confluiscono tutti gli aspetti fisici e psichici, quindi l'insieme di fattori biologici, somatici e psicologici. L'importanza biologica è dimostrata dalle gravi modificazioni di personalità che possono essere provocate da alterazioni della morfologia o della funzionalità degli apparati.
Accanto ai fattori biologici, un ruolo fondamentale hanno quelli psicologici, tra cui si riconoscono processi conoscitivi o intellettivi, affettivi, conativi o volitivi.
La personalità, da un punto di vista psichiatrico, può essere definita come la totalità dei tratti emozionali e comportamentali che caratterizzano la persona nella vita quotidiana e in situazioni ordinarie; come tale è relativamente stabile e prevedibile.
Quando i tratti della personalità sono inflessibili e maladattivi e causano una significativa alterazione funzionale oppure un disagio soggettivo, si ha un disturbo di personalità; poiché tali tratti sono molteplici un soggetto potrà presentare dei disturbi in una o più aree, che potranno classificarsi a seconda delle manifestazioni che verranno espresse.
In carcere l'estrinsecazione di turbe psichiche può essere dovuta a due cause principali:
la continuazione o l'evidenziazione di disturbi psichici già prima esistenti
la strutturazione di una risposta patologica ad eventi particolarmente traumatici quali l'imprigionamento, il rimorso per il delitto commesso, la previsione di condanna, la condanna stessa.
Uno studio di Rokach del 2001[33] dimostra come i soggetti carcerati tendano ad essere molto più consapevoli della loro solitudine e della loro malinconia rispetto ad una popolazione generale di riferimento e ciò è legato strettamente alle cause che hanno portato all'imprigionamento. I fattori ambientali-strutturali entro cui si svolge la pena non contribuiscono poi a creare delle condizioni ottimali di scarica di questi sentimenti, che possono così cronicizzarsi ed esprimersi attraverso turbe psichiche.
Sicuramente il primo trauma che un detenuto subisce è rappresentato dall'ingresso in carcere e può estrinsecarsi in una vera e propria sindrome.
La sindrome da ingresso in carcere, consistente in una serie di disturbi non solo psichici, ma spesso psicosomatici, riguardanti diversi organi ed apparati, compare tanto più frequentemente e manifestamente quanto più elevato è il grado di educazione, di sensibilità, di cultura dei soggetti detenuti e può diventare, quindi, tanto più forte quanto maggiore è il divario fra il tenore di vita condotto in libertà e quello fruibile in carcere.
È chiaro, tuttavia, che non si può generalizzare, poiché varie ed articolate sono le modalità di risposta adattiva in relazione a molteplici variabili, legate alla struttura di personalità, allo 'status' di appartenenza, alla reazione personale, familiare e sociale all'avvenimento, alle condizioni ambientali, finanche al tipo di cella e di compagnia.
Inoltre il grado di isolamento a cui si sottopone il soggetto, soprattutto nel primo periodo di reclusione, favorisce un pensiero rimuginativo che viene elaborato in maniera catastrofica e pessimistica, ponendo fortemente l'accento sulla percezione delle cause che hanno determinato l'arresto, e favorendo così ulteriormente la comparsa di sensi di colpa persecutori[34].
Studi condotti in Massachusetts[35] hanno evidenziato una forte tendenza dei soggetti a presentare disturbi psichici connessi con una bassissima qualità di vita espressa con alti punteggi di depressione ed ansia alle scale sintomatologiche presentate, anche se essi non depongono necessariamente per la presenza di vere e proprie psicopatie; si potrebbe pensare dunque che siano piuttosto delle risposte adattive ai fenomeni deprivativi e spersonalizzanti che il carcere apporta .
I disturbi psichici evidenziabili in carcere sono raggruppabili in sei campi che si sovrappongono in larga misura:
psicotico;
parapsicotico;
tossicomanico;
psicosomatico-somatopsichico;
nevrotico;
reattivo[37].
Nel campo reattivo rientrano tutte quelle sindromi patologiche che si sviluppano per il crollo dell'autostima conseguente all'arresto, e che implicano una menomazione nella competenza relazionale e nella capacità di adattamento.
Nel campo nevrotico rientrano i disturbi d'ansia, i disturbi dissociativi, la distimia, la ciclotimia.
Il campo psicosomatico-somatopsichico include:
Pazienti affetti da incarnazioni del disagio precedenti la detenzione;
Soggetti che sono andati incontro a tale organizzazione disturbata dopo il soggiorno in carcere;
Coloro che, in seguito alla scoperta di una grave malattia somatica durante la reclusione, hanno manifestato crisi psicopatologiche acute, passibili di uno sviluppo cronico.
Le forme psicosomatiche più usuali attengono al tratto gastro-enterico (coliche, ulcere etc.) e al sistema cardiocircolatorio (tachiaritmie, ipertensione, angina etc.).
La capacità di intendere è in genere integra, quella di volere risulta compromessa, come dimostrano l'emergere di desideri autosoppressivi e il potenziale autoaggressivo che sostiene il disturbo somatico. In questo campo rientrano, oltre ai disturbi psicosomatici, i disturbi somatoformi, i disturbi fittizi e i fattori psichici che incidono sulla condizione fisica secondo il DSMIV[38].
Una molteplicità di sintomi, che racchiudono quelli già descritti, nonché specifici vissuti soggettivi, sono alla base di quella che viene indicata, sul piano nosografico, come sindrome da prigionizzazione, sindrome che si articola in una vasta gamma di quadri psicopatologici che vanno dalla comune reazione ansioso-depressiva sino alla sindrome ganseriana.
Catanesi[39] sostiene che sul piano clinico la comune reazione d'ansia iniziale, che può colorarsi di spunti fobici e varie espressioni somatiche, lascia il posto nel tempo di 2-3 giorni alla sindrome da prigionizzazione vera e propria o si avvia, per lo più nei casi di recidivi, ad un progressivo adattamento.
Sensazioni angosciose ed opprimenti, a tonalità fobica, vengono riscontrate abitualmente, unite ad un timore che può divenire ben presto paura per la propria incolumità fisica.
Insonnia, inappetenza, incapacità a gestire la propria emotività sono sensazioni comuni e contribuiscono ad indurre nel detenuto una situazione di allarme. È l'ansia in questo momento la spina più dolorosa, come conferma lo studio di Schmitt e Newman del 1999, che smentisce l'ipotesi per cui i soggetti in carcere abbiano bassi punteggi ai test per la rilevazione dell'ansia e non siano fortemente sconvolti dalla loro condizione detentiva[40].
E' verso il trattamento di questa, non solo farmacologicamente, che è necessario agire, poiché è questo il momento in cui più facilmente il soggetto, sentendosi perso, può andare incontro ad improvvisi gesti autolesivi.
A questa fase che può avere durata diversa da caso a caso, ma che generalmente si esaurisce nell'ambito di 2-3 settimane e che può essere definita di 'iperestesia' verso gli stimoli ambientali, può seguirne un'altra caratterizzata da progressivo distacco, indifferenza, ritiro in sé stessi. È la fase, cioè, in cui subentra la depressione, in cui lo scoraggiamento prende il posto della paura. Compaiono allora idee di rovina, un senso di annichilimento, un sentirsi oggetto nelle mani altrui.
La possibilità di fronteggiare tale condizione depressiva è intimamente legata alla personalità di base, che dovrebbe trovare degli spunti per uscirne attraverso il ricorso al trattamento delle figure professionali che operano internamente al carcere, nonché alla rete di relazioni familiari, che possono offrire un incentivo alla sopravvivenza ed al mantenimento di quella speranza necessaria per reagire positivamente ad un universo di processi deterrenti.
Continuando nell'analisi dei disturbi psichici, una peculiare forma reattiva alla carcerazione è la sindrome ganseriana (pseudo-demenza psicogena o stato crepuscolare isterico).
Si tratta di reazioni relativamente rare, basate su di una motivazione inconscia del soggetto ad evitare la responsabilità, sforzandosi di apparire infermo di mente. Tra i sintomi psicopatologici più caratteristici è da annotare il fatto che il soggetto non è capace di rispondere alle domande più semplici che gli vengono rivolte, sebbene attraverso le risposte appare evidente di aver colto il significato della domanda; nelle risposte tradisce una sconcertante mancanza di conoscenze che ha posseduto e che ancora, senza ombra di dubbio, possiede. Egli in sostanza parla fuori tema, contro senso, a vanvera. Trascura la risposta corretta e ne dà un'altra vicina, ma inesatta.
'Il corredo sintomatologico è contraddistinto dal puerilismo che emerge dall'aspetto recitativo o 'bamboleggiante' che questi soggetti assumono'[41].
Nel contesto della sindrome ganseriana si impone la diagnosi differenziale con la simulazione. Il DSMIV e l'ICD10 ritengono che nella simulazione è evidente il tentativo cosciente di produrre sintomi fisici e/o psichici e l'intento di amplificarli o di esagerarli, con il fine di richiamare l'attenzione altrui e di ottenere benefici, mentre nella sindrome di Ganser la componente dell'intenzionalità appare più sfumata e prevale invece una componente isterica dissociativa, con chiari ed accentuati aspetti crepuscolari psicogeni[42].
Rientrano poi tra le patologie psichiche riscontrabili in carcere, forme gravi come le psicosi, le forme del campo tossicomanico e altre meno gravi, ma non per questo meno pericolose.
Si intende con il termine psicosi un insieme di sintomi, che può associarsi a molti disturbi psichiatrici diversi, ma che non rappresenta di per sé un disturbo specifico negli schemi diagnostici quali il DSMVI o l'ICD10, i quali pongono l'individuo in una situazione, temporanea o permanente, di perdita più o meno totale della capacità di comprendere il significato della realtà in cui vive e di mantenere tra sé e quella realtà un rapporto di sintonia sufficiente a salvaguardare un comportamento autonomo e responsabile, dunque un insieme di sintomi in cui le capacità mentali di un soggetto, la sua risposta affettiva, la sua capacità di riconoscere la realtà, di comunicare e di relazionarsi con gli altri sono compromesse[43].
Tra le psicosi si annoverano sintomi quali: disturbi nella percezione (allucinazioni), nel processo ideativo e nel contenuto del pensiero (deliri ed altre idee erronee), nel linguaggio e nell'eloquio, nel Sé, nella volizione, nelle emozioni e nell'affettività.
In base ai fattori eziopatogenetici possiamo suddividere le psicosi in due gruppi: le psicosi organiche (metaboliche, disendocrine, infettive, vascolari, degenerative, neoplastiche, post-traumatiche, genetiche) e le psicosi endogene (o funzionali), includenti le schizofrenie e i disturbi dell'umore.
Ad esse, nell'ambito dell'Istituzione penitenziaria, vanno aggiunte le psicosi carcerarie, con veri e propri squilibri psicotici.
Infine, tra i disturbi psichiatrici riscontrabili in carcere ricordiamo la tossicomania; essa si colloca tra i disturbi d'abuso di sostanze, con cui viene definita l'assunzione di stupefacenti chimici che possono portare a dipendenza, a problemi fisici che mettono in pericolo la vita e ad una moltitudine di problemi psicologici. Si intende con il termine sostanza ogni tipo di composto che va dall'alcool alle droghe "leggere" a quelle riconosciute come più nocive come la cocaina o l'eroina.
Molte ricerche (cfr. fra le altre Kendler e al., 1992) hanno dimostrato come i fattori genetici abbiano un ruolo importante nello sviluppo di quadri di alcolismo e tossicomania e come degli specifici tratti di personalità, come la debolezza dell'Io e la difficoltà a mantenere una buona autostima, concorrano all'estrinsecazione di questi quadri patologici. Inoltre, un considerevole numero di ricerche sostiene l'esistenza di una associazione tra disturbo di personalità, depressione e tossicodipendenza[44].
La tossicodipendenza sarebbe, insomma, un fenomeno sintomatico di un disagio psicopatologico che la sostanza stupefacente serve a coprire. I disagi più frequenti sono di tre tipi: depressione, che per lo più viene compensata con l'eroina, vere e proprie psicosi, ma soprattutto disturbi di tipo borderline'.
Accanto agli psicotici e ai tossicomani, troviamo un'altra categoria di persone. Scrive Catanesi:
"Insidie si nascondono comunque anche in soggetti apparentemente adattati, o per meglio dire, costretti a mostrarsi adattati per non venire meno alle aspettative del gruppo di appartenenza. Questi individui segnalano in maniera tipica al medico penitenziario difficoltà di altro genere, mascherando in tal modo disturbi psicologici che, se esplicitati (e soprattutto se affrontati con terapia farmacologica e psicoterapica specifica) li esporrebbero a severi giudizi da parte del clan di appartenenz"a[45].
Un giudizio di incapacità a 'fare la galera' suona infatti, in particolari contesti, come condanna ancor peggiore della detenzione. Così essi ostentano una forza ed una sicurezza che in realtà non hanno e secondo molti medici psichiatri, anch'essi sono detenuti a rischio perché impossibilitati ad esprimere il dolore e la sofferenza, sino a che la situazione non diviene insostenibile e l'angoscia si manifesta all'improvviso con comportamenti insospettati, con esplosioni auto-eteroaggressive.
Concludendo, non si può non prendere atto di questi aspetti di personalità così importanti, e non si può non riconoscere che un certo grado di sofferenza psichica è implicito ed inevitabile nell'applicazione del regime detentivo, a prescindere dalla qualità delle condizioni di vita che quella determinata Istituzione può offrire.
Anche in un contesto che rispetta fortemente i principi di terapia e riabilitazione che l'Ordinamento prevede, il ristretto è immerso in un ambiente complesso e conflittuale, sotto la pressione di un numero elevato di variabili non controllabili da chi si occupa della sua presa in carico; inoltre i rapporti detenuto-psicologo/psichiatra/educatore soffrono di discontinuità, di frammentarietà d'intervento e spesso di mancanza di coordinamento con le altre figure sanitarie.
Tutto ciò contribuisce all'esplosione di quel disagio psichico che caratterizza l'esperienza carcere e di cui non si tende a parlarne mai; d'altronde i detenuti non dispongono di un'organizzazione sindacale, né tanto meno di una "cultura rivendicativa", capace di diventare motore di riforma e di innescare cambiamento, e tutto ciò consente la strutturazione di quel silenzio di cui il disagio si nutre.
Ceraudo F. (2004). La sessualità in carcere: aspetti psicologici, comportamentali ed ambientali. Medicina Penitenziaria - periodico di informazione culturale e sindacale, 31, 16.
Il carcere Due Palazzi di Padova, ad esempio, dispone di ampi spazi nei quali sono ubicati vari capannoni industriali gestiti da imprese private: l'amministrazione penitenziaria può così organizzare un tipo di lavoro intramurario molto qualificato, come la produzione di guardrail, microchip, schede elettroniche, manichini; invece nei piccoli Istituti di reclusione o in quelli dall'architettura antica - molti di questi sono ricavati da abbazie e fortezze - tali attività, come anche le classiche rieducative, non sono fattibili per l'inadeguatezze degli spazi. In esse, inoltre, svolgere le tradizionali attività risocializzative e far fronte al problema annoso del sovraffollamento diventa ancora più difficoltoso.
Turco M., Relatore del Parlamento europeo sui diritti dei detenuti nell'UE (2004). La situazione nelle carceri italiane, Elaborazione dei dati del Ministero della Giustizia al 30 giugno 2004.
Serra, C. (2000). Psicologia penitenziaria. Sviluppo storico e contesti psicologico sociali e clinici. Milano: Giuffrè Editore
Serra, C., Macchia, P. (1995). Chi ha paura di uscirne? Tossicodipendenza, AIDS e carcere: Strategie possibili ed interventi. Roma: Edizioni Kappa.
Dazzi, N., Vetrone, G. (2000). Psicologia. In M., W., Battacchi, Le Emozioni, (pp361-404). Roma: Carocci Editore.
Bentivogli, S. (2004). In passato, quando una entrava in carcere sapeva ben presto cosa doveva fare e cosa gli era vietato. Ristretti Orizzonti, 6, 7.
Carot, E., Peraire, J., Carlinga, A., Bacche, M. (2003). Les rèactions psychopatologiques de captivite. Annales Médico - psychologiques, VII
"Gli anni successivi alla seconda guerra mondiale", Memoria e Libertà, articolo senza firma apparso su internet all'indirizzo https://www.tmcrew.org, marzo 2004.
Severi, P. (1996). 231 giorni. Un diario dal carcere. Un percorso di liberazione. Milano: Frontiera Edizioni.
Rokach, A. (2001). Criminal offense type and the causes of loneliness. Journal of Psychology, 135(3), 277-91.
Keaveny, M., E., Zauniewski, J., A. (1999). Life events and psychological well-being in women sentenced to prison. Issues Mental Health Nurse, 20(1), 73-89.
Schmitt, W., A., Newman, J., P. (1999). Are all psychopathic individuals low-anxious?. Journal of Abnormal Psychology
https://www.ristretti.it/areestudio/salute/mentale/bartolini/index.htm.
Catanesi, R. (1995). Disturbi mentali e compatibilità carceraria. Rivista Italiana di Medicina Legale, XVIII, 1043.
Dello Russo, G., Rutigliano, G. (1968). Considerazioni sulla sindrome ganseriana, Rivista Psichiatrica, III, 1.
 |
| Appunti su: grafico che rappresenti carceri italiani, benessere nei carceri italiani grafici, carcere incide sulla personalitC3A0, |
|
| Appunti Etica moralita |  |
| Tesine Amministratori |  |