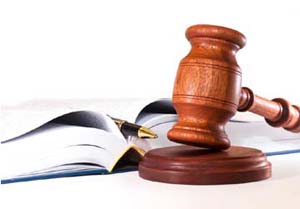L'individuazione dei "diritti inviolabili": serie chiusa o serie
aperta?
Ma quali situazioni debbono venire definite come "diritti inviolabili"?
La carta costituzionale denomina espressamente "inviolabili" talune situazioni
attive: quali la libertà personale, di domicilio e di comunicazione, come pure
il diritto di difesa giudiziale. Ma non può dubitarsi che nel quadro rientrino
altri diritti fondamentalissimi: a cominciare dalla libertà d'associazione e di
manifestazione del pensiero. Ancor più decisiva è la considerazione che i tre
principi ai quali si informa questa parte della costituzione - quello
democratico, quello personalista e quello pluralista - fanno parte di un comune
disegno, integrandosi e sostenendosi a vicenda; sicché non sono contestabili le
premesse democratiche del principio personalista, sebbene le prime non
esauriscano del tutto il secondo. Nell'individuazione di tali diritti occorre
guardare anche al titolo dei "rapporti politici", quali il diritto di voto e la
libera associazione in partiti. Ma non si possono nemmeno escludere i "rapporti
economici", di cui al titolo terzo della parte prima. Da un lato, l'intera repubblica
è stata "fondata sul lavoro", tanto che un'autorevole corrente dottrinale ha
proposto di inserire il "principio lavorista" accanto ai principi democratico,
personalista e pluralista.
Detto ciò bisogna subito aggiungere che il conseguente quadro dei
"diritti inviolabili" appare quanto mai disomogeneo. In comune tali situazioni
hanno unicamente la posizione ad essa spettante "nella scala dei valori
costituzionali": vale a dire la loro coessenzialità rispetto alla forma di
stato vigente in Italia. Al di là di questo dato, s'impongono invece accurate
distinzioni interne, sul tipo di quella fra diritti individuali e diritti
funzionali. Si suole sostenere che trovino "in se stessi la propria esclusiva
finalità". Degli altri si afferma che sarebbero contraddistinti dalla loro
"funzione sociale". Ora l'utilità e la stessa validità della contrapposizione
fra diritti individuali e funzionali sono state messe in dubbio, soprattutto
perché entrambi sarebbero riconosciuti e garantiti anche in vista del buon funzionamento
del sistema. Ma queste obiezioni, di per sé fondate, non tolgono che la
distinzione sia pur sempre producente, in vista dei limiti che le rispettive
situazioni si prestano a subire. Alcuni fra i "diritti inviolabili" non
tollerano altro che i limiti immediatamente e specificamente risultanti dalla
costituzione, accanto a quelli imposti dall'esigenza di non pregiudicare oltre
misura quei valori costituzionalmente garantiti. In altri campi la disciplina
costituzionale si risolve nell'assicurare la presenza di certe specie di
situazioni attive, devolvendo alla legge ordinaria il compito di determinarne i
confini. Si deve avvertire però, che la configurazione dei diritti del primo
tipo richiede comunque, nel più vario senso, il bilanciamento degli interessi
in gioco. Le scelte inerenti ad un tale contemperamento spettano innanzitutto
alla legge. All'organo della giustizia costituzionale compete cioè, per prima
cosa, verificare se a fondamento delle norme limitative dei diritti in
questione vi siano altri interessi costituzionalmente meritevoli.
Sino a pochi anni fa, l'orientamento della corte costituzionale era
comunque nel senso che la formula dell'art. 2 fosse riassuntiva delle
situazioni giuridiche attive puntualmente considerate nel seguito della costituzione.
Vero è che la giurisprudenza costituzionale non ignorava l'esistenza di
"diritti inviolabili" non previsti dalla costituzione. Così il "diritto alla
vita" veniva fin d'allora definito come "premessa naturale di qualsiasi altra
situazione costituzionalmente protetta". Più in generale, la corte ammetteva la
sussistenza dei "diritti fondamentali inviolabili.necessariamente conseguenti a
quelli costituzionalmente previsti.
Il che concorre a spiegare per quali motivi la giurisprudenza
costituzionale più recente abbia ragionato dell'inviolabilità del "diritto
all'abitazione". Le potenze normative dei disposti costituzionali concernenti i
diritti fondamentali "sono talmente ampie ed elastiche da ricomprendere" quei
"nuovi diritti" che lo sviluppo della coscienza sociale proponga. In altre
parole, ciò che consente quasi sempre di giungere a conclusioni soddisfacenti
nei singoli casi è la reciproca "integrazione" delle norme stesse.