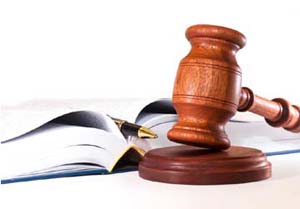La
mediazione penale in Italia
Nonostante
poco o nulla si sappia circa una analoga esperienza in Italia, vanno aggiornati
i progressi che il nostro paese ha fatto negli ultimissimi anni, anche se in
notevole ritardo rispetto agli altri. Tale resistenza del sistema italiano ad
una recezione di un modello riparativo della giustizia è connaturato ai
principi cardine che reggono il nostro sistema giudiziario. Il principio
dell'obbligatorietà dell'azione penale ha sicuramente costituito un ostacolo di
non poco rilievo alla creazione di un qualsivoglia modello che dalla
legalità tribunale si discostasse.
Ovviamente in un sistema rigidamente ancorato al processo, le alternative che
possono essere create non possono prescindere da questo dato e la possibilità
di un'evoluzione diviene plausibile solo se il legislatore recepisce e
concretizza in legge un cambiamento altrimenti attuabile. Il principio di legalità,
soprattutto in materia processuale, è difficilmente eludibile se non trovando
un ingresso in spiragli lasciati aperti dalla legge. Questi spiragli in effetti
ci sono, anche se di portata limitatissima, ed hanno così dato la possibilità
di effettuare l'esperimento riparativo anche in Italia. Ho detto che è
recentissimo. Infatti il nostro primo Ufficio di Mediazione Penale è stato
creato a Torino nel 1996. In seguito sono stati aperti altri Uffici di
Mediazione in altre città d'Italia quali a Bari (1996) e a Milano (1998). Oggi
sono presenti anche a Trento e Bolzano, a Catanzaro e un Istituto di ricerca
sulla mediazione a Roma. La situazione è notevolmente cambiata nell'arco degli
ultimi quattro anni, ma ancora non si può certo affermare che si versi in un
terreno ancora stabile e definito. Non è possibile fare statistiche sui
risultati dell'istituto, dato che siamo ancora in una fase di sperimentazione,
ma è già agevole fare delle considerazioni positive sugli esiti risultanti da
questa, almeno per noi, novità processuale. Le notizie che ho fin qui riportate
e che seguiranno sono state da me raccolte all'Ufficio di Mediazione Penale a
Milano, dove ho intervistato alcuni esperti dell'ufficio che mi hanno spiegato
il funzionamento dell'istituto ed i suoi scopi.
La
Mediazione penale, bisogna avvertire, ha una limitata applicazione, cioè
solamente all'interno del processo minorile, o in sua sostituzione. La
legislazione di riferimento è quindi i d.P.R. 22 settembre 1998, n°448 (Disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni) in combinato disposto con l'art.564 c.p.p. (approvata
in stessa data con il d.P.R. n°447), le cui norme lasciano uno spazio, seppur
esiguo, alla possibilità di compiere la mediazione tra i protagonisti della
vicenda penale in alternativa al processo. Le norme del c.d. Codice di
Procedura penale minorile che rendono possibile un intervento alternativo al
processo di tipo riparativo sono gli artt.9, 27 e 28. Prima di analizzare
partitamente i singoli articoli è bene fare una premessa sulla diversa natura
del processo minorile sotto aspetti che lo tengono distinto da quello ordinario
per gli adulti. Il legislatore in numerose disposizioni ha mostrato un
atteggiamento di maggior apertura ed elasticità nei confronti di imputati (nonché
detenuti) minori. Questo nella
convinzione che l'esperienza processuale e a maggior ragione quella detentiva
possa rappresentare un ostacolo al futuro sviluppo della persona dato anche il
probabile grado di immaturità e di sensibilità che gli adolescenti presentano.
Questa la ratio su cui è modellato il sistema penale minorile, che tende
quindi, ove possibile, ad evitare il contatto destabilizzante con la giustizia,
cercando preferibilmente altre modalità di recupero del minore. Basti pensare
ad una disposizione come l'art.27 ( Sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto) che dispone la
possibilità per il giudice, se risulta la tenuità del fatto o la occasionalità
del comportamento, di emettere, su proposta del P.M., sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. Altra norma
fondamentale per l'ammissibilità della mediazione è l'art.9 (Accertamenti sulla personalità del minorenne)
del decreto con cui è stabilito che ' il pubblico ministero e il giudice
acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari,
sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il
grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché le
adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili'.
Tale tipo di accertamento può essere demandato dal giudice e dal pubblico
ministero anche a soggetti non processuali come gli esperti ex art.9, comma 2, cui può essere richiesto, anche in via
informale, un parere. Ora questa previsione della compartecipazione allo studio
della personalità del minore anche da esperti esterni, fornisce la legittimità
all'intervento, eventuale, dei mediatori, che in effetti sono persone
qualificate in materia. I mediatori, infatti, oltre a aver seguito corsi di
preparazione specializzati in materia minorile e in particolare sulla
mediazione, sono persone con determinate qualifiche professionali, quali
criminologi, assistenti sociali, psicologi, avvocati, educatori. La vara
legittimazione l'istituto della mediazione la riceve però dall'ultima delle
norme menzionate e cioè dall'art.28 (Sospensione
del processo e messa alla prova) dove è esplicitamente previsto al 2° comma
che il giudice, insieme alle altre prescrizioni stabilite nell'ordinanza di
sospensione del processo, può promuovere la conciliazione del minore con la
persona offesa dal reato . Ora la prassi ha
dimostrato che nel caso appena prospettato la mediazione si realizza molto
raramente. Quando interviene l'art.28, infatti, il processo è già in corso e la
mediazione perde la sua funzione principale di permettere una conciliazione
extragiudiziale del conflitto, scopo principale dell'istituto. In più la
circostanza che venga promossa durante il processo con l'ordinanza con cui si
impartiscono le prescrizioni al minore per il periodo di messa alla prova, fa
sì che l'istituto si confonda con queste, perdendo la essenziale caratteristica
volontaria dell'adesione al programma di mediazione. Come mi hanno spiegato a
Milano ci sono 'pochi casi di messa alla prova, anche se teoricamente è
l'ambito in cui si trova scritto il tentativo di conciliazione, perché può
essere confusa con una forma di sanzione. () Nel momento di messa alla prova
il giovane ha tante prescrizionimetterci anche la mediazione è un rischio,
perché può essere confusa con una di queste prescrizioni e quindi si perde
l'adesione libera della parte' . L'ambito più sfruttato
dai giudici è invece la richiesta di parere agli esperti ex art.9, l'art.27
sulla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto in combinato
disposto con l'art.564 c.p.p. (Tentativo
di conciliazione). In questi casi, nei reati punibili a querela (art.564
c.p.p.), o nei casi in cui il fatto è 'tenue ed occasionale'
ex.art.27, il minore arriva alla mediazione in una fase anticipata, ossia
durante le indagini preliminari, per cui non ha ancora subito condizionamenti
di origine processuale. Gli articoli fondamentali per l'applicazione della
mediazione sono il 9 e il 27. Il primo è molto sfruttato, perché dà la
possibilità al giudice di far svolgere un'osservazione agli esperti o ai
servizi della giustizia sulla personalità del minore, sulle sue condizioni
familiari, sociali ed ambientali. L'esito di questa osservazione permette poi
al giudice di prendere delle decisioni processuali, come l'applicazione di una
misura cautelare o fare comunque delle scelte. Interessante è notare come il
legislatore abbia preso atto della insufficienza del processo di fronte ad uno
studio approfondito sulla vicenda umana che lo sottende e che non riesce ad
emergere con gli strumenti formali ordinari. La norma non parla di
esplicitamente di mediazione, ma di esperti che però vengono individuati con i
professionisti degli uffici. L'art.27 consente, al contrario, non di evitare il
processo, che con la sentenza di non luogo a procedere è già stato evitato, ma
a riempire di un significato plausibile la dichiarazione di irrilevanza del
fatto. La pronuncia di irrilevanza del fatto può essere interpretata dal minore
in modo altamente diseducativo se deve trovare giustificazione solo in se
stessa. Mi spiego meglio. Il fatto c'è stato e il minore lo sa perfettamente.
Una sentenza di questo tipo 'viene vissuta da un adolescente come una non
risposta' ,
e può essere interpretata come se nulla fosse effettivamente successo. Cosa che
non è. Le considerazioni che il legislatore ha fatto per giungere
all'introduzione di questa previsione clemenziale sono di varia natura e
poggiano principalmente sulla volontà di evitare il contatto con la giustizia
al minore che ha commesso il primo reato di gravità non allarmante. Introdurre
la mediazione in questi casi porta a 'contribuire a riempire di
significato queste norme in termini, per il reo, di responsabilizzazione. ()
Non incontro l'articolo tot, che mi dice che ho commesso un fatto (rectius: che
non è stato commesso), ma incontro una persona in carne ed ossa, che sta
soffrendo per quello che io ho fatto '.
Al termine
di questi vari tipi di procedimenti l'ufficio fornisce al giudice la c.d. restituzione. La restituzione non è
altro che una relazione sintetica sull'esito della mediazione, che si limiterà
ad informare se è stato positivo, negativo, incerto o non è stata fatta. E'
interessante notare come ciò che avviene in realtà durante gli incontri tra reo
e persona offesa rimangano coperti dal segreto professionale dei mediatori, che
sono tenuti solo a riferire circa la positività dell'esito o meno. Questo
aspetto è di non poco momento, se si considera che tutto ciò che avviene invece
durante il processo deve essere conosciuto dal giudice e non vi è certo spazio
per momenti confidenziali o personali. Questo obiettivo invece la mediazione lo
raggiunge pienamente. Fa sì che i protagonisti si riapproprino della loro
vicenda, fornendo così la possibilità ad entrambi di riallacciare una
comunicazione che si è interrotta con il reato e che il processo avrebbe
contribuito a non ricucire. Aiuta il reo a comprendere il male che ha provocato
con il suo comportamento, e aiuta la vittima ad esprimerlo, trovando finalmente
una cassa di risonanza del proprio punto di vista, della propria sofferenza cui
il processo penale non lascia spazio. Quando si giunge ad un accordo tra reo e
vittima, durante il percorso c'è stato un duro lavoro in termini di
comprensione reciproca, dei rispettivi punti di vista. I mediatori lavorano
'sui sentimenti e sulle sensazioni, sui vissuti delle persone della
vicenda',
aspetti che non hanno alcuna possibilità di emergere nella loro pienezza
durante un processo, ma che sono come il sapere comune è a conoscenza, gli
elementi scatenanti di ogni fattispecie delittuosa. Queste sono le linee
generali del discorso intorno alla mediazione penale, che per essere integrato
necessita della lettura dell'intervista fatta a Milano, a cui rinvio per
completare l'argomento.