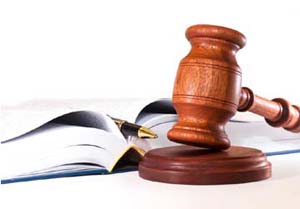I procedimenti e i sistemi di elezione delle camere
Ovviamente comuni sono i principi che governano l'elettorato, tanto
attivo quanto passivo. Da un lato, la stessa costituzione proclama che deputati
e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. D'altro lato, comune è
il regime delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità. Assolutamente in
eleggibili ad entrambi i rami del parlamento sotto pena d'invalidità, salvo che
l'esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della
scadenza del quinquennio delle camere, sono i presidenti delle province, i
sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, gli alti gradi
e i funzionari della pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei ministri, i
prefetti e i viceprefetti, gli alti gradi delle forze armate, i magistrati e i
diplomatici. L'esclusione "risponde a imprescindibili esigenze di interesse
generale" le quali richiedono, per un verso, "che l'espressione del voto rappresenti
la libera e genuina manifestazione di volontà dell'elettore, donde
l'ineleggibilità delle persone e dei funzionari che possono esercitare
pressione sugli elettori stessi. Al di fuori di questi tipi d'ipotesi, si
pongono invece numerose cause d'incompatibilità, che non rendono annullabile
l'elezione, ma sono sanabili qualora gli interessati optino entro un breve
termine fra le cariche da essi ricoperte ed il mandato parlamentare.
Le sole differenze già segnalate, attengono invece a quella che si suole
definire la capacità elettorale: vale a dire all'età minima richiesta per
votare e per essere votati. Fondamentalmente comuni si dimostrano, altresì, i
rispettivi procedimenti elettorali. In entrambi i casi l'iter si suddivide in
quattro o cinque momenti fra loro distinti: cioè nella fase dell'iniziativa,
nella fase preparatoria, nella fase della votazione e nella fase dello
scrutinio. A mettere in moto la macchina elettorale è il decreto con il quale
il presidente della repubblica effettua la convocazione dei comizi elettorali.
Si apre a questo punto la complessa fase preparatoria, con la costituzione dei
vari uffici elettorali. Ed è agli uffici stessi che i partiti od i gruppi
politici organizzati presentano le candidature nei collegi uninominali e le rispettive
liste di candidati. Quanto alla fase della votazione, s'impone in ogni caso il
rispetto delle proclamazioni sulla personalità, libertà e segretezza del voto.
In ogni seggio, dopo che gli elettori hanno votato nel corso dell'unica
giornata elettorale si svolgono le prime operazioni di scrutinio. Ed è su
quella base che gli uffici medesimi provvedono alla proclamazione degli eletti.
Le sole varianti significative
discendono dalla diversità dei sistemi di elezione delle due assemblee. I
sistemi elettorali sono complessi "meccanismi per la trasformazione dei voti in
seggi": nella definizione dei quali rileva anzitutto la varia tipologia dei
collegi elettorali e delle corrispondenti circoscrizioni. Di norma, il
territorio dello stato viene a questi fini suddiviso in più circoscrizioni e
dunque in più collegi. Tali collegi si dicono uninominali, quando ognuno di
essi dispone di un solo seggio; plurinominali, quando i seggi rispettivamente
assegnati sono più d'uno e concretamente possono assommare anche a varie decine
di unità. Al di là della nota contrapposizione fra i sistemi elettorali
maggioritari e i sistemi elettorali proporzionali, i meccanismi in questione si
presentano a venire quanto meno quadripartiti: in primo luogo si danno i
sistemi maggioritari estremi o puri, per cui la forza politica che consegue nel
collegio la maggioranza relativa si vede con ciò stesso attribuiti il seggio o
i seggi disponibili; in secondo luogo, seguono i sistemi proporzionali
corretti, per mezzo dei quali la ripartizione dei seggi si effettua in
proporzione ai suffragi ottenuti dai vari partiti concorrenti; in quarto luogo,
il quadro è completato dai sistemi proporzionali estremi o puri, in cui non
vigono correttivi di sorta, sicché il parlamento tende ad essere lo specchio
fedele del paese politicamente considerato. Ora in presenza dei collegi
uninominali, occorre per definizione avvalersi dei sistemi maggioritari; ma i
sistemi stessi possono essere ad unico turno, come nel caso della Gran
Bretagna, ovvero a doppio turno, come si verifica tuttora in Francia. Per
contro, i collegi plurinominali richiedono generalmente l'applicazione dei
sistemi proporzionali; ma non mancano alcune eccezioni, rappresentate da quei
sistemi maggioritari "di schiacciamento", per mezzo dei quali le forze
politiche prevalenti s'impadroniscono di tutti i seggi spettanti al collegio.
Quanto alla elezione del Senato, la riforma è stata resa indispensabile
dal referendum abrogativo del 18 aprile 1993. Il referendum fu ammesso in
quanto manipolativo, anziché produttivo di un paralizzante vuoto: "conseguenza
dell'abrogazione" sarebbe stata "la sostituzione del sistema attuale con un
sistema misto prevalentemente maggioritario e precisamente maggioritario con
unico turno per 238 seggi da assegnare nei collegi. Ogni territorio regionale è
stato perciò "ripartito in collegi uninominali, pari a tre quarti dei seggi
assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto"; mentre, "per
l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti", in primo luogo del sistema
maggioritario uninominale, "ciascuna regione è costituita in un'unica
circoscrizione elettorale". Ciò comporta "candidature individuali". Per altro i
gruppi meno forti sono avvantaggiati dalla scorporo, consistente nel fatto che
dalla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo vanno "sottratti i voti dei
candidati già proclamati eletti".
Le nuove norme per l'elezione della camera dei deputati, sono
fondamentalmente in linea con quelle introdotte per il Senato. Anche dalla
camera, infatti, si prevede che, "in ogni circoscrizione, il settantacinque per
cento del totale dei seggi" venga "attribuito nell'ambito di altrettanti
collegi uninominali"; mentre il residuo venticinque per cento deve essere
"attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti".
Le tecniche utilizzate non coincidono però: in primo luogo agli elettori spetta
un doppio voto. In secondo luogo, lo scorporo dalla cifra elettorale di
ciascuna lista non tiene conto di tutti i voti ottenuti dai relativi candidati
eletti nei collegi uninominali; in terzo luogo, al riparto della quota
proporzionale non partecipano tutte le liste presentate nelle singole
circoscrizioni. Ciò che più conta, le riforme in questione non sono riuscite a
rendere possibile la formazione di forti maggioranze entro il parlamento e la
conseguente investitura di governi destinati a durare per l'intera legislatura.