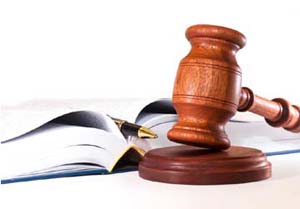Dalla costituzione provvisoria del 1944 alla nuova carta costituzionale
del 1947
Formalmente dunque, quello vigente in Italia continua ad essere un
regime dell'esecutivo, imperniato sul Capo dello Stato e sul Capo del Governo;
ma in linea di fatto, il regime è alterato dalla presenza determinante dei
partiti politici che implica nel tempo stesso, una riduzione dei poteri reali
del Luogotenente, una restituzione del Primo Ministro al suo vecchio ruolo di
Presidente del Consiglio dei ministri ed un più stretto legame fra il governo
stesso e l'opinione pubblica. Il 9 maggio del '46 la tregua istituzionale viene
però interrotta dall'abdicazione di Vittorio Emanuele III: per effetto della
quale il luogotenente assume il titolo di Umberto II, Re d'Italia, aprendo con
ciò la brevissima fase del "regno di maggio". In quell'occasione la parte
repubblicana denuncia la violazione del "patto di Salerno", sostenendo che
Vittorio Emanuele III non poteva abdicare, avendo già rinunciato nel '44 alla
totalità dei suoi poteri. Fra monarchici e repubblicani si aprì un'ulteriore
polemica, avente per tema i criteri di valutazione dell'esito del referendum:
in quanto tra i primi si affermava che il voto popolare sarebbe stato decisivo
nella sola ipotesi che il numero dei sostenitori della Repubblica o della
Monarchia fosse risultato superiore a quello di tutti gli altri votanti,
facendo pesare accanto ai fautori della tesi contraria anche coloro che
avessero votato scheda bianca; mentre i secondi asserivano che tanto i voti
nulli quanto le schede bianche dovessero venire esclusi dal computo, per porre
invece a diretto confronto i soli voti validamente espressi a favore dell'una o
dell'altra forma istituzionale. Tuttavia fra i costituzionalisti è divenuto da
tempo pacifico che fosse fondata la tesi formulata dalla parte repubblicana:
non solo perché le schede bianche sono escluse dalla valutazione degli esiti di
tutti i referendum disciplinati dall'attuale ordinamento; ma anche perché
diversamente il referendum istituzionale avrebbe corso il rischio di dover
essere infinitamente ripetuto, mentre l'ipotesi di una reiterazione di esso non
era stata minimamente prevista dal legislatore italiano del '46. Con la prima
seduta dell'assemblea costituente la forma di governo subisce un'ulteriore
modificazione. I costituenti non si limitarono alla progettazione ed all'approvazione
della nuova Carta costituzionale, sulla base del referendum, ma esercitarono
inoltre sia certe specifiche funzioni legislative ordinarie sia l'attività di
controllo politico sull'intero operato del Governo. Rispetto al modello
parlamentare un fondamentale motivo di diversità fu dato dalla circostanza che
il Governo rimase il titolare della legislazione, fatta eccezione per singole
leggi ordinarie di particolare importanza. Ma in quel momento si riteneva che
non sarebbe stato conveniente ritornare senz'altro alla tradizionale divisione
dei poteri fra il legislativo e l'esecutivo, perché la Costituente doveva
rimanere libera di concentrarsi sul suo compito essenziale, varando una nuova
costituzione nei brevissimi termini fissati dal decreto n. 98 del '46.
I cosiddetti elementi costitutivi dello Stato; il popolo e la nazione
(pagina 105)
Il concetto di stato presupponeva l'esistenza di tre elementi
costitutivi: il popolo, il territorio e il governo. In realtà ciò che residua è
soltanto l'evidente verità che ogni ordinamento statale presuppone un
territorio, indipendentemente dal quale non si potrebbe più distinguerlo dalla
generalità degli ordinamenti giuridici non statali; non possono prescindere da
una pluralità di soggetti, che nel caso dello Stato assume appunto il nome di
popolo. Quanto all'odierna Italia alcuni disposti della vigente carta
costituzionale ragionano senz'altro di popolo: per popolo si intende la
"generazione attuale di cittadini". Il termine nazione allude generalmente ad
una "sintesi delle generazioni passate, presenti e future" dei cittadini
italiani.
Più arduo e discusso è il problema riguardante la qualificazione del
popolo sul piano della dogmatica giuridica. Si è infatti dubitato se il
carattere democratico del vigente ordinamento imponga di considerare il popolo
stesso alla stregua di un organo di stato; oppure si tratti di una "figura
soggettiva" per sé stante, che non può essere confusa con lo Stato-soggetto.
Giustamente prevale la seconda opinione. Per altro è corrente l'avviso che il
popolo stesso non sia configurabile come persona giuridica a sé stante. E la
circostanza che la Carta costituzionale gli conferisca senz'altro la sovranità
viene appunto spiegata ricorrendo all'idea di una figura giuridica soggettiva
di rango minore; salvo a ritenere che si tratti di un'espressione sintetica.