 |
|
 |
|
| Visite: 1400 | Gradito: |
Leggi anche appunti:EbreiEbrei 2000 a.c Ebrei in mesopotamia ed Ur Abramo guida gli La ResistenzaLa Resistenza I sogni dei partigiani sono rari e corti, sogni nati dalle Le forme di governoLE FORME DI GOVERNO Le forme di governo sono le modalità con cui vengono |
 |
 |
Introduzione (le origini della parola)
Uno stato che vuole esercitare il proprio 'totale' controllo sulla società, soffocandone ogni autonomia, abolendo ogni libertà e pluralismo attraverso sia l'uso della violenza sia l'uso degli strumenti atti a produrre consenso, invadendone ogni campo, occupando anche la sfera privata dei cittadini, è uno Stato totalitario o totale. L'aggettivo totale o totalitario viene elaborato nel lessico politico in Italia e in Germania dagli anni Venti in poi. Per la prima volta in Italia è Mussolini che nel discorso del 28 Ottobre 1925 sembra definire il nuovo regime: 'Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato'. Sarà poi in particolare il filosofo Giovanni Gentile, importante esponente della cultura fascista a contribuire in modo determinante ad elaborare il concetto di 'totalitario', a imporre una concezione etica dello Stato e ad attribuire alla missione totalitaria dello Stato caratteri quasi religiosi. La definizione di totalitarismo risale all'inizio degli anni cinquanta, quando apparve l'opera di Hannah Arendt "Le origini del totalitarismo"(1951). L'autrice connetteva le dittature appena sperimentate dalla civiltà europea con il famoso Metodo Comparativo basato sul confronto punto per punto dei tre totalitarismi.
Secondo Hannah Arendt i totalitarismi sono stati possibili per il profondo cambiamento sociale e politico avvenuto agli inizi del 900': Il processo di modernizzazione che nel corso del Novecento aveva trasformato le società europee in società di massa. Industrializzazione e urbanizzazione, insieme a crescita demografica ed aumento della disoccupazione, avevano rotto gli antichi vincoli comunitari e le relazioni personali "faccia a faccia" dei paesi e dei villaggi; tanto che le esigenze civili e professionali dei singoli individui si erano separate fino alla reciproca ignoranza e indifferenza. Questa enorme massa amorfa rappresenta la base di consenso di nuovi regimi autoritari, capaci di dominare le folle divise attraverso l'autorità carismatica di un capo. Lo strumento per restituire loro unità e identità era costituito dal mito imperialistico della nazione, forte e potente nel contesto internazionale: un mito alimentato dal capo secondo i moduli tradizionali della coltura militaristica, senza bisogno della mediazione caratteristica della democrazia parlamentare. Lo stato e i cittadini formavano una comunità la quale vedeva verso gli altri "I Diversi" che automaticamente erano nemici. Il regime dittatoriale funzionava come un recupero artificiale di quelle identità di gruppo(organizzazioni paramilitari, stili di vita comuni, rituali di massa) che ormai erano state perdute, attraverso l'uso della "psicologia collettiva".
I tratti comuni fra i totalitarismi :
-Presenza di un dittatore
-Partito unico di massa
-Ideologia assoluta
-Concentrazione dei poteri economici nelle mani dello stato
-Sfrenato uso della propaganda per produrre consensi
-Uso delle squadre che eliminavano le opposizioni politiche
Tratti comuni fascismo e nazismo :
-Antisemitismo
-Proprietà privata
Caratteristiche comunismo :
-Abolizione della proprietà privata
Marx e le basi filsofiche del comunismo Il filosofo Karl Marx (1818-1883)

Il futuro per Marx è la società comunista, una società perfetta, caratterizzata dall'assenza di proprietà privata e della lotta di classe, in cui ognuno lavori in modo adeguato alle proprie possibilità e riceva in modo adeguato ai propri bisogni. E la storia tende proprio a questo modello: il proletariato sta aumentando sempre di più e i capitalisti stanno diminuendo: ci sarà un momento in cui le 'forze di produzione'(proletari) saranno il 90% della società, mentre i 'mezzi di produzione'(fabbriche) saranno in mano al 10% de essa. Sarà una contraddizione esplosiva che terminerà con una rivoluzione. Inizialmente una 'dittatura del proletariato' provvederà a espropriare i proprietari delle loro fabbriche e in seguito la dittatura sarà sostituita dal Comunismo. Marx però non dà precise indicazioni su questo tipo di società, lascia il discorso in sospeso rifiutandosi di 'prescrivere ricette per l'osteria dell'avvenire'. Di una cosa però Marx era sicuro fin dall'inizio: la rivoluzione sarebbe dovuta avvenire in un Paese economicamente e soprattutto industrialmente avanzato.
Stalin e la costituzione dello stato totalitario russo
Losif Stalin Gori 21 dicembre 1878
-Mosca 5 marzo 1953
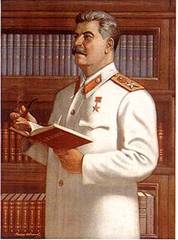 Nel
1924 Lenin muore e inizia così la lotta per la sua successione. I due
personaggi più importanti all'interno del partito sono Trotzkij e Stalin. Il
primo, capo delle Armate Rosse, è un rivoluzionario, contrario alla NEP e
favorevole a riprendere la costruzione di un'economia socialista; inoltre
voleva cercare di estendere la rivoluzione anche ad altri Paesi per evitare che
la Russia si trovasse isolata. Il secondo dal '22 è segretario generale, cioè
organizzatore nazionale del partito; è favorevole alla NEP e al libero mercato
per appoggiare maggiormente la componente contadina del popolo russo, è
favorevole al 'socialismo in un solo Paese' e controlla la potente
'burocrazia sovietica'. Stalin riesce a prendere il controllo e immediatamente promuove una campagna
di nuove iscrizioni al partito: il suo scopo è quello di rinnovarlo e
ampliarlo. Le nuove leve si presentano come 'gente tranquilla' che
cerca solo stabilità e sicurezza all'interno della realtà più potente in Russia
e in cambio garantisce una indiscussa obbedienza: esattamente quello che il
nuovo leader voleva. Inoltre Stalin seleziona i nuovi quadri dirigenti tra
persone a lui fidate sempre nel tentativo di creare un partito a lui fedele
espellendo dal partito e liberandosi degli oppositori politici. Inoltre Stalin,
fa promotore del 'leninismo':
egli infatti si ritiene l'unico vero interprete nonché unico conoscitore dell'ormai
defunto padre della Russia. Il novo capo dei comunisti, proprio per ingigantire
questo culto di Lenin, offre alla nazione russa una reliquia: il corpo
mummificato di Lenin, conservato poi in un mausoleo nella piazza Rossa del
Cremlino. Il comunismo sta diventando sempre più simile ad una religione. In
seguito intraprende una politica economica che vede l'abbandono della NEP e la
conseguente espulsione dal partito del suo ideatore. Nelle campagne si procede
con una collettivizzazione forzata e i contadini sono costretti ad entrare in
aziende collettive. Naturalmente molti contadini e soprattutto molti piccoli
proprietari terrieri (i kulaki) non accettano questa imposizione e a causa
delle loro rivolte iniziano ad essere considerati nemici del Comunismo e della
patria. La maggior parte di loro viene così deportata nei Gulag, campi di lavoro
forzato situati in regioni lontane e desertiche, dal clima inclemente. Per
quanto riguarda l'industrializzazione, vengono varati dei piani quinquennali con cui lo Stato pianifica la produzione e gli
investimenti dandosi obiettivi precisi da rispettare e verificare dopo cinque
anni. Tutta la popolazione avrebbe dovuto quindi trasformarsi in un grande
esercito impegnato a produrre sempre di più; ecco dunque un obiettivo tipico
dei regimi totalitari: militarizzare tutti i lavoratori e fare della loro produttività
l'indice della loro lealtà alla nazione. Naturalmente i piani prevedevano una
durissima disciplina nelle fabbriche, una riduzione dei salari, un durissimo
lavoro, ma in molti casi si riscontrava un certo entusiasmo nei lavoratori,
ancora convinti di costruire un mondo nuovo. Nel 1934 al XVII congresso del
partito, Stalin è ancora nominato segretario, nonostante un quarto dei
congressisti avesse votato contro di lui. Nel Dicembre dello stesso anno Kirov,
un suo collaboratore, viene assassinato in modo misterioso e questo offre al
leader del partito un capo di accusa contro i trotzkisti all'interno del
partito: su 2000 deputati, circa 1200 sono uccisi. L'obiettivo di liberarsi
dell'opposizione era stato raggiunto. Dal 1936 inizia il terrore delle 'epurazioni'.
Con l'utilizzo della NKVD, Stalin accusa e condanna al carcere, ai gulag o alla
morte i maggiori esponenti della 'destra' e della 'sinistra.
Eliminati i quadri dirigenti del bolscevismo storico, il segretario del partito
è il solo e incontrastato signore della Russia. L'istruzione (che il regime
diffonde diminuendo al 18% gli analfabeti) e la politica di incoraggiamento
verso la cultura promuovono la formazione di un ceto di intellettuali,
naturalmente i libri di storia vengono controllati e viene istituito un testo
unico con solo i punti positivi del comunismo presentato come una continuazione
del bolscevismo. E' questa nuova generazione va a riempire i vuoti lasciati
dalle 'purghe'. Stalin Infine sfrutta anche il cinema per diffondere
la sua politica, poiché era un passatempo abbastanza popolare in Russia, anche
se faceva assistere solo a film che celebrano gli sforzi dei lavoratori, la
fatica dei minatori, il fervore degli operai tutti tesi a battere i record di
produzione, che esaltano il genio del capo, la fedeltà, nonché, in guerra, il
valore dell'Armata Rossa che blocca i nemici, resiste all'assalto delle truppe
naziste e le sconfigge: più una lezione
di patriottismo che un film.
Nel
1924 Lenin muore e inizia così la lotta per la sua successione. I due
personaggi più importanti all'interno del partito sono Trotzkij e Stalin. Il
primo, capo delle Armate Rosse, è un rivoluzionario, contrario alla NEP e
favorevole a riprendere la costruzione di un'economia socialista; inoltre
voleva cercare di estendere la rivoluzione anche ad altri Paesi per evitare che
la Russia si trovasse isolata. Il secondo dal '22 è segretario generale, cioè
organizzatore nazionale del partito; è favorevole alla NEP e al libero mercato
per appoggiare maggiormente la componente contadina del popolo russo, è
favorevole al 'socialismo in un solo Paese' e controlla la potente
'burocrazia sovietica'. Stalin riesce a prendere il controllo e immediatamente promuove una campagna
di nuove iscrizioni al partito: il suo scopo è quello di rinnovarlo e
ampliarlo. Le nuove leve si presentano come 'gente tranquilla' che
cerca solo stabilità e sicurezza all'interno della realtà più potente in Russia
e in cambio garantisce una indiscussa obbedienza: esattamente quello che il
nuovo leader voleva. Inoltre Stalin seleziona i nuovi quadri dirigenti tra
persone a lui fidate sempre nel tentativo di creare un partito a lui fedele
espellendo dal partito e liberandosi degli oppositori politici. Inoltre Stalin,
fa promotore del 'leninismo':
egli infatti si ritiene l'unico vero interprete nonché unico conoscitore dell'ormai
defunto padre della Russia. Il novo capo dei comunisti, proprio per ingigantire
questo culto di Lenin, offre alla nazione russa una reliquia: il corpo
mummificato di Lenin, conservato poi in un mausoleo nella piazza Rossa del
Cremlino. Il comunismo sta diventando sempre più simile ad una religione. In
seguito intraprende una politica economica che vede l'abbandono della NEP e la
conseguente espulsione dal partito del suo ideatore. Nelle campagne si procede
con una collettivizzazione forzata e i contadini sono costretti ad entrare in
aziende collettive. Naturalmente molti contadini e soprattutto molti piccoli
proprietari terrieri (i kulaki) non accettano questa imposizione e a causa
delle loro rivolte iniziano ad essere considerati nemici del Comunismo e della
patria. La maggior parte di loro viene così deportata nei Gulag, campi di lavoro
forzato situati in regioni lontane e desertiche, dal clima inclemente. Per
quanto riguarda l'industrializzazione, vengono varati dei piani quinquennali con cui lo Stato pianifica la produzione e gli
investimenti dandosi obiettivi precisi da rispettare e verificare dopo cinque
anni. Tutta la popolazione avrebbe dovuto quindi trasformarsi in un grande
esercito impegnato a produrre sempre di più; ecco dunque un obiettivo tipico
dei regimi totalitari: militarizzare tutti i lavoratori e fare della loro produttività
l'indice della loro lealtà alla nazione. Naturalmente i piani prevedevano una
durissima disciplina nelle fabbriche, una riduzione dei salari, un durissimo
lavoro, ma in molti casi si riscontrava un certo entusiasmo nei lavoratori,
ancora convinti di costruire un mondo nuovo. Nel 1934 al XVII congresso del
partito, Stalin è ancora nominato segretario, nonostante un quarto dei
congressisti avesse votato contro di lui. Nel Dicembre dello stesso anno Kirov,
un suo collaboratore, viene assassinato in modo misterioso e questo offre al
leader del partito un capo di accusa contro i trotzkisti all'interno del
partito: su 2000 deputati, circa 1200 sono uccisi. L'obiettivo di liberarsi
dell'opposizione era stato raggiunto. Dal 1936 inizia il terrore delle 'epurazioni'.
Con l'utilizzo della NKVD, Stalin accusa e condanna al carcere, ai gulag o alla
morte i maggiori esponenti della 'destra' e della 'sinistra.
Eliminati i quadri dirigenti del bolscevismo storico, il segretario del partito
è il solo e incontrastato signore della Russia. L'istruzione (che il regime
diffonde diminuendo al 18% gli analfabeti) e la politica di incoraggiamento
verso la cultura promuovono la formazione di un ceto di intellettuali,
naturalmente i libri di storia vengono controllati e viene istituito un testo
unico con solo i punti positivi del comunismo presentato come una continuazione
del bolscevismo. E' questa nuova generazione va a riempire i vuoti lasciati
dalle 'purghe'. Stalin Infine sfrutta anche il cinema per diffondere
la sua politica, poiché era un passatempo abbastanza popolare in Russia, anche
se faceva assistere solo a film che celebrano gli sforzi dei lavoratori, la
fatica dei minatori, il fervore degli operai tutti tesi a battere i record di
produzione, che esaltano il genio del capo, la fedeltà, nonché, in guerra, il
valore dell'Armata Rossa che blocca i nemici, resiste all'assalto delle truppe
naziste e le sconfigge: più una lezione
di patriottismo che un film.
Hitler e la costruzione dello stato totalitario tedesco
Adolf Hitler Braunau 20 aprile 1889
- Berlino, 30 aprile 1945
 Nell'anno
della grande crisi si presenta per la prima volta alle elezioni politiche
Hitler col suo partito, ma riceve soltanto il 3,2% dei voti. In seguito però la
grande depressione determina in Germania un sempre più rapido deterioramento
della situazione politica con un susseguirsi di deboli governi di coalizione,
fino a quando la NSDAP di Hitler nel '33 non ottiene il 37% dei voti. Ormai il
partito hitleriano rappresenta una discreta quantità del Parlamento e non è più
una realtà sottovalutabile: Hitler diventa così cancelliere e gli viene
affidato l'incarico di formare il nuovo governo. Alla fine del '33 la
Repubblica di Weimar non esiste più. Come ha fatto Hitler a guadagnare così
tanto consenso nel giro di soli due anni? Per prima cosa egli presentava un
programma di enorme forza ed energia, nonché innovativo. Nell'opera Mein Kampf,
egli parla di una lotta cosmica e di una missione universale del popolo
tedesco: quella di promuovere un'umanità superiore, di eliminare i popoli
inferiori, deboli e impuri. Hitler, infatti, occupandosi di eugenetica, la scienza
che studia il miglioramento della razza umana, dichiara quella ariana come la
migliore in Europa. Inoltre la NSDAP si faceva portavoce del risentimento della
popolazione tedesca nei confronti della Francia sia in seguito alla bruciante
sconfitta della I guerra mondiale, sia all'imposizione del pagamento dei danni
causati dalla guerra in Europa. Questo sentimento veniva tradotto in un
imperialismo aggressivo volto alla conquista dell'est europeo: Hitler infatti
credeva che ogni nazione avesse diritto ad un proprio spazio vitale e che
quello della Germania dovesse essere ampliato, poiché molti popoli di lingua
tedesca si trovavano fuori dai confini dello Stato e soprattutto in Austria,
Polonia e negli altri Paesi dell'est. La NSDAP proponeva anche ai tedeschi
l'ideale della comunità di popolo, una società unita dal vincolo della nazione,
della storia, della lingua che non abbia nessun conflitto al suo interno ma che
sia unita verso fini comuni; nell'ottica della ricerca di questa compattezza,
il partito nazista individua anche un nemico, responsabile delle crisi subite
finora, interno alla patria e quindi da espellere: i marxisti, i finanzieri e
gli ebrei. Hitler rappresenta una novità nel panorama politico dell'epoca e il
suo partito riesce ad ottenere un gran numero di voti anche perché ormai un
vasto numero di elettori non si fida più dei partiti tradizionali, che si erano
dimostrati inetti nei confronti della crisi. Il primo governo presieduto da
Hitler è un governo di coalizione, ma il suo scopo è quello di accentrare il
potere nelle sue mani con una rivoluzione. Per prima cosa inizia a sospendere
gli articoli della Costituzione a favore dei diritti dei cittadini, per dare al
governo la possibilità di vietare ogni libertà di stampa, di opinione e di associazione.
Inoltre crea un corpo di polizia ausiliaria formato da SA (squadre d'azione) e
SS (guardie del corpo di Hitler), corpi paramilitari alle dipendenze dei
nazisti, per il quale è legittimo compiere ogni atto di violenza. Il 27
febbraio '33 scoppia un incendio al Reichstag, la sede del Parlamento: sono
accusati i comunisti che con l'incendio vogliono avviare la rivoluzione. Questo
episodio dà il via ad una furibonda repressione dell'opposizione con arresti di
massa e assassinii. Nello stesso anno continua la politica sui due fronti
(quello del consenso e quello della violenza) del nazismo: da una parte al
governo vengono attribuiti pieni poteri per il bene dello Stato, viene creato
il Ministero per l'Istruzione Popolare e la Propaganda (affidato a Goebbels),
sono organizzate parate e manifestazioni; dall'altro, le SS e le SA continuano
con assassinii, pestaggi, arresti e deportazioni di Ebrei (è proprio l'8 marzo
che è realizzato il primo campo di concentramento a Dachau). Entro la fine del
'33 sono eliminati tutti i partiti eccetto quello nazista, che può così
presentarsi da solo alle successive elezioni. Inoltre vengono anche eliminati
tutti i capi delle SA, perché sotto il controllo di Rhom, non avevano
dimostrato una piena fedeltà nei confronti del cancelliere, così Hitler si
libera totalmente dei pericoli di colpi di stato, dimostrando inoltre di essere
un capo duro ma giusto e di punire le SA che avevano compiuto violenze sulla
popolazione. Nel '34 il Presidente Hindemburg muore. La carica è assunta da
Hitler che vede concentrati nelle sue mani tutti i poteri dello Stato, compreso
l'esercito. Il Fuhrer può cominciare la deportazione e l'eliminazione di altri
nemici della razza come disabili, omosessuali, zingari e nel 1935 sono
proclamate le leggi di Norimberga, leggi che privano gli ebrei di ogni
cittadinanza e ogni diritto da essa derivante. Con le sempre più numerose
deportazioni di ebrei, il regime si vede obbligato alla costruzione di altri
campi di concentramento sia per i lavori forzati, sia per lo sterminio di massa
dei prigionieri (per rafforzare l'economia vengono ampliati i rastrellamenti di
ebrei che nei campi di concentramento costituivano una grande forza lavoro
gratuita). La pressione sull'opinione pubblica è ben applicata da Joseph Goebbels
(uno dei più importanti
gerarchi nazisti, responsabile del Ministero della Propaganda nel Terzo Reich ),che
suddivide il ministero in dette sezioni: propaganda, radio, stampa, cinema,
teatro, musica e arti figurative. Naturalmente tutto deve tendere all'
esaltazione del regime e viene dichiarata guerra aperta agli intellettuali non
allineati. Anche il nazismo, come tutti i totalitarismi, riserva grande
importanza all'educazione e all'istruzione dei giovani; la Hitler-Jugend è
un'organizzazione che ha proprio lo scopo di inquadrare e formare i futuri perfetti
esponenti della specie umana superiore, utilizzando un'attenta sorveglianza
sulla scuola: il giovane dovrà sviluppare un forte spirito di corpo e una
solidarietà che eliminerà ogni differenza di censo e renderà possibile la più
completa identità collettiva nella comunità dei camerati. Per quanto riguarda infine
la politica economica, il nazismo subordina l'economia alla politica; i tempi e
i modi della produzione sono dettati unicamente in vista dell'assoluto dominio
del regime sul mondo, dominio assicurato al Reich dalla vittoria in guerra,
tutto sempre nell'ottica dell'estrema aggressività del nazismo; viene promossa
una politica di riarmo, per cui si ha un forte sviluppo del settore bellico che
può così assorbire parte dei disoccupati, aumentati di molto in seguito alle
crisi del decennio precedente. Inoltre il regime investe moltissimo in opere
pubbliche come canali e in particolare vie di comunicazione come strade e
autostrade, utili sia per dare lavoro a molte persone, sia per agevolare gli
spostamenti interni dell'esercito.
Nell'anno
della grande crisi si presenta per la prima volta alle elezioni politiche
Hitler col suo partito, ma riceve soltanto il 3,2% dei voti. In seguito però la
grande depressione determina in Germania un sempre più rapido deterioramento
della situazione politica con un susseguirsi di deboli governi di coalizione,
fino a quando la NSDAP di Hitler nel '33 non ottiene il 37% dei voti. Ormai il
partito hitleriano rappresenta una discreta quantità del Parlamento e non è più
una realtà sottovalutabile: Hitler diventa così cancelliere e gli viene
affidato l'incarico di formare il nuovo governo. Alla fine del '33 la
Repubblica di Weimar non esiste più. Come ha fatto Hitler a guadagnare così
tanto consenso nel giro di soli due anni? Per prima cosa egli presentava un
programma di enorme forza ed energia, nonché innovativo. Nell'opera Mein Kampf,
egli parla di una lotta cosmica e di una missione universale del popolo
tedesco: quella di promuovere un'umanità superiore, di eliminare i popoli
inferiori, deboli e impuri. Hitler, infatti, occupandosi di eugenetica, la scienza
che studia il miglioramento della razza umana, dichiara quella ariana come la
migliore in Europa. Inoltre la NSDAP si faceva portavoce del risentimento della
popolazione tedesca nei confronti della Francia sia in seguito alla bruciante
sconfitta della I guerra mondiale, sia all'imposizione del pagamento dei danni
causati dalla guerra in Europa. Questo sentimento veniva tradotto in un
imperialismo aggressivo volto alla conquista dell'est europeo: Hitler infatti
credeva che ogni nazione avesse diritto ad un proprio spazio vitale e che
quello della Germania dovesse essere ampliato, poiché molti popoli di lingua
tedesca si trovavano fuori dai confini dello Stato e soprattutto in Austria,
Polonia e negli altri Paesi dell'est. La NSDAP proponeva anche ai tedeschi
l'ideale della comunità di popolo, una società unita dal vincolo della nazione,
della storia, della lingua che non abbia nessun conflitto al suo interno ma che
sia unita verso fini comuni; nell'ottica della ricerca di questa compattezza,
il partito nazista individua anche un nemico, responsabile delle crisi subite
finora, interno alla patria e quindi da espellere: i marxisti, i finanzieri e
gli ebrei. Hitler rappresenta una novità nel panorama politico dell'epoca e il
suo partito riesce ad ottenere un gran numero di voti anche perché ormai un
vasto numero di elettori non si fida più dei partiti tradizionali, che si erano
dimostrati inetti nei confronti della crisi. Il primo governo presieduto da
Hitler è un governo di coalizione, ma il suo scopo è quello di accentrare il
potere nelle sue mani con una rivoluzione. Per prima cosa inizia a sospendere
gli articoli della Costituzione a favore dei diritti dei cittadini, per dare al
governo la possibilità di vietare ogni libertà di stampa, di opinione e di associazione.
Inoltre crea un corpo di polizia ausiliaria formato da SA (squadre d'azione) e
SS (guardie del corpo di Hitler), corpi paramilitari alle dipendenze dei
nazisti, per il quale è legittimo compiere ogni atto di violenza. Il 27
febbraio '33 scoppia un incendio al Reichstag, la sede del Parlamento: sono
accusati i comunisti che con l'incendio vogliono avviare la rivoluzione. Questo
episodio dà il via ad una furibonda repressione dell'opposizione con arresti di
massa e assassinii. Nello stesso anno continua la politica sui due fronti
(quello del consenso e quello della violenza) del nazismo: da una parte al
governo vengono attribuiti pieni poteri per il bene dello Stato, viene creato
il Ministero per l'Istruzione Popolare e la Propaganda (affidato a Goebbels),
sono organizzate parate e manifestazioni; dall'altro, le SS e le SA continuano
con assassinii, pestaggi, arresti e deportazioni di Ebrei (è proprio l'8 marzo
che è realizzato il primo campo di concentramento a Dachau). Entro la fine del
'33 sono eliminati tutti i partiti eccetto quello nazista, che può così
presentarsi da solo alle successive elezioni. Inoltre vengono anche eliminati
tutti i capi delle SA, perché sotto il controllo di Rhom, non avevano
dimostrato una piena fedeltà nei confronti del cancelliere, così Hitler si
libera totalmente dei pericoli di colpi di stato, dimostrando inoltre di essere
un capo duro ma giusto e di punire le SA che avevano compiuto violenze sulla
popolazione. Nel '34 il Presidente Hindemburg muore. La carica è assunta da
Hitler che vede concentrati nelle sue mani tutti i poteri dello Stato, compreso
l'esercito. Il Fuhrer può cominciare la deportazione e l'eliminazione di altri
nemici della razza come disabili, omosessuali, zingari e nel 1935 sono
proclamate le leggi di Norimberga, leggi che privano gli ebrei di ogni
cittadinanza e ogni diritto da essa derivante. Con le sempre più numerose
deportazioni di ebrei, il regime si vede obbligato alla costruzione di altri
campi di concentramento sia per i lavori forzati, sia per lo sterminio di massa
dei prigionieri (per rafforzare l'economia vengono ampliati i rastrellamenti di
ebrei che nei campi di concentramento costituivano una grande forza lavoro
gratuita). La pressione sull'opinione pubblica è ben applicata da Joseph Goebbels
(uno dei più importanti
gerarchi nazisti, responsabile del Ministero della Propaganda nel Terzo Reich ),che
suddivide il ministero in dette sezioni: propaganda, radio, stampa, cinema,
teatro, musica e arti figurative. Naturalmente tutto deve tendere all'
esaltazione del regime e viene dichiarata guerra aperta agli intellettuali non
allineati. Anche il nazismo, come tutti i totalitarismi, riserva grande
importanza all'educazione e all'istruzione dei giovani; la Hitler-Jugend è
un'organizzazione che ha proprio lo scopo di inquadrare e formare i futuri perfetti
esponenti della specie umana superiore, utilizzando un'attenta sorveglianza
sulla scuola: il giovane dovrà sviluppare un forte spirito di corpo e una
solidarietà che eliminerà ogni differenza di censo e renderà possibile la più
completa identità collettiva nella comunità dei camerati. Per quanto riguarda infine
la politica economica, il nazismo subordina l'economia alla politica; i tempi e
i modi della produzione sono dettati unicamente in vista dell'assoluto dominio
del regime sul mondo, dominio assicurato al Reich dalla vittoria in guerra,
tutto sempre nell'ottica dell'estrema aggressività del nazismo; viene promossa
una politica di riarmo, per cui si ha un forte sviluppo del settore bellico che
può così assorbire parte dei disoccupati, aumentati di molto in seguito alle
crisi del decennio precedente. Inoltre il regime investe moltissimo in opere
pubbliche come canali e in particolare vie di comunicazione come strade e
autostrade, utili sia per dare lavoro a molte persone, sia per agevolare gli
spostamenti interni dell'esercito.
I principi filosofici del nazismo
POPPER E NIETZSCHE
Alcune idee, adatte a giustificarne la politica :
Un individuo non ha nessun valore se non nello Stato
La sovranità dello Stato non deriva dal popolo ma dallo Stato stesso
La sovranità statale si incarna in una classe di funzionari
Lo stato deve permeare tutte le manifestazioni della vita comune
Non esiste nessun diritto internazionale al di sopra dello Stato
Lo stato è l'Assoluto stesso, un principio collettivo che detiene il primato assoluto sull'individuo.
Mussolini e la costruzione dello stato totalitario italiano
Benito Mussolini Dovia di Predappio, 29 luglio 1883
- Giulino di Mezzegra, 28 aprile 1945
 Il
28 ottobre 1922 è indetta la Marcia su Roma, dove tutte le milizie fasciste si
sarebbero dirette verso la capitale. Il Primo Ministro Facta voleva dichiarare
lo stato d'assedio (poiché l'esercito avrebbe potuto facilmente sbaragliare le
squadre) ma il Re si rifiuta di proclamarlo; quindi Mussolini può entrare
facilmente a Roma, presentarsi dal Re ed essere investito della carica di
Presidente del Consiglio, come voleva la tradizione dello Statuto Albertino. Mussolini
quindi si pone come uomo rispettoso della legge italiana, capace di riportare
l'ordine all'interno dello Stato. Inizialmente il Duce ha il compito di formare
un governo, che sarà di coalizione di centro-destra, e in seguito istituisce il
Gran Consiglio del Fascismo, un organo al vertice del partito fascista e dello
Stato, presieduto dallo stesso Mussolini. Inoltre disciplina e legalizza il
movimento squadrista, facendolo confluire nella Milizia Volontaria di Sicurezza
Nazionale, cioè un corpo che avrebbe dovuto affiancare la polizia, i
carabinieri, ecc.. In seguito è approvata la legge Acerbo: il partito che
avesse avuto la maggioranza relativa del 25% alle successive elezioni avrebbe
avuto il 66% dei seggi in Parlamento. Le elezioni del '24 si svolgono in un
clima di terrore, in quanto le squadre fasciste presiedevano i seggi elettorali
con atteggiamenti intimidatori, e il 'listone' fascista (una lista
proposta dal PNF con anche membri liberali e popolari) vince le elezioni.
Matteotti, un deputato socialista, decide però in Parlamento di denunciare il
clima di terrore in cui si erano svolte le elezioni. Poco dopo verrà ritrovato
morto. A questo punto l'opposizione si ritira dalla Camera, chiedendo anche
l'intervento del Re che però non agisce, naturalmente questo invece di scoraggiare
il Duce e fargli diminuire popolarità lo rafforza perché non aveva più
oppositori politici. Nonostante il momento difficile, Mussolini continua ad
applicare una tattica bifronte: da una parte prende la strada della
'normalizzazione' prendendo misure più moderate per calmare la troppa
irruenza di alcuni dei suoi seguaci più 'estremi'; dall'altra lancia
minacce e limita la libertà di stampa. Il 3 gennaio 1925 Mussolini, rendendosi
conto che ormai l'opposizione non può più nulla contro di lui, spiazza tutti
con un discorso tenuto alla Camera: 'Io
assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è
avvenuto. Il governo è abbastanza forte per stroncare la sedizione
dell'Aventino. L'Italia, o signori, vuole la tranquillità, vuole la calma
laboriosa. Noi questa tranquillità, questa calma laboriosa gliela daremo con
l'amore, se è possibile, con la forza, se sarà necessario.' Inizia qui
la Dittatura del fascismo: sono imbavagliati i giornali di opposizione, sciolte
organizzazioni 'sovversive', arresti e pestaggi di oppositori. A
dicembre sono emanate le 'leggi fascistissime': sono sciolti tutti i
partiti, sono vietate le associazioni non fasciste e sono attribuiti poteri
speciali al Presidente del Consiglio, tra cui anche quello di veto su qualsiasi
legge proposta dalla Camera, e d'ora in poi alle elezioni sarà sempre proposta
dal regime una lista unica. Sempre nel '25 sono sciolti tutti i sindacati
socialisti tranne Confindustria che viene obbligata a trattare solo coi
sindacati fascisti. Per quanto riguarda la politica economica dell'Italia,
visto che la guerra aveva lasciato all'Italia un'estrema debolezza e fragilità
finanziaria, il governo fascista si impegna ad attuare una politica
deflazionistica. Sin dal 1925 è anche promossa la 'Battaglia del
Grano', per assicurare al Paese il fabbisogno di grano, causando una
diminuzione delle importazioni. Un'altra iniziativa è quella della
'bonifica integrale', che si propone di recuperare all'agricoltura
tutto il suolo nazionale; sono eliminate terre paludose in Emilia-Romagna, nel
Veneto, nel Lazio, in Campania, in Puglia, in Calabria, in Sicilia e in
Sardegna. Inoltre lo Stato, per rispondere alla crisi del '29, istituirà dei
grossi enti (come l'IMI o l'IRI) con lo scopo di trovare fondi alle industrie
in via di fallimento o di comprare e statalizzare parti di industrie che
stavano per fallire. Il regime ha quindi spesso dimostrato di applicare una
politica economica interventista e una presenza sempre più
'totalitaria' del potere politico sull'economia. Per quanto riguarda
la politica estera del fascismo, il regime ha cercato di ampliare i
possedimenti coloniali italiani riconquistando prima di tutto Libia e Albania e
in seguito attaccando e sconfiggendo l'Etiopia, presentando agli italiani
questa guerra come un'impresa civilizzatrice da parte di un popolo superiore
nei confronti di un popolo inferiore, rozzo e sporco. La Società delle Nazioni,
visto l'attacco dell'Italia ad un altro Stato indipendente, multò questa con
sanzioni economiche. Questo significava che l'Italia doveva produrre da sola
ciò che prima era abituata ad importare; Mussolini ne approfitta quindi per
lanciare una politica di 'autarchia': l'Italia sarebbe dovuta
diventare autosufficiente e produrre tutto da sola senza l'aiuto di quelle
potenze europee che, erano considerate ipocrite poiché penalizzavano l'Italia,
che voleva andare a conquistare una piccola colonia, quando loro possedevano i
due più grandi imperi coloniali del mondo. Il regime inoltre cerca di
assoggettare a sé le masse con l'Opera Nazionale del Dopolavoro, i circoli
diffondono l'interesse e la pratica dello sport, in particolare del ciclismo,
del calcio e del gioco delle bocce, ma soprattutto si propongono di formare un
nuovo tipo di cittadino, integrato nella società di massa, virile, ben
socializzato e con un forte spirito i solidarietà di gruppo. Inoltre il
fascismo è ben consapevole dell'importanza dell'istruzione (soprattutto della
scuola elementare, obbligatoria per tutti), per la creazione del consenso; essa
infatti diventa uno degli strumenti più preziosi e importanti di coinvolgimento
di tutti nell'accettazione e addirittura nell'esaltazione dello Stato e del suo
capo. Viene fondata inoltre l'Opera Nazionale Balilla che si occupa dei giovani
dai sei ai diciotto anni, impegnandoli in attività ginniche, sportive e
premilitari(con grandi risultati e affermazioni sportive a livello mondiale),
confidando nel carattere formativo dell'agonismo (tipico dello sport) che
esalta la prestanza e la potenza fisica, connotati indispensabili del virile
uomo fascista. Infine bisogna ricordare che il fascismo, come ogni
totalitarismo, si è subito impadronito completamente di ogni mezzo di
comunicazione (stampa, radio, cinegiornali) per produrre documenti col compito
di dare del regime un' immagine giusta e coinvolgente.
Il
28 ottobre 1922 è indetta la Marcia su Roma, dove tutte le milizie fasciste si
sarebbero dirette verso la capitale. Il Primo Ministro Facta voleva dichiarare
lo stato d'assedio (poiché l'esercito avrebbe potuto facilmente sbaragliare le
squadre) ma il Re si rifiuta di proclamarlo; quindi Mussolini può entrare
facilmente a Roma, presentarsi dal Re ed essere investito della carica di
Presidente del Consiglio, come voleva la tradizione dello Statuto Albertino. Mussolini
quindi si pone come uomo rispettoso della legge italiana, capace di riportare
l'ordine all'interno dello Stato. Inizialmente il Duce ha il compito di formare
un governo, che sarà di coalizione di centro-destra, e in seguito istituisce il
Gran Consiglio del Fascismo, un organo al vertice del partito fascista e dello
Stato, presieduto dallo stesso Mussolini. Inoltre disciplina e legalizza il
movimento squadrista, facendolo confluire nella Milizia Volontaria di Sicurezza
Nazionale, cioè un corpo che avrebbe dovuto affiancare la polizia, i
carabinieri, ecc.. In seguito è approvata la legge Acerbo: il partito che
avesse avuto la maggioranza relativa del 25% alle successive elezioni avrebbe
avuto il 66% dei seggi in Parlamento. Le elezioni del '24 si svolgono in un
clima di terrore, in quanto le squadre fasciste presiedevano i seggi elettorali
con atteggiamenti intimidatori, e il 'listone' fascista (una lista
proposta dal PNF con anche membri liberali e popolari) vince le elezioni.
Matteotti, un deputato socialista, decide però in Parlamento di denunciare il
clima di terrore in cui si erano svolte le elezioni. Poco dopo verrà ritrovato
morto. A questo punto l'opposizione si ritira dalla Camera, chiedendo anche
l'intervento del Re che però non agisce, naturalmente questo invece di scoraggiare
il Duce e fargli diminuire popolarità lo rafforza perché non aveva più
oppositori politici. Nonostante il momento difficile, Mussolini continua ad
applicare una tattica bifronte: da una parte prende la strada della
'normalizzazione' prendendo misure più moderate per calmare la troppa
irruenza di alcuni dei suoi seguaci più 'estremi'; dall'altra lancia
minacce e limita la libertà di stampa. Il 3 gennaio 1925 Mussolini, rendendosi
conto che ormai l'opposizione non può più nulla contro di lui, spiazza tutti
con un discorso tenuto alla Camera: 'Io
assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è
avvenuto. Il governo è abbastanza forte per stroncare la sedizione
dell'Aventino. L'Italia, o signori, vuole la tranquillità, vuole la calma
laboriosa. Noi questa tranquillità, questa calma laboriosa gliela daremo con
l'amore, se è possibile, con la forza, se sarà necessario.' Inizia qui
la Dittatura del fascismo: sono imbavagliati i giornali di opposizione, sciolte
organizzazioni 'sovversive', arresti e pestaggi di oppositori. A
dicembre sono emanate le 'leggi fascistissime': sono sciolti tutti i
partiti, sono vietate le associazioni non fasciste e sono attribuiti poteri
speciali al Presidente del Consiglio, tra cui anche quello di veto su qualsiasi
legge proposta dalla Camera, e d'ora in poi alle elezioni sarà sempre proposta
dal regime una lista unica. Sempre nel '25 sono sciolti tutti i sindacati
socialisti tranne Confindustria che viene obbligata a trattare solo coi
sindacati fascisti. Per quanto riguarda la politica economica dell'Italia,
visto che la guerra aveva lasciato all'Italia un'estrema debolezza e fragilità
finanziaria, il governo fascista si impegna ad attuare una politica
deflazionistica. Sin dal 1925 è anche promossa la 'Battaglia del
Grano', per assicurare al Paese il fabbisogno di grano, causando una
diminuzione delle importazioni. Un'altra iniziativa è quella della
'bonifica integrale', che si propone di recuperare all'agricoltura
tutto il suolo nazionale; sono eliminate terre paludose in Emilia-Romagna, nel
Veneto, nel Lazio, in Campania, in Puglia, in Calabria, in Sicilia e in
Sardegna. Inoltre lo Stato, per rispondere alla crisi del '29, istituirà dei
grossi enti (come l'IMI o l'IRI) con lo scopo di trovare fondi alle industrie
in via di fallimento o di comprare e statalizzare parti di industrie che
stavano per fallire. Il regime ha quindi spesso dimostrato di applicare una
politica economica interventista e una presenza sempre più
'totalitaria' del potere politico sull'economia. Per quanto riguarda
la politica estera del fascismo, il regime ha cercato di ampliare i
possedimenti coloniali italiani riconquistando prima di tutto Libia e Albania e
in seguito attaccando e sconfiggendo l'Etiopia, presentando agli italiani
questa guerra come un'impresa civilizzatrice da parte di un popolo superiore
nei confronti di un popolo inferiore, rozzo e sporco. La Società delle Nazioni,
visto l'attacco dell'Italia ad un altro Stato indipendente, multò questa con
sanzioni economiche. Questo significava che l'Italia doveva produrre da sola
ciò che prima era abituata ad importare; Mussolini ne approfitta quindi per
lanciare una politica di 'autarchia': l'Italia sarebbe dovuta
diventare autosufficiente e produrre tutto da sola senza l'aiuto di quelle
potenze europee che, erano considerate ipocrite poiché penalizzavano l'Italia,
che voleva andare a conquistare una piccola colonia, quando loro possedevano i
due più grandi imperi coloniali del mondo. Il regime inoltre cerca di
assoggettare a sé le masse con l'Opera Nazionale del Dopolavoro, i circoli
diffondono l'interesse e la pratica dello sport, in particolare del ciclismo,
del calcio e del gioco delle bocce, ma soprattutto si propongono di formare un
nuovo tipo di cittadino, integrato nella società di massa, virile, ben
socializzato e con un forte spirito i solidarietà di gruppo. Inoltre il
fascismo è ben consapevole dell'importanza dell'istruzione (soprattutto della
scuola elementare, obbligatoria per tutti), per la creazione del consenso; essa
infatti diventa uno degli strumenti più preziosi e importanti di coinvolgimento
di tutti nell'accettazione e addirittura nell'esaltazione dello Stato e del suo
capo. Viene fondata inoltre l'Opera Nazionale Balilla che si occupa dei giovani
dai sei ai diciotto anni, impegnandoli in attività ginniche, sportive e
premilitari(con grandi risultati e affermazioni sportive a livello mondiale),
confidando nel carattere formativo dell'agonismo (tipico dello sport) che
esalta la prestanza e la potenza fisica, connotati indispensabili del virile
uomo fascista. Infine bisogna ricordare che il fascismo, come ogni
totalitarismo, si è subito impadronito completamente di ogni mezzo di
comunicazione (stampa, radio, cinegiornali) per produrre documenti col compito
di dare del regime un' immagine giusta e coinvolgente.
Un totalitarismo imperfetto
Il regime fascista, però, a differenza degli altri regimi totalitari, non riuscì mai ad esercitare un totale controllo sulle masse e sulla società italiana, poiché il suo potere era fortemente limitato da due forti istituzioni: la Corona e la Chiesa. Per quanto riguarda il Re, egli non si dimostrò mai un effettivo pericolo per Mussolini, anche perché non intervenne mai contro di lui. Non bisogna dimenticare comunque che egli era il capo dell'esercito, un esercito di italiani che aveva giurato fedeltà al monarca e non al duce. Per quanto riguarda la Chiesa essa era un'entità molto forte in Italia vista anche la sede a Roma del Vaticano e la forte presenza di cattolici nel Paese, Mussolini cercò di prendere subito accordi col Papa, per evitare che questi intervenisse a suo svantaggio. Così nel '29 il cardinale Gasparri e Mussolini sanciscono i 'Patti Lateranensi', che includono vari provvedimenti:
Un trattato chiude la questione romana con il reciproco riconoscimento delle legittime sovranità nazionali: al Papa spetta la Città del Vaticano, al Re e al governo spetta l'Italia.
Lo Stato italiano si impegna a risarcire in denaro la Chiesa per la perdita dei territori dell'ex Stato della Chiesa.
Con il Concordato vengono accordati particolari privilegi all'interno dell'Italia in favore della religione cattolica: il suo insegnamento sarà obbligatorio all'interno della scuola, il matrimonio cattolico sarà riconosciuto anche con valore civile, gli espulsi dall'ambito ecclesiastico per opera della Chiesa stessa non avrebbero avuto incarichi pubblici statali, ecc. .
In ogni caso, il fascismo si è dimostrato più debole degli altri regimi anche perché, mentre nazismo e stalinismo hanno sempre cercato di subordinare lo Stato al partito, in Italia è avvenuto il contrario: al centro del regime c'era lo Stato. Inoltre, mentre gli altri regimi totalitari hanno cercato di organizzare la società in modo che la sovranità fosse interamente nelle mani del potere esecutivo o dell'apparato amministrativo, totalmente assoggettato al regime, in Italia ciò non è stato reso possibile per la volontà di Mussolini di fondare un sistema con i consensi del popolo italiano.
 |
| Appunti su: |
|
| Appunti Astronomia cosmologia |  |
| Tesine Architettura |  |
| Lezioni Archeologia |  |