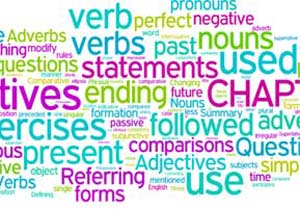LE IDEE POLITICHE DI DANTE
Durante il suo viaggio Dante incontra molti
personaggi famosi, tra cui alcune personalità politiche attraverso le quali
espone le proprie idee sull'argomento. Il primo di questi personaggi è Ciacco, nel VI canto dell'Inferno. Egli si trova nel primo
regno poiché era stato condannato per il peccato, frutto dell'ingordigia che
chiude l'uomo nell'individualismo e corrompe le sue qualità. Questo peccato si
rivela essere affine alla cupidigia che distrugge la società civile, di cui l'esempio
più vicino a Dante è senza dubbio la situazione di Firenze. Ciacco
è molto significativo perché visse nella Firenze antica, che il poeta sogna di
veder rinascere. Dante pone a questo personaggio tre domande: quale sarà la
sorte di Firenze; se c'è speranza in qualcuno; qual è la ragione della
discordia civile. Nella sua risposta Ciacco mette in
evidenza le cause dei problemi sociali della città:la superbia degli
aristocratici, che vogliono conservare i loro poteri e privilegi, l'avidità
della classe borghese, l'invidia del popolo, che si inserisce in un modo molto
violento tra le due parti. Egli svela anche il futuro che coinvolgerà Firenze:
la città sarà, ancora per molto tempo, dilaniata dalle lotte interne tra le
varie fazioni.
Continuando il suo viaggio, Dante, nel VI
canto del Purgatorio, assiste all'incontro dei due mantovani (Virgilio e Sordello). A questo punto egli fa una digressione che
scaturisce dal contrasto che c'è tra l'affetto dei due compatrioti morti e
l'odio tra gli italiani vivi, non solo tra le città, ma anche all'interno di
una stessa città. Alla base troviamo il tema della discordia e del male e non
l'amore per la patria. Sordello definisce l'Italia
non come "donna di province, ma bordello". Egli prosegue con una denuncia verso
l'origine del male che coinvolge rutta l'Italia: la padrona del mondo è vista
ora come un cavallo che ha sia briglie che freno (le leggi), ma è senza
cavaliere, poiché i papi impediscono agli imperatori di salire in sella per
poter guidare essi stessi il cavallo, che, non protetto dagli sproni, si
imbizzarrisce. Questa teoria richiama alla teoria dei due soli, che viene
esposta nel De Monarchia. Essi separati l'uno dall'altro, rappresentano la
chiesa e l'impero, che devono guidare gli uomini verso la beatitudine, il primo
eterna, il secondo terrena. Difatti la società deve essere guidata da due
figure: il Papa, che conduce l'uomo alla salvezza attraverso le Sacre
Scritture; e l'imperatore che guida gli uomini nella vita terrena attraverso la
filosofia.
Il VI canto del Paradiso accoglie interamente
il discorso di Giustiniano, del quale colpisce immediatamente l'invettiva
contro i guelfi e i ghibellini, i primi colpevoli di aver travisato il
significato del potere imperiale a proprio vantaggio essendone i sostenitori; i
secondi, invece, colpevoli di averlo addirittura contrastato. Giustiniano
celebra l'impero romano considerandolo uno strumento provvidenziale
dell'organizzazione politica della cristianità, essendo stato l'autore del
Corpus Iuris Civilis.
L'impero è quindi necessario per garantire un futuro di pace, attraverso la
riunificazione religiosa di esso. Bisogna perciò dare grande merito a Dante per
la sua capacità di rendere la politica vera storia.