 |
|
| Appunti scientifiche |
|
 |
|
| Appunti scientifiche |
|
| Visite: 7026 | Gradito: |
Leggi anche appunti:Reazioni di ossidoriduzioneReazioni di ossidoriduzione Ossidazione - Un elemento chimico si ossida quando, IdrogenoIDROGENO Chimica 2 Idrogeno L'idrogeno era conosciuto sotto il Titolazione acido forte - base forteTITOLAZIONE ACIDO FORTE - BASE FORTE TITOLAZIONE Metodo chimico |
 |
 |
Quando un acido debole è molto diluito e/o molto debole non è possibile trascurare, nel calcolo del pH, la concentrazione degli ioni H+ provenienti dalla dissociazione dell'acqua.
L'equilibrio dell'acido e dell'acqua si disturbano reciprocamente.
La quantità di acido che si dissocia è infatti inferiore rispetto a quel che avremo calcolato senza tener conto dell'acqua, a causa degli ioni H+ prodotti dall'acqua che spostano verso sinistra l'equilibrio dell'acido.
In modo analogo l'acqua si dissocia meno per la presenza degli ioni H+ generati dall'acido.
Il pH si calcola sommando gli ioni H+ generati dall'acqua agli ioni H+ generati dall'acido.
Indichiamo allora con x la concentrazione di ioni H+ generati dall'acido e con y la concentrazione di ioni H+ generati dall'acqua. La concentrazione totale di ioni H+ sarà (x + y) e tale quantità dovrà soddisfare contemporaneamente l'equilibrio dell'acido e l'equilibrio dell'acqua.
Ora consideriamo un generico acido debole HA di concentrazione iniziale C e costante di dissociazione acida Ka. L'acido si dissocia, in presenza di y ioni H+ dell'acqua, in x ioni H+ ed x ioni A-.
Scriviamo dunque l'equilibrio dell'acido riportando sotto ogni specie chimica le concentrazioni di equilibrio
HA → H+ + A-
C - x x + y x
Consideriamo ora l'equilibrio dell'acqua che si dissocia, in presenza degli x ioni H+ provenienti dalla dissociazione dell'acido, in y ioni H+ ed y ioni OH-. Scriviamo dunque l'equilibrio dell'acqua riportando sotto ogni specie chimica le concentrazioni di equilibrio
H2O → H+ + OH-
55,55 - y x + y y
Scriviamo ora le rispettive relazioni di equilibrio, sostituendo opportunamente le concentrazioni di equilibrio
![]()
![]()
Dalla relazione 2) ricaviamo il valore della ![]() che sostituiamo
nella 1) ottenendo la seguente equazione di terzo grado in y
che sostituiamo
nella 1) ottenendo la seguente equazione di terzo grado in y
![]()
Calcoliamo ad esempio il pH di una soluzione 0.5 M di un acido debole con ka = 10-14.
l'equazione 3) fornisce y = [H+]acqua = 8,1650 10-8 M
Si noti che l'acqua in assenza dell'acido produce una concentrazione di ioni H+ pari a 10-7 mol/L, mentre qui, a causa della presenza dell'acido, ne produce solo 8,1650 10-8 mol/L
Ora usiamo il valore trovato della y per sostituirlo nella 2) e calcolare il valore della x (concentrazione di ioni H+ generata dall'acido)
![]()
da cui
x = [H+]acido = 4,0825 ·10-8 M
Si noti che se avessimo calcolato la concentrazione di ioni H+ generata dall'acido senza considerare l'acqua, utilizzando l'equazione di secondo grado, avremo trovato un valore superiore, pari a
![]()
![]()
x = [H+] = 7,0711 ·10-8 M
L'acido si dissocia quindi meno di quanto farebbe in assenza degli ioni H+ generati dall'acqua. Tuttavia se considerassimo solo gli ioni H+ dell'acido commetteremmo in questo caso un errore. Si noti infatti come la concentrazione di ioni H+ prodotta dall'acido sia dello stesso ordine di grandezza di quella proveniente dall'acqua. E dunque quest'ultima non possa essere trascurata.
La concentrazione totale di ioni H+ è quindi pari a
y + x = [H+]acqua + [H+]acido = 8,1650 10-8 + 4,0825 10-8 = 1.225 10-7 M
che porta ad un pH = 6.91
Se avessimo considerato solo l'equilibrio dell'acido saremmo arrivati al risultato palesemente assurdo di un pH basico (pH = - log 7,0711 ·10-8 = 7.15)
L'equazione 3) ci permette di calcolare in modo esatto la concentrazione di ioni H+ generata dall'acqua e di sommarla successivamente agli ioni H+ prodotti dall'acido debole per ottenere la concentrazione totale degli ioni H+.
E' tuttavia possibile ricavare un'equazione che fornisca direttamente la concentrazione totale degli ioni H+. Per trovarla riconsideriamo i due equilibri che dobbiamo analizzare e che si disturbano reciprocamente, quello dell'acido debole e quello dell'acqua.
HA → H + + A-
H2O → H + + OH -
Nei due equilibri compaiono le seguenti 4 incognite.
1) [H+] 2) [OH -] 3) [HA] 4) [A-]
Dobbiamo pertanto scrivere 4 equazioni indipendenti nelle 4 incognite.
La prima e la seconda equazione si ricavano dalle relazioni di equilibrio rispettivamente dell'acido e dell'acqua
a)
![]()
b)
![]()
la terza si ottiene dal bilancio delle cariche (la somma di tutte le cariche positive deve essere uguale alla somma di tutte le cariche negative)
c)
![]()
la quarta si ricava infine dal bilancio di massa (il numero iniziale C di molecole dell'acido deve essere uguale alla somma delle molecole di acido indissociato HA e delle molecole di acido dissociato A- all'equilibrio)
d)
![]()
Ricaviamo ora ![]() dalla relazione
d) e sostituiamo nella relazione a)
dalla relazione
d) e sostituiamo nella relazione a)
e) ![]()
Ricaviamo ![]() dalla relazione
c) e sostituiamo nella e)
dalla relazione
c) e sostituiamo nella e)
f) ![]()
Si ricava infine ![]() dalla relazione
b) e si sostituisce nella f) che, riordinata, fornisce
dalla relazione
b) e si sostituisce nella f) che, riordinata, fornisce
![]()
un'equazione di terzo grado che ci permette di calcolare il valore esatto della concentrazione totale di ioni H+ per una soluzione qualsiasi di un acido debole.
È evidente che risolvere un'equazione di terzo grado non è affatto una prospettiva allettante. Vediamo allora se è possibile sostituirla con metodi risolutivi più semplici, anche se, ovviamente, approssimati. Consideriamo i casi in cui non è applicabile il metodo semplificato e dunque in cui
C·ka < 10-12 e ![]() < 102
< 102
Caso 1) Acidi debolissimi Ka ≤ 10-7 (e C·Ka < 10-12 )
Consideriamo l'equazione risolutiva esatta di terzo grado (equazione 4) e dividiamola per la concentrazione degli ioni H+, ottenendo
![]()
Verifichiamo ora come, nelle condizioni considerate (Ka ≤ 10-7),
i termini ![]() e
e ![]() risultino
entrambi più piccoli e quindi trascurabile rispetto al termine Kw.
risultino
entrambi più piccoli e quindi trascurabile rispetto al termine Kw.
Infatti, essendo la soluzione acida, si avrà [H+] > 10-7 ed essendo Ka ≤ 10-7 quindi ![]() dunque
dunque
![]()
Inoltre, essendo C·Ka ≤ 10-12, la concentrazione degli ioni H+ deve essere non molto diversa da 10-7 per cui
![]() ≈ ka 10-7 < 10-14
≈ ka 10-7 < 10-14
che è ciò che volevamo verificare.
Possiamo dunque trascurare i termini
![]() e
e ![]() e l'equazione 5)
può quindi essere ridotta di grado. diventando
e l'equazione 5)
può quindi essere ridotta di grado. diventando
![]()
e la concentrazione degli ioni H+ è calcolabile con la seguente formula semplificata
![]()
Proviamo ad applicare tale formula risolutiva all'esempio precedente: una soluzione 0.5 M di un acido debole con Ka = 10-14, che avevamo risolto utilizzando l'equazione di terzo grado ottenendo
[H+] = 1.225 10-7 M e pH = 6.91
In questo caso il prodotto C·Ka = 0.5 10-14
è inferiore a 10-12 Ciò significa che gli ioni H+
generati dall'acqua non sono trascurabili rispetto a quelli prodotti dall'acido
e non possiamo pertanto utilizzare la relazione semplificata ![]() (la quale
fornirebbe [H+] = 7.07 10-8 M ed un pH = 7.15, basico!!).
(la quale
fornirebbe [H+] = 7.07 10-8 M ed un pH = 7.15, basico!!).
Applicando invece la formula 6) otteniamo
![]() 1.225 10-7 M e pH = 6.91
1.225 10-7 M e pH = 6.91
Il medesimo risultato ottenuto con l'equazione di terzo grado!!! Non male.
Caso 2) Acidi deboli molto diluiti Ka > 10-7 e C ≤ 10-7
Per acidi così diluiti il grado di dissociazione risulta molto elevato. Se Ka > 10-7 e C ≤ 10-7 il rapporto C/ka risulta essere infatti inferiore all'unità ed il grado di dissociazione superiore al 70%. In queste condizioni l'acido, pur rimanendo un acido debole, può essere trattato come un acido forte completamente dissociato. Possiamo cioè calcolare come si comporta l'equilibrio dell'acqua in presenza di C ioni H+ prodotti dall'acido debole completamente dissociato
HA → H+ + A-
C - C + C + C
H2O → H+ + OH-
55,55 - x x + C x
Kw = [H+] [OH-] = (x + C) x
x2 + Cx - Kw = 0
![]()
e la concentrazione degli ioni H+ totale è calcolabile con la seguente formula
![]()
3) Acidi deboli che non ricadono nei casi precedenti Ka > 10-7 e C > 10-7 (e C/·ka < 102 )
Consideriamo il caso di un acido debole che non ricada nei casi precedenti (per i quali abbiamo già individuato una formula risolutiva semplificata).
Consideriamo ancora l'equazione risolutiva esatta di terzo grado (equazione 4) divisa per la concentrazione degli ioni H+
![]()
è possibile verificare come, nelle condizioni considerate il
termine ![]() risulti più
piccolo e quindi trascurabile rispetto al termine kaC.
risulti più
piccolo e quindi trascurabile rispetto al termine kaC.
Essendo infatti la soluzione acida, si avrà [H+] > 10-7
, quindi ![]()
Dunque, poiché per ipotesi C > 10-7 , allora ![]() . Moltiplicando entrambi i membri della disuguaglianza
per ka, otteniamo
. Moltiplicando entrambi i membri della disuguaglianza
per ka, otteniamo
![]()
che è quanto volevamo verificare
L'equazione può quindi essere ridotta di grado. diventando
![]()
e la concentrazione degli ioni H+ è calcolabile con la seguente formula

Possiamo dunque utilizzare 4 formule risolutive approssimate che si applicano in condizioni diverse di concentrazione (C) e di forza (ka) dell'acido.
Nello schema seguente vengono riportate le 4 formule risolutive per il calcolo della concentrazione degli ioni H+ in funzione di C e ka.

Riportiamo infine una tabella con alcuni valori di pH calcolati con le relazioni semplificate, confrontati con i valori esatti. In ogni casella è presente il vaore esatto (in nero sopra) ed il valore approssimato (in colore sotto)
|
pH |
Costante di dissociazione acida - Ka |
|||||||||||||||
|
C O N C E N T R A Z I O N E mol/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riassumendo
Per calcolare la concentrazione degli ioni H+ di una soluzione di un acido debole monoprotico è possibile utilizzare una delle quattro seguenti formule semplificate in relazione ai valori che assumono la concentrazione C e la costante di dissociazione acida ka.

 |
|
| Appunti Ingegneria tecnico |  |
| Tesine Geografia | 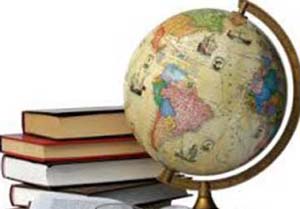 |
| Lezioni Biologia |  |