 |
|
| Appunti scientifiche |
|
 |
|
| Appunti scientifiche |
|
| Visite: 2393 | Gradito: |
Leggi anche appunti:Parallassi annue e Parallassi di gruppoParallassi annue e Parallassi di gruppo Parallassi annue Eseguendo due osservazioni Le stelleLe stelle Riferimenti per individuare le stelle: le costellazioni Sistema solareSistema solare Sistema di corpi celesti di cui fanno parte il Sole, i nove |
 |
 |
Un giorno senza un sorriso è un giorno perso
Sorriso: riso leggero, appena accennato: sorriso dolce, amabile, mesto, malinconico; sorriso di gioia, sdegno, compassione, fare, abbozzare un sorriso; avere un bel sorriso; Avere sempre il sorriso sulle labbra; avere un sorriso per tutti.
Riso: dimostrazione di ilarità, di allegria, o, talvolta, di scherno.[.] il riso fa buon sangue.
Sono partito dall'idea che, per quanto difficile fosse, il modo migliore per iniziare il mio esame e - spero - la mia vita sia con un:

E questo e' il tema sul quale ho impostato il mio lavoro, basandomi non gia' sulla vita degli autori o sulla specificità dei fatti, ma sugli effetti e le emozioni che il loro pensiero mi hanno trasmesso e le note distintive di un accaduto.........
 Il primo ''sorriso'' sul quale
ho intenzione di porre attenzione è del tutto naturale, perché è il sorriso
enigmatico, e affascinante, della luna. L'unico satellite, appunto naturale, non
gode di luce propria, ma è costituito di materiali solidi che riflettono la luce del sole. Ha forma
pressoché sferica, caratteristica non comune almeno nel nostro sistema solare (potrebbe
definirsi sistema terra-luna, quindi bi-planetario), raggio ¼ di quello medio
terrestre, e massa corrispondente ad 1/81; la densità della roccia è
leggermente maggiore di quella terrestre, sebbene quella totale sia inferiore
alla densità della terra. Sulla superficie lunare possiamo notare l'assenza di
atmosfera gassosa, che porta a diverse conseguenze, quali l'assenza di fenomeni
crepuscolari (alba,tramonto), per cui l'alternanza tra giorno e notte è molto
brusca, e il cambiamento repentino e considerevole delle temperature (si passa
dai 110° il dì e -150° la notte),e idrosfera, causa evaporazione costante e
bassa velocità di fuga; possiamo, inoltre, osservarne la scarsa luminosità, anche
nelle fasi dette di ''luna piena'', in cui solo il 7% della luce solare viene
riflessa mentre il restante 93% viene assorbito e poi espulso per irraggiamento
(sempre a causa della
Il primo ''sorriso'' sul quale
ho intenzione di porre attenzione è del tutto naturale, perché è il sorriso
enigmatico, e affascinante, della luna. L'unico satellite, appunto naturale, non
gode di luce propria, ma è costituito di materiali solidi che riflettono la luce del sole. Ha forma
pressoché sferica, caratteristica non comune almeno nel nostro sistema solare (potrebbe
definirsi sistema terra-luna, quindi bi-planetario), raggio ¼ di quello medio
terrestre, e massa corrispondente ad 1/81; la densità della roccia è
leggermente maggiore di quella terrestre, sebbene quella totale sia inferiore
alla densità della terra. Sulla superficie lunare possiamo notare l'assenza di
atmosfera gassosa, che porta a diverse conseguenze, quali l'assenza di fenomeni
crepuscolari (alba,tramonto), per cui l'alternanza tra giorno e notte è molto
brusca, e il cambiamento repentino e considerevole delle temperature (si passa
dai 110° il dì e -150° la notte),e idrosfera, causa evaporazione costante e
bassa velocità di fuga; possiamo, inoltre, osservarne la scarsa luminosità, anche
nelle fasi dette di ''luna piena'', in cui solo il 7% della luce solare viene
riflessa mentre il restante 93% viene assorbito e poi espulso per irraggiamento
(sempre a causa della  mancanza di atmosfera).
mancanza di atmosfera).
Come
la terra, anche la luna compie i movimenti di rotazione, di rivoluzione e,
insieme alla terra, quello di traslazione. Il moto di rotazione lunare è molto
lento - poco più di 27 giorni - effettuato nello stesso senso della rotazione
terrestre. La rotazione non è uniforme, data la forma ellissoidale e
l'attrazione della terra, che provoca lievi oscillazioni, dette librazioni; grazie
a queste librazioni e a quelle dette apparenti, dovute a fattori come lo
spostamento della terra nello spazio e il punto da dove la ammiriamo, riusciremo
a scorgere circa il 59% del suolo lunare. Il moto di rivoluzione implica,
invece, il movimento della luna intorno alla terra: esso si effettua in senso
antiorario se lo osserviamo dal polo nord celeste. Come anche la terra (ma
ovviamente nei confronti del sole), la luna non si trova sempre alla stessa
distanza dal pianeta attorno a cui ruota: il punto più vicino, detto perigeo, è
a  l'esterno. Potremmo inserire tra i movimenti lunari il moto che
compiono tutti i corpi del sistema solare
l'esterno. Potremmo inserire tra i movimenti lunari il moto che
compiono tutti i corpi del sistema solare  nell'espansione dell'universo,
nell'espansione dell'universo,  ma non conosciamo davvero quale
sia il futuro del nostro universo, e quindi non abbiamo dati certi.
ma non conosciamo davvero quale
sia il futuro del nostro universo, e quindi non abbiamo dati certi.
Sebbene
la luna ci rivolga sempre la stessa faccia, le condizioni di illuminazione non
sono sempre le stesse, a causa del moto che essa compie intorno alla terra e
nei confronti del sole, che, la illumina. Possiamo schematizzare quattro fasi
lunari principali: quando la luna si trova dalla stessa parte del sole
l'emisfero a noi rivolto non sarà illuminato, e avremo così la fase di
novilunio (durante questa fase la superficie lunare non sarà totalmente
oscurata poiché la terra riflette i raggi solari su di essa, che li riflette
tenuemente indietro); quando la luna si trova a formare con la terra e il sole
un triangolo rettangolo ideale si individueranno due fasi distinte nominate
primo e ultimo quarto, durante le quali la metà che vediamo verso di noi sarà
illuminata; l'ultima fase, detta plenilunio, corrisponde al fenomeno della
''luna piena'', e si ha quando la luna si trova in opposizione al sole rispetto
alla terra. Sorge spontanea la domanda: se la luna si trova in opposizione al
sole, e quindi dall'altra parte della terra, come fa ad essere illuminata? La risposta è data dall'inclinazione del
piano dell'orbita lunare rispetto a quella terrestre: quando la luna si trova
infatti in fase di plenilunio, avrà rispetto alla terra un'inclinazione tale
che possa essere illuminata dai raggi solari. Questa risposta sposta
l'obiettivo sulle eclissi. Innanzitutto la risposta alla precedente domanda
deve essere completata dalla definizione della cosiddetta ''linea dei nodi'', che
corrisponde ad una ideale linea di intersezione dei piani lunari e terrestri, che
evidentemente non sono paralleli, altrimenti le cause sarebbero frequenti
oscurazioni lunari o di una porzione di superficie terrestre nelle fasi
rispettive di plenilunio e novilunio. Le eclissi possono essere  lunari o solari, parziali o totali a seconda della posizione dei due
corpi: le eclissi di luna si verificano
quando la luna si trova in uno dei nodi (o in prossimità, considerato che il
cono d'ombra della terra molto più ampio delle dimensioni della luna) durante
la fase di plenilunio, poiché il nodo corrisponde al punto di intersezione col
piano orbitale della terra, per cui terra e luna si troveranno allineate. Le
eclissi lunari sono spesso totali e si possono osservare da tutti i luoghi in cui la luna si trova
sopra l'orizzonte. Le eclissi parziali sono meno frequenti e per essere
definite tali devono essere interessati i ¾ della superficie: queste saranno
visibili qualora la parte di penombra che si allarga dietro la terra investe la
luna. Le eclissi solari si hanno
durante la fase di novilunio, più precisamente quando la luna è su uno dei
nodi: in questo caso si ha una situazione di eclisse totale quando la luna è
particolarmente vicina alla terra, e può essere vista come totale solo in una
porzione ristretta di superficie terrestre (mentre le altre zone investite
dalla penombra hanno solo la percezione di un'eclisse parziale). Particolare
rilevanza hanno poi le eclissi anulari
di sole che si verificano quando la luna si trova in uno dei nodi alla massima
lunari o solari, parziali o totali a seconda della posizione dei due
corpi: le eclissi di luna si verificano
quando la luna si trova in uno dei nodi (o in prossimità, considerato che il
cono d'ombra della terra molto più ampio delle dimensioni della luna) durante
la fase di plenilunio, poiché il nodo corrisponde al punto di intersezione col
piano orbitale della terra, per cui terra e luna si troveranno allineate. Le
eclissi lunari sono spesso totali e si possono osservare da tutti i luoghi in cui la luna si trova
sopra l'orizzonte. Le eclissi parziali sono meno frequenti e per essere
definite tali devono essere interessati i ¾ della superficie: queste saranno
visibili qualora la parte di penombra che si allarga dietro la terra investe la
luna. Le eclissi solari si hanno
durante la fase di novilunio, più precisamente quando la luna è su uno dei
nodi: in questo caso si ha una situazione di eclisse totale quando la luna è
particolarmente vicina alla terra, e può essere vista come totale solo in una
porzione ristretta di superficie terrestre (mentre le altre zone investite
dalla penombra hanno solo la percezione di un'eclisse parziale). Particolare
rilevanza hanno poi le eclissi anulari
di sole che si verificano quando la luna si trova in uno dei nodi alla massima  distanza dalla terra (apogeo): l'effetto
anulare sarà dovuto alle dimensioni
distanza dalla terra (apogeo): l'effetto
anulare sarà dovuto alle dimensioni  notevolmente minori del satellite terrestre rispetto alla grandezza del
sole, che oscurerà solo la parte centrale della Stella, lasciando appunto un ''anello'' luminoso in vista.
notevolmente minori del satellite terrestre rispetto alla grandezza del
sole, che oscurerà solo la parte centrale della Stella, lasciando appunto un ''anello'' luminoso in vista.
Grazie alle moderne apparecchiature sismografiche, si è scoperto che la luna ha un'attività ridotta ma non assente. I terremoti lunari possono avere cause diverse: frane, assestamenti della crosta, altri motivi spiegabili con l'influenza dell'attrazione terrestre, come succede con le maree sulla terra.
 Nella esistenza di questo corpo
celeste sono stati individuati sei stati fondamentali:
Nella esistenza di questo corpo
celeste sono stati individuati sei stati fondamentali:
1) l'origine della luna, con quattro diverse ipotesi: a) la fissione darwiniana, per la quale un tempo la terra ad uno stato fuso ruotava molto velocemente, così da potersi scindere in due corpi a causa dell'azione gravitazionale del sole, che avrebbe prodotto maree sempre più frequenti fino alla scissione di una parte di materiale terrestre. Se in un primo momento questa teoria riscosse molte adesioni venne in seguito abbandonata per essere poi ripresa e ritrattata: la nuova teoria spiega che alla formazione del nucleo con materiale più pesante, la terra aumentò la velocità di rotazione con conseguente fissione di quel materiale che sarebbe diventato un nuovo corpo celeste. Questa teoria spiegherebbe la minore densità della luna rispetto al suo ''pianeta d'origine'', sebbene resti da risolvere il problema dell'inclinazione dell'orbita lunare; b) l'ipotesi della cattura, secondo alcuni infatti la luna viaggiava liberamente nel sistema solare, sarebbe poi giunta molto vicina alla terra tanto da esserne attratta. Questa seconda teoria ammette un'improbabile diminuzione della velocità lunare, che, però, potrebbe essere stata causata dalla dissipazione dell'energia dovuta all'attrito delle maree. Rispetto alla teoria della fissione questa spiegherebbe il dilemma sulla diversa composizione della terra, sebbene abbia diversi punti ancora da risolvere per essere accettata come vera; c) la formazione per accrescimento, che non esclude l'ipotesi di una specie di ''cattura'' dopo la genesi, dovuta ai materiali diversi che erano in orbita intorno al nostro pianeta; d) infine la teoria dell'impatto, in cui studiosi ricondurrebbero la creazione della terra ad un impatto violentissimo con un corpo di enormi dimensioni (teoria che si è fatta strada specialmente dopo le missioni Apollo);
2) la separazione della primitiva crosta lunare, avvenuta all'incirca 4.5 miliardi d'anni fa;
3) la prima epoca vulcanica, durante la quale con gigantesche eruzioni si sono formate le brecce, particolari rocce presenti sul suolo lunare;
4) il bombardamento meteoritico, periodo quasi contemporaneo alla prime eruzioni;
5) la seconda parte dell'attività vulcanica, mentre il bombardamento meteoritico andava diminuendo la fuoriuscita di lava dai bacini scavati dall'impatto dei meteoriti creava solidificandosi i basalti, presenti anche nella crosta oceanica terrestre;
6) la quiescenza: mentre l'attività vulcanica è ormai terminata e i bombardamenti meteoritici sono diminuiti lo spessore della crosta lunare è aumentato in maniera tale che le fratture non possano più manifestarsi. Dopo un periodo d'attività durato circa 4 miliardi di anni la luna può considerarsi oggi un corpo morto.
 L'ultima parte riguarda la luna
vista in superficie, ai giorni nostri. I mari lunari sono distese ampie e
piatte di polvere, cenere e detriti di provenienza incerta, che si
differenziano in frammenti di rocce magmatiche simili a quelle terrestri, frammenti
di sostanza vetrose e sferule tondeggianti ma che rientrano nel gruppo
denominato regolite. Al passaggio in prossimità dei mari, i satelliti
artificiali subiscono delle perturbazioni dovute probabilmente ad un maggior
effetto gravitazionale: queste aree sono dette mascon (dall'inglese mass
concentrations).
L'ultima parte riguarda la luna
vista in superficie, ai giorni nostri. I mari lunari sono distese ampie e
piatte di polvere, cenere e detriti di provenienza incerta, che si
differenziano in frammenti di rocce magmatiche simili a quelle terrestri, frammenti
di sostanza vetrose e sferule tondeggianti ma che rientrano nel gruppo
denominato regolite. Al passaggio in prossimità dei mari, i satelliti
artificiali subiscono delle perturbazioni dovute probabilmente ad un maggior
effetto gravitazionale: queste aree sono dette mascon (dall'inglese mass
concentrations).
La
''faccia'' a noi rivolta si presenta con il 70% di terre alte, o altopiani (sebbene
la struttura non sia uniforme), che sulla superficie totale ricoprono quasi l'80%;
i rilievi possono arrivare a


In a period when there was the so-named cold war, characterised by
conflict without arms, the two presidents of Usa and Urss, J.F. Kennedy and
Nikita Kruscev and their runners, tried to overcome the opposite nation with
innovations or technological inventions. So years by years they spent money and
money especially for space's industry : in 1961 was launched the first man in
the universe, Yurij Gagarin, and the supremacy of Urss seemed to be absolute:
there was of course the perfect way to show to the world the strength of a
winning economical model. The American
answer was ready, and just 8 years later, Neil Armstrong and other two spacemen
get the first moon landing on the Eagle with mission named Apollo 11. At the
20.17 of the 20th of July the Eagle (so named because this bird is
the image of united states) had the lunar landing, but only at 2.56 Armstrong made his descent to the moon's surface and is remembered because he said a
famous line 'That's one small step for a man, one giant leap for
mankind'. All the world could see the magnificence and the greatness of
the moon in tv and spacemen took photos of the moon land. But is this the real story of the moon landing? Is man
really arrived on moon surface? Or is it just a film? Some people studied
photos of the great conquest and demonstrated those are just a  fake, due to the will of Usa to be superior on Urss and distract people from
Vietnam war:
fake, due to the will of Usa to be superior on Urss and distract people from
Vietnam war:
 1. We know Armstrong was the
first man that take the first step on the moon. So who took the photo? A robot?
Then there is no atmosphere on the moon and the contrast between black and
white is clean: so
1. We know Armstrong was the
first man that take the first step on the moon. So who took the photo? A robot?
Then there is no atmosphere on the moon and the contrast between black and
white is clean: so
why the gloom?
2. if the sun shines all with their rays why behind this spaceman in the sky is all dark?

 3. Who took this photo if the spaceman on the moon were just 2?and why
the men's shades are not parallel and one is littler then the other?
3. Who took this photo if the spaceman on the moon were just 2?and why
the men's shades are not parallel and one is littler then the other?

4. why the spacecraft ''legs'' are not full of powder? And why the rocket didn't produce a hole in the moon land? Above all why we can't see any star in the sky? without atmosphere we should see the milky way too.
At the end the moon landing is justified for Us supremacy, and of course the smile represents the success of America against Soviets. Although there are many reasons to believe the moon landing is not true, people like dreaming. So let people dream..
Il
popolo romano, sebbene di grande cultura e magnifica storia, riuscì negli anni
del suo glorioso impero a portare alle massime espressioni forme di ingegneria,
arte, e tecnica che però avevano ereditato dalle genti confinanti prima o poi inglobate.
Di loro iniziativa inventarono ben poco, sebbene poi andarono in giro orgogliosamente
dicendo: ''Tota nostra est''(Quintiliano). Si parla ovviamente della satira (letteraria), genere letterario
talmente nuovo che i romani non  furono mai del tutto consci
nemmeno del significato etimologico: il termine può essere collegato alla
satura lanx, vassoio di cibarie differenti in offerta agli dei, o all'aggettivo
satura, che indica un ripieno di condimenti, oppure alla lex satura, proposta
di legge che faceva riferimenti ad argomenti scollegati tra loro, o magari ai
satiri, figure mitiche caratterizzate da un comportamento burlesco. Il termine
sembra così ricondurre alla varietà, che si riscontrerà poi con i temi
trattati, e alla spiritosaggine, spesso aggressiva. La storia della satira
appare così delineata: un primo periodo in cui scrittori come Ennio trattavano una vastità di temi, passando dal serio
al faceto con estrema semplicità; Lucilio, che getterà le reali basi su quella
che sarà la vera e propria satira letteraria latina (varietà tematica, aggressività
spesso ad personam , fine educativo-riflessivo);
e l'età augustea, durante la quale si avrà la possibilità di trattare temi
critici anche rispetto al potere (la repubblica consentiva una certa libertà di
scrittura per fattori molto importanti: SPQR, la famosa sigla Senatus PopulusQue Romanorum, implicava
una certa importanza del senato anzitutto, che aveva molti poteri, e certamente
del popolo, che, data l'esistenza di cariche annuali, aveva la facoltà di
eleggere i propri rappresentanti), e in cui maggior esponente è Orazio, che
avrà l'abilità, con il suo labor limae, di
elevare ad un linguaggio medio il lavoro precedente svolto da Lucilio (che sarà
criticato per il modo di scrivere); infine l'età imperiale, in cui senato e
popolo avevano ormai perso il proprio potere e la loro importanza (divenne
senatore un cavallo, mentre il popolo fu tenuto lontano dalle questioni
politiche con giochi e spettacoli), caratterizzata dalla ''persecuzione
letteraria''. I letterati non erano certo stupidi, e sapevano che una parola
contraria al potere li avrebbe condannati alla morte: trovarono così diversi
modi di operare nell'epoca imperiale.
furono mai del tutto consci
nemmeno del significato etimologico: il termine può essere collegato alla
satura lanx, vassoio di cibarie differenti in offerta agli dei, o all'aggettivo
satura, che indica un ripieno di condimenti, oppure alla lex satura, proposta
di legge che faceva riferimenti ad argomenti scollegati tra loro, o magari ai
satiri, figure mitiche caratterizzate da un comportamento burlesco. Il termine
sembra così ricondurre alla varietà, che si riscontrerà poi con i temi
trattati, e alla spiritosaggine, spesso aggressiva. La storia della satira
appare così delineata: un primo periodo in cui scrittori come Ennio trattavano una vastità di temi, passando dal serio
al faceto con estrema semplicità; Lucilio, che getterà le reali basi su quella
che sarà la vera e propria satira letteraria latina (varietà tematica, aggressività
spesso ad personam , fine educativo-riflessivo);
e l'età augustea, durante la quale si avrà la possibilità di trattare temi
critici anche rispetto al potere (la repubblica consentiva una certa libertà di
scrittura per fattori molto importanti: SPQR, la famosa sigla Senatus PopulusQue Romanorum, implicava
una certa importanza del senato anzitutto, che aveva molti poteri, e certamente
del popolo, che, data l'esistenza di cariche annuali, aveva la facoltà di
eleggere i propri rappresentanti), e in cui maggior esponente è Orazio, che
avrà l'abilità, con il suo labor limae, di
elevare ad un linguaggio medio il lavoro precedente svolto da Lucilio (che sarà
criticato per il modo di scrivere); infine l'età imperiale, in cui senato e
popolo avevano ormai perso il proprio potere e la loro importanza (divenne
senatore un cavallo, mentre il popolo fu tenuto lontano dalle questioni
politiche con giochi e spettacoli), caratterizzata dalla ''persecuzione
letteraria''. I letterati non erano certo stupidi, e sapevano che una parola
contraria al potere li avrebbe condannati alla morte: trovarono così diversi
modi di operare nell'epoca imperiale.
Seneca
visse un'esperienza di vita difficile: nell'anno
Il contesto politico non sembrava dei migliori poiché Agrippina era ancora molto vicina al potere, ma basti pensare che fu lei stessa a favorire l'ascesa al trono del figlio servendo all'ormai ex marito funghi velenosi.
 Persio fu forse il più grande
ed importante autore di satire in epoca imperiale: ne scrisse 6, spazianti dai
malcostumi dell'epoca alla filosofia, dallo stoico modello alla ricchezza. Lo
stile si presenta ''anticlassico'' dalla forzatura del linguaggio (sempre
dialogico, riprende il modello oraziano) e da metafore impavide, passaggi
logici e grotteschi quadretti: al linguaggio familiare si accosta una
raffinatezza stilistica e lessicale, forse perché era consapevole di dover
diffondere un messaggio morale e di riflessione. Sebbene parte dei suoi scritti
fu censurata ed eliminata per gli aggressivi e diretti attacchi all'imperatore,
nell'opera di Persio si può distinguere il prologo (o epilogo), in cui esplica
quella che sarà la sua poetica, non condita da sogni divini o investiture di
divinità protettrici nè con la pretesa di diventare poeta-vate (portatore di
verità), non comune alla letteratura del tempo, in grado di ricevere applausi
solo grazie alla raffinatezza esteriore. Questo sarà anche il tema della prima
satira, nella quale alla fine esprimerà la necessità di ''parlare'', ossia
mettere a nudo la società. Passa poi ad esaminare una religiosità che punta
all'interesse proprio dell'uomo, dalla ricchezza alla salute, fino all'augurio
per la morte di un parente ricco per poterne evidentemente ereditare la
proprietà. La terza e la quarta satira trattano argomenti intrecciati tra loro:
prima vengono illustrati i vantaggi nel dedicarsi alla filosofia in un quadro
originale in cui un uomo ubriaco viene esortato a cambiare vita -ma lo stesso
prima teme per la propria esistenza e poi ricomincia a bere e mangiare a più
non posso-poi ad allontanarsi dalla politica per dedicarsi alla contemplazione
di se stesso, per continuare a cercare quella saggezza che sta perdendo pian
piano; infine si diverge sul cattivo comportamento della gente che giudica gli
altri, invece di fare un esame di coscienza. Le ultime due satire fanno riflettere
sulla libertà morale - intesa come indipendenza da quelle passioni e quei vizi
che ostacolano l'uomo nel raggiungimento della saggezza stoica- e sulla
ricchezza, che induce gli uomini a comportamenti riprovevoli (il quadro ironico
del vecchio ricco che non si concede un ''lusso'' nemmeno al suo compleanno e
il giovane ereditiere che aspetta bramando la morte del vecchio e ne rimprovera
ogni minima spesa, rappresenta il modo più diretto per evidenziare i
comportamenti umani). Politicamente, Persio si trovava in un contesto che pian
piano andava evolvendosi: dopo una prima parte di ''regno illuminato''
l'uccisione della madre Agrippina e l'allontanamento di Seneca e Burro, con
conseguente avvicinamento di Tigellino, frenarono gli intenti positivi
dell'allora giovane Nerone, che cambiò il suo modo di regnare: possiamo
ricondurre solo al cambiamento non radicale ma graduale della politica
neroniana e quindi all'incoscienza di Persio l'impegno assiduo in un genere che
avrebbe potuto portarlo alla morte.
Persio fu forse il più grande
ed importante autore di satire in epoca imperiale: ne scrisse 6, spazianti dai
malcostumi dell'epoca alla filosofia, dallo stoico modello alla ricchezza. Lo
stile si presenta ''anticlassico'' dalla forzatura del linguaggio (sempre
dialogico, riprende il modello oraziano) e da metafore impavide, passaggi
logici e grotteschi quadretti: al linguaggio familiare si accosta una
raffinatezza stilistica e lessicale, forse perché era consapevole di dover
diffondere un messaggio morale e di riflessione. Sebbene parte dei suoi scritti
fu censurata ed eliminata per gli aggressivi e diretti attacchi all'imperatore,
nell'opera di Persio si può distinguere il prologo (o epilogo), in cui esplica
quella che sarà la sua poetica, non condita da sogni divini o investiture di
divinità protettrici nè con la pretesa di diventare poeta-vate (portatore di
verità), non comune alla letteratura del tempo, in grado di ricevere applausi
solo grazie alla raffinatezza esteriore. Questo sarà anche il tema della prima
satira, nella quale alla fine esprimerà la necessità di ''parlare'', ossia
mettere a nudo la società. Passa poi ad esaminare una religiosità che punta
all'interesse proprio dell'uomo, dalla ricchezza alla salute, fino all'augurio
per la morte di un parente ricco per poterne evidentemente ereditare la
proprietà. La terza e la quarta satira trattano argomenti intrecciati tra loro:
prima vengono illustrati i vantaggi nel dedicarsi alla filosofia in un quadro
originale in cui un uomo ubriaco viene esortato a cambiare vita -ma lo stesso
prima teme per la propria esistenza e poi ricomincia a bere e mangiare a più
non posso-poi ad allontanarsi dalla politica per dedicarsi alla contemplazione
di se stesso, per continuare a cercare quella saggezza che sta perdendo pian
piano; infine si diverge sul cattivo comportamento della gente che giudica gli
altri, invece di fare un esame di coscienza. Le ultime due satire fanno riflettere
sulla libertà morale - intesa come indipendenza da quelle passioni e quei vizi
che ostacolano l'uomo nel raggiungimento della saggezza stoica- e sulla
ricchezza, che induce gli uomini a comportamenti riprovevoli (il quadro ironico
del vecchio ricco che non si concede un ''lusso'' nemmeno al suo compleanno e
il giovane ereditiere che aspetta bramando la morte del vecchio e ne rimprovera
ogni minima spesa, rappresenta il modo più diretto per evidenziare i
comportamenti umani). Politicamente, Persio si trovava in un contesto che pian
piano andava evolvendosi: dopo una prima parte di ''regno illuminato''
l'uccisione della madre Agrippina e l'allontanamento di Seneca e Burro, con
conseguente avvicinamento di Tigellino, frenarono gli intenti positivi
dell'allora giovane Nerone, che cambiò il suo modo di regnare: possiamo
ricondurre solo al cambiamento non radicale ma graduale della politica
neroniana e quindi all'incoscienza di Persio l'impegno assiduo in un genere che
avrebbe potuto portarlo alla morte.
Con
una società sempre più corrotta e degradata, la satira raggiunse l'apice con il
poeta Giovenale. La scelta del genere satirico appare obbligata (''difficile est saturam non scribere'')
dal dilagare di vizi sempre più presenti in un popolo che si avviava al
declino, politico e sociale; gli imperatori d'altra parte, esercitando il
controllo totale,  non permettevano un attacco
diretto al potere, motivo in più per evitare una morte certa, sorvolando
apparentante sul presente. L'autore d'origine laziale per ovvi motivi di
prudenza si troverà così a trattare ironicamente argomenti di un passato
recente (come altri suoi amici letterati), tali da proiettare i problemi
cronologicamente nel suo presente. È importante sottolineare che Giovenale non
ha radici filosofiche, non prenderà così ad esempio i suoi ideali, ma si
ispirerà alla tradizione morale romana con un atteggiamento altamente
conservatore (saranno presi di mira i ricchi, i ''diversi'', le donne e la
nobiltà che si disinteressa dell'arte) ed aggressivo che farà pensare ad un
risentimento personale più che ad una messa in luce oggettiva della società. La
sua aggressività, che sarà alla base della poetica, potrebbe infatti dipendere
dalla sfortunata esperienza biografica causata da un mancato aggancio ad un
potente padrone, che potesse garantirgli sostentamento. I suoi 5 libri di
satire trattano tutti gli argomenti con una spiccata indignatio: la satira
è la sola forma letteraria adatta ad esprimere lo sdegno dell'autore (''si natura negat, facit indingnatio versus''),
che vede lo sfacelo morale dei suoi tempi, laddove i suoi coetanei vedono
l'approssimarsi di una nuova 'età dell'oro' dopo la buia epoca di Domiziano;
mentre però Persio credeva nella capacità umana di risollevarsi dopo un periodo
buio, Giovenale critica aspramente senza nemmeno cercare di proporre
correttivi. Questo astio sociale, che in un primo momento può sembrare
oggettivo, richiama la sua condizione di cliens
emarginato: un poeta, diventato tale dopo una carriera sfortunata da
avvocato, che non riuscirà mai ad affermarsi veramente nel panorama letterario
romano. Sotto il profilo linguistico e stilistico la svolta di Giovenale: da un
lato egli saprà sfruttare a pieno gli insegnamenti di Quintiliano (''da, Quintiliano, colorem''), proponendo
un linguaggio ''aulico'' rispetto al sermo
familiaris a cui eravamo stati precedentemente abituati, perdendo così il
gusto del vero e proprio comico ridicolo, dall'altro il suo realismo sarà così
esasperato da annullare quasi la componente satirica, dipingendo i personaggi
delle sue satire come dei mostri dai quali è meglio fuggire. L'unica satira che
si differenzia realmente dagli argomenti in precedenza trattati dagli altri
autori è quella sulle donne: Giovenale presenta all'amico Postumo, destinatario
della satira, una serie di ritratti femminili, ovviamente negativi, che
dovrebbero far desistere l'amico dall'intenzione di prendere moglie: mogli
infedeli, disposte finanche a prostituirsi, avide di ricchezze o sicure di sé, ma
anche tutte coloro che non rispettavano i canoni della matrona repubblicana.
non permettevano un attacco
diretto al potere, motivo in più per evitare una morte certa, sorvolando
apparentante sul presente. L'autore d'origine laziale per ovvi motivi di
prudenza si troverà così a trattare ironicamente argomenti di un passato
recente (come altri suoi amici letterati), tali da proiettare i problemi
cronologicamente nel suo presente. È importante sottolineare che Giovenale non
ha radici filosofiche, non prenderà così ad esempio i suoi ideali, ma si
ispirerà alla tradizione morale romana con un atteggiamento altamente
conservatore (saranno presi di mira i ricchi, i ''diversi'', le donne e la
nobiltà che si disinteressa dell'arte) ed aggressivo che farà pensare ad un
risentimento personale più che ad una messa in luce oggettiva della società. La
sua aggressività, che sarà alla base della poetica, potrebbe infatti dipendere
dalla sfortunata esperienza biografica causata da un mancato aggancio ad un
potente padrone, che potesse garantirgli sostentamento. I suoi 5 libri di
satire trattano tutti gli argomenti con una spiccata indignatio: la satira
è la sola forma letteraria adatta ad esprimere lo sdegno dell'autore (''si natura negat, facit indingnatio versus''),
che vede lo sfacelo morale dei suoi tempi, laddove i suoi coetanei vedono
l'approssimarsi di una nuova 'età dell'oro' dopo la buia epoca di Domiziano;
mentre però Persio credeva nella capacità umana di risollevarsi dopo un periodo
buio, Giovenale critica aspramente senza nemmeno cercare di proporre
correttivi. Questo astio sociale, che in un primo momento può sembrare
oggettivo, richiama la sua condizione di cliens
emarginato: un poeta, diventato tale dopo una carriera sfortunata da
avvocato, che non riuscirà mai ad affermarsi veramente nel panorama letterario
romano. Sotto il profilo linguistico e stilistico la svolta di Giovenale: da un
lato egli saprà sfruttare a pieno gli insegnamenti di Quintiliano (''da, Quintiliano, colorem''), proponendo
un linguaggio ''aulico'' rispetto al sermo
familiaris a cui eravamo stati precedentemente abituati, perdendo così il
gusto del vero e proprio comico ridicolo, dall'altro il suo realismo sarà così
esasperato da annullare quasi la componente satirica, dipingendo i personaggi
delle sue satire come dei mostri dai quali è meglio fuggire. L'unica satira che
si differenzia realmente dagli argomenti in precedenza trattati dagli altri
autori è quella sulle donne: Giovenale presenta all'amico Postumo, destinatario
della satira, una serie di ritratti femminili, ovviamente negativi, che
dovrebbero far desistere l'amico dall'intenzione di prendere moglie: mogli
infedeli, disposte finanche a prostituirsi, avide di ricchezze o sicure di sé, ma
anche tutte coloro che non rispettavano i canoni della matrona repubblicana.
 Uno degli ultimi autori romani
studiati nell'epoca imperiale è Marziale, che fece dell'umorismo l'arma tagliente
con la quale mettere in risalto il comportamento umano (i componimenti di
Marziale tratteranno sempre la realtà, ''hominem nostra pagina sapit''). Sempre
convinto che l'epigramma potesse diventare un genere letterario a sé stante (cosa
che peraltro riuscì a fare), scrisse circa diecimila versi: mentre alcuni (liber de spectaculis) celebrano
l'imperatore per la costruzione dell'anfiteatro flavio (ricordiamo che Marziale
ebbe sempre ottimi rapporti con il potere, e non mancò di elogiare coloro i
quali gli permettevano di svolgere liberamente l'attività) o servono per essere
regalati durante banchetti e feste (xenia e aphophoreta), altri senza alcun
pregiudizio moralistico attaccano sfacciatamente vizi e debolezze umane, comportamenti
inadeguati o avversari letterari, senza mai tralasciare quel pizzico di umorismo
con il quale riesce ad affrontare, con magistrale destrezza, qualsiasi tema. La
peculiarità fondamentale dell'umorismo di Marziale sta nel fulmen in clausula, metafora di una battuta piacevole che
disorienta il lettore, lo sorprende anche dopo un testo di raffinata eleganza, ma
solo nella parte finale dell'epigramma. Possiamo individuare in Marziale una
duplice finalità realizzativa: mentre, da una parte, mette in risalto
comportamenti e vizi senza alcun pudore (tant'è che verrà definito volgare, ma
saprà difendersi distinguendo poesia e poeta, ''lasciva est nobis pagina, vita proba''), inducendo l'uomo al
semplice riso (quindi l'ironia), dall'altra parte il suo era un modo per far
riflettere sulle condizioni del tempo (quindi l'umorismo): una Roma ormai
malandata e indebolita da un impero così grande da essere quasi incontrollato, stava
sempre di più perdendo il suo potere e la sua moralità. Marziale cercherà di
far riflettere l'uomo sulle condizioni in cui vive, ma forse a causa del suo
continuo voler far ridere, o magari perché gli uomini del tempo plaudivano solo
gli elogianti, non ci riuscirà mai pienamente, lasciando intendere che i suoi
epigrammi fossero solo uno sfogo personale contro la società e niente di più.
Uno degli ultimi autori romani
studiati nell'epoca imperiale è Marziale, che fece dell'umorismo l'arma tagliente
con la quale mettere in risalto il comportamento umano (i componimenti di
Marziale tratteranno sempre la realtà, ''hominem nostra pagina sapit''). Sempre
convinto che l'epigramma potesse diventare un genere letterario a sé stante (cosa
che peraltro riuscì a fare), scrisse circa diecimila versi: mentre alcuni (liber de spectaculis) celebrano
l'imperatore per la costruzione dell'anfiteatro flavio (ricordiamo che Marziale
ebbe sempre ottimi rapporti con il potere, e non mancò di elogiare coloro i
quali gli permettevano di svolgere liberamente l'attività) o servono per essere
regalati durante banchetti e feste (xenia e aphophoreta), altri senza alcun
pregiudizio moralistico attaccano sfacciatamente vizi e debolezze umane, comportamenti
inadeguati o avversari letterari, senza mai tralasciare quel pizzico di umorismo
con il quale riesce ad affrontare, con magistrale destrezza, qualsiasi tema. La
peculiarità fondamentale dell'umorismo di Marziale sta nel fulmen in clausula, metafora di una battuta piacevole che
disorienta il lettore, lo sorprende anche dopo un testo di raffinata eleganza, ma
solo nella parte finale dell'epigramma. Possiamo individuare in Marziale una
duplice finalità realizzativa: mentre, da una parte, mette in risalto
comportamenti e vizi senza alcun pudore (tant'è che verrà definito volgare, ma
saprà difendersi distinguendo poesia e poeta, ''lasciva est nobis pagina, vita proba''), inducendo l'uomo al
semplice riso (quindi l'ironia), dall'altra parte il suo era un modo per far
riflettere sulle condizioni del tempo (quindi l'umorismo): una Roma ormai
malandata e indebolita da un impero così grande da essere quasi incontrollato, stava
sempre di più perdendo il suo potere e la sua moralità. Marziale cercherà di
far riflettere l'uomo sulle condizioni in cui vive, ma forse a causa del suo
continuo voler far ridere, o magari perché gli uomini del tempo plaudivano solo
gli elogianti, non ci riuscirà mai pienamente, lasciando intendere che i suoi
epigrammi fossero solo uno sfogo personale contro la società e niente di più.
La componente del ridere negli ultimi argomenti trattati è chiara: in epoca romana, a meno che non si parli di età repubblicana, fare ridere era l'unico modo per portare a riflettere sulle problematiche del tempo; una riflessione che forse, avrebbe giovato allo stesso popolo Romano.
Con
il ''nuovo corso'', gli Stati Uniti
d'America e tutto il popolo americano ritrovarono il sorriso dopo un periodo
economicamente depresso: la crisi del 1929 aveva infatti recato un danno
ingente al  nuovo continente, portandolo ad
una recessione economica senza paragoni. Ma andiamo per gradi. Negli anni '20,
la produzione statunitense conobbe una crescita sproporzionata, tale da introdurre
per la prima volta la produzione di massa, e le politiche repubblicane
sembravano favorire il commercio con interventi a favore degli investimenti, ma
contro i ceti più bassi e poveri. Sperando in ricchezze facili e veloci, gli
americani investirono in borsa i propri guadagni, acquistando (e prendendo in
prestito) azioni che sarebbero state rivendute poco dopo; mentre le fasce
povere continuavano ad esistere, problemi come l'aumento di salari non pari
all'aumento di produzione, l'impossibilità di cambio frequente dei beni
durevoli e i successivi crolli in borsa (si ricordino il giovedì e il martedì
nero) produssero effetti a catena tali da aumentare disoccupazione e
diminuzione della liquidità. Dopo i ''ruggenti'' anni '20, si affacciava alla
porta degli Stati Uniti il primo vero problema, che sarebbe poi divenuto
la prima dimostrazione vera del potere
statunitense. Per la cronaca, anche altri paesi, economicamente vicini e aiutati
dagli Stati Uniti, quali Gran Bretagna, Francia, Italia e specialmente Germania, subirono una flessione che causò
anche rivoluzioni del sistema politico (si veda
nuovo continente, portandolo ad
una recessione economica senza paragoni. Ma andiamo per gradi. Negli anni '20,
la produzione statunitense conobbe una crescita sproporzionata, tale da introdurre
per la prima volta la produzione di massa, e le politiche repubblicane
sembravano favorire il commercio con interventi a favore degli investimenti, ma
contro i ceti più bassi e poveri. Sperando in ricchezze facili e veloci, gli
americani investirono in borsa i propri guadagni, acquistando (e prendendo in
prestito) azioni che sarebbero state rivendute poco dopo; mentre le fasce
povere continuavano ad esistere, problemi come l'aumento di salari non pari
all'aumento di produzione, l'impossibilità di cambio frequente dei beni
durevoli e i successivi crolli in borsa (si ricordino il giovedì e il martedì
nero) produssero effetti a catena tali da aumentare disoccupazione e
diminuzione della liquidità. Dopo i ''ruggenti'' anni '20, si affacciava alla
porta degli Stati Uniti il primo vero problema, che sarebbe poi divenuto
la prima dimostrazione vera del potere
statunitense. Per la cronaca, anche altri paesi, economicamente vicini e aiutati
dagli Stati Uniti, quali Gran Bretagna, Francia, Italia e specialmente Germania, subirono una flessione che causò
anche rivoluzioni del sistema politico (si veda  riconosciuto quale fautore
della rinascita americana. Costituito un ''brain trust'' (si noti la
somiglianza con la politica recentissima di Barack Obama) di ricercatori e
specialisti nel campo economico, il nuovo presidente ovviamente cercò una
soluzione alla crisi, per rilanciare investimenti, aziende e privati, adottando
una politica pragmatica: in ogni situazione si sarebbe scelta la soluzione più
indicata per la ripresa. Un presidente moderno e diretto entrò nelle case degli
americani attraverso l'unico apparecchio di comunicazione di massa allora
esistente: la radio permise a Roosevelt un contatto attivo con la sua gente;
egli infondeva loro coraggio e speranza con i suoi discorsi settimanali (con i
quali ovviamente illustrava la situazione economica del paese), che poi vennero
chiamati ''chiacchierate al caminetto''. Passando ai fatti, il nuovo presidente
democratico attuò interventi indiretti come la riforma del sistema creditizio
con lo sganciamento del dollaro dalla parità con l'oro, favorendo le esportazioni;
l'atto sull'agricoltura, che concedeva premi in denaro ai contadini che
avessero limitato la produzione, per favorire un rialzo dei prezzi; l'atto
sull'industria, che proponeva anche un codice etico rinunciando così al lavoro
in nero e infantile e definendo un orario comune di lavoro, per limitarne la
sovrapproduzione; una riforma fiscale, che prevedeva criteri di tassazione a
seconda del reddito; il wagner act, per favorire l'organizzazione sindacale.
Non mancano gli interventi diretti, per fornire direttamente lavoro ai
disoccupati: il TVA, che prevedeva lo sfruttamento delle risorse idroelettriche
del Tennessee (Tennessee Valley Authority); il Works Progress Administration, che
impiegò circa 8 milioni di persone, tra cui 2.5 milioni di disoccupati, nei
riconosciuto quale fautore
della rinascita americana. Costituito un ''brain trust'' (si noti la
somiglianza con la politica recentissima di Barack Obama) di ricercatori e
specialisti nel campo economico, il nuovo presidente ovviamente cercò una
soluzione alla crisi, per rilanciare investimenti, aziende e privati, adottando
una politica pragmatica: in ogni situazione si sarebbe scelta la soluzione più
indicata per la ripresa. Un presidente moderno e diretto entrò nelle case degli
americani attraverso l'unico apparecchio di comunicazione di massa allora
esistente: la radio permise a Roosevelt un contatto attivo con la sua gente;
egli infondeva loro coraggio e speranza con i suoi discorsi settimanali (con i
quali ovviamente illustrava la situazione economica del paese), che poi vennero
chiamati ''chiacchierate al caminetto''. Passando ai fatti, il nuovo presidente
democratico attuò interventi indiretti come la riforma del sistema creditizio
con lo sganciamento del dollaro dalla parità con l'oro, favorendo le esportazioni;
l'atto sull'agricoltura, che concedeva premi in denaro ai contadini che
avessero limitato la produzione, per favorire un rialzo dei prezzi; l'atto
sull'industria, che proponeva anche un codice etico rinunciando così al lavoro
in nero e infantile e definendo un orario comune di lavoro, per limitarne la
sovrapproduzione; una riforma fiscale, che prevedeva criteri di tassazione a
seconda del reddito; il wagner act, per favorire l'organizzazione sindacale.
Non mancano gli interventi diretti, per fornire direttamente lavoro ai
disoccupati: il TVA, che prevedeva lo sfruttamento delle risorse idroelettriche
del Tennessee (Tennessee Valley Authority); il Works Progress Administration, che
impiegò circa 8 milioni di persone, tra cui 2.5 milioni di disoccupati, nei  cantieri che si formavano per
tutto il paese; il patto per il nuovo sistema pensionistico e assistenziale, che
prevedeva appunto aiuti per gli anziani e i disoccupati. Roosevelt e il suo
staff certo non erano folli nello spendere ingenti somme di denaro statale per
risollevarsi dalla crisi, e comunque se c'era qualcuno che doveva ricominciare
ad investire, quello era lo stato. I programmi varati in questo periodo
consideravano infatti progetti a lungo termine, per i quali solo alla fine
della crisi i cittadini avrebbero potuto investire il denaro che avevano
guadagnato e così lo stato ne avrebbe tratto profitto. I nuovi interventi
gettavano le basi per il ''welfare state'' (o stato d'assistenza) che avrebbe
garantito assistenza minima ai cittadini, al contrario della precedente
discrezionalità delle singole città. Grazie a questi importanti interventi gli
Stati Uniti diedero una svolta fondamentale a quella che sembrava una crisi senza via d'uscita: il laissez fare economico degli anni precedenti si era rivelato
totalmente incontrollabile per i cittadini, che pensavano certamente ai propri
interessi, ed erano necessarie così nuove regole, che vennero istituite - forse
fortunosamente - dalla politica rooseveltiana, ma che certamente diedero i
frutti sperati. Parlando col senno di poi è facile illustrare la dimestichezza
del governo dal 1932 per uscire dalla crisi, ma anche in quell'epoca dove pochi
stavano bene, proprio quei pochi cercarono di opporsi al nuovo corso:
cantieri che si formavano per
tutto il paese; il patto per il nuovo sistema pensionistico e assistenziale, che
prevedeva appunto aiuti per gli anziani e i disoccupati. Roosevelt e il suo
staff certo non erano folli nello spendere ingenti somme di denaro statale per
risollevarsi dalla crisi, e comunque se c'era qualcuno che doveva ricominciare
ad investire, quello era lo stato. I programmi varati in questo periodo
consideravano infatti progetti a lungo termine, per i quali solo alla fine
della crisi i cittadini avrebbero potuto investire il denaro che avevano
guadagnato e così lo stato ne avrebbe tratto profitto. I nuovi interventi
gettavano le basi per il ''welfare state'' (o stato d'assistenza) che avrebbe
garantito assistenza minima ai cittadini, al contrario della precedente
discrezionalità delle singole città. Grazie a questi importanti interventi gli
Stati Uniti diedero una svolta fondamentale a quella che sembrava una crisi senza via d'uscita: il laissez fare economico degli anni precedenti si era rivelato
totalmente incontrollabile per i cittadini, che pensavano certamente ai propri
interessi, ed erano necessarie così nuove regole, che vennero istituite - forse
fortunosamente - dalla politica rooseveltiana, ma che certamente diedero i
frutti sperati. Parlando col senno di poi è facile illustrare la dimestichezza
del governo dal 1932 per uscire dalla crisi, ma anche in quell'epoca dove pochi
stavano bene, proprio quei pochi cercarono di opporsi al nuovo corso:
 L'arte del ridere riflettendo sposa
in pieno il progetto Dada. Tendenza, e non movimento, nata dalla protesta contro
la prima guerra mondiale, accomunava tutti gli esponenti per due importanti
fattori, entrambi legati alla guerra: la volontà di fare arte anche in questi
momenti sicuramente non felici e la necessità di sfuggire all'arruolamento. Trovò
posto in quel piccolo stato del centro Europa,
L'arte del ridere riflettendo sposa
in pieno il progetto Dada. Tendenza, e non movimento, nata dalla protesta contro
la prima guerra mondiale, accomunava tutti gli esponenti per due importanti
fattori, entrambi legati alla guerra: la volontà di fare arte anche in questi
momenti sicuramente non felici e la necessità di sfuggire all'arruolamento. Trovò
posto in quel piccolo stato del centro Europa, 
 Nella prima, la provocazione non sta tanto
nell'aggiunta di baffi e pizzetto - cosa che molti bambini fanno sui loro libri
scolastici solo per gioco - e nemmeno nella scritta L.H.O.O.Q. che sillabata
alla francese dà vita ad una frase volgare, totalmente estranea al contesto (elle a chaud au cul, lei ha caldo al
sedere), ma nel contestare gli estimatori ignoranti e passivi che si attaccano all'opinione
pubblica per conformarsi al gusto di
tutti; Duchamp onora a suo modo l'opera di Leonardo. ''Non è importante se Mr.
Mutt abbia fatto Fontana con le sue mani o no. Egli l'ha SCELTA. Egli ha preso
un articolo ordinario della vita di ogni giorno, lo ha collocato in modo tale
che il suo significato d'uso è scomparso sotto il nuovo titolo e il nuovo punto
di vista - ha creato un nuovo modo di pensare quell'oggetto''-commentò Duchamp
quando l'opera di un certo R. Mutt venne scartata da un importante museo
americano. La provocazione dell'artista era chiara anche in questo caso: voleva
sconvolgere l'istituzione e l'arte stessa con un orinatoio capovolto, favorendo
non il fare arte (quindi la bravura di un artista nel disegnare) ma lo
scegliere (quindi lavorare con l'intelletto). L'opera originale fu persa
durante il trasporto poiché i facchini lo buttarono via, credendolo un comune
orinatoio; ecco che, tornando al contesto originale, l'opera è nuovamente un
oggetto comune e Duchamp non poteva aspettarsi un esito migliore. L'unica nota
artistica nella scelta dell'orinatoio sta nella firma, R. Mutt, in cui, se
anteponiamo il cognome al nome otteniamo la parola tedesca mutter , che significa madre, poiché la forma dell'orinatoio
ricorda un bacino femminile.
Nella prima, la provocazione non sta tanto
nell'aggiunta di baffi e pizzetto - cosa che molti bambini fanno sui loro libri
scolastici solo per gioco - e nemmeno nella scritta L.H.O.O.Q. che sillabata
alla francese dà vita ad una frase volgare, totalmente estranea al contesto (elle a chaud au cul, lei ha caldo al
sedere), ma nel contestare gli estimatori ignoranti e passivi che si attaccano all'opinione
pubblica per conformarsi al gusto di
tutti; Duchamp onora a suo modo l'opera di Leonardo. ''Non è importante se Mr.
Mutt abbia fatto Fontana con le sue mani o no. Egli l'ha SCELTA. Egli ha preso
un articolo ordinario della vita di ogni giorno, lo ha collocato in modo tale
che il suo significato d'uso è scomparso sotto il nuovo titolo e il nuovo punto
di vista - ha creato un nuovo modo di pensare quell'oggetto''-commentò Duchamp
quando l'opera di un certo R. Mutt venne scartata da un importante museo
americano. La provocazione dell'artista era chiara anche in questo caso: voleva
sconvolgere l'istituzione e l'arte stessa con un orinatoio capovolto, favorendo
non il fare arte (quindi la bravura di un artista nel disegnare) ma lo
scegliere (quindi lavorare con l'intelletto). L'opera originale fu persa
durante il trasporto poiché i facchini lo buttarono via, credendolo un comune
orinatoio; ecco che, tornando al contesto originale, l'opera è nuovamente un
oggetto comune e Duchamp non poteva aspettarsi un esito migliore. L'unica nota
artistica nella scelta dell'orinatoio sta nella firma, R. Mutt, in cui, se
anteponiamo il cognome al nome otteniamo la parola tedesca mutter , che significa madre, poiché la forma dell'orinatoio
ricorda un bacino femminile.

 Come già accennato, uno dei movimenti successivi al
Dada è il Surrealismo, pura arte psichica, che sarà indirizzata dalla scoperta
dell'inconscio di Freud, manifestata in vario modo. L'artista Magritte sfrutta
le sue conoscenze artistiche e letterarie per la creazione di un quadro
apparentemente contraddittorio e ironico, ma, nei fatti, di profonda
riflessione: l'uso della parola. Il
quadro prende di mira una delle convenzioni estetiche più antiche, quella
secondo cui il pregio di un'opera starebbe nel rappresentare nel modo più
illusionistico possibile la realtà. Magritte avverte lo spettatore che ciò che
è rappresentato è, appunto, solo rappresentato, come sono rappresentazioni una
parola o un pensiero; l'arte non copia la natura né, tanto meno, la ricrea. La
pittura infatti è un linguaggio convenzionale esattamente come la scrittura;
quel che è raffigurato con mezzi pittorici è un ragionamento e non un'emozione,
lo straniamento del pensiero di fronte alla negazione di qualcosa che si dava
per scontato. In questo quadro, è importante il rapporto visione-linguaggio: l'oggetto
rappresentato non corrisponde infatti all'oggetto reale. Esaminando il quadro,
notiamo subito nella parte superiore una pipa e, sotto, una apparentemente equivoca scritta, con caratteri scolastici in
francese: Ceci n'est pas une pipe (questa
non è una pipa). Questa contraddizione crea uno stato di shock e riso, ma se si
riflette sull'opera, si capirà bene che l'oggetto è solo rappresentato. La
peculiarità di Magritte nel panorama artistico del suo tempo è la veglia, contro l'usuale
rappresentazione inconscia (e quindi del sogno) degli altri artisti
surrealisti: una veglia fin troppo vera, nella quale gli oggetti accomunati fra
loro avranno una nitidezza di colori e linee che ce li farà sembrare più veri
del vero.
Come già accennato, uno dei movimenti successivi al
Dada è il Surrealismo, pura arte psichica, che sarà indirizzata dalla scoperta
dell'inconscio di Freud, manifestata in vario modo. L'artista Magritte sfrutta
le sue conoscenze artistiche e letterarie per la creazione di un quadro
apparentemente contraddittorio e ironico, ma, nei fatti, di profonda
riflessione: l'uso della parola. Il
quadro prende di mira una delle convenzioni estetiche più antiche, quella
secondo cui il pregio di un'opera starebbe nel rappresentare nel modo più
illusionistico possibile la realtà. Magritte avverte lo spettatore che ciò che
è rappresentato è, appunto, solo rappresentato, come sono rappresentazioni una
parola o un pensiero; l'arte non copia la natura né, tanto meno, la ricrea. La
pittura infatti è un linguaggio convenzionale esattamente come la scrittura;
quel che è raffigurato con mezzi pittorici è un ragionamento e non un'emozione,
lo straniamento del pensiero di fronte alla negazione di qualcosa che si dava
per scontato. In questo quadro, è importante il rapporto visione-linguaggio: l'oggetto
rappresentato non corrisponde infatti all'oggetto reale. Esaminando il quadro,
notiamo subito nella parte superiore una pipa e, sotto, una apparentemente equivoca scritta, con caratteri scolastici in
francese: Ceci n'est pas une pipe (questa
non è una pipa). Questa contraddizione crea uno stato di shock e riso, ma se si
riflette sull'opera, si capirà bene che l'oggetto è solo rappresentato. La
peculiarità di Magritte nel panorama artistico del suo tempo è la veglia, contro l'usuale
rappresentazione inconscia (e quindi del sogno) degli altri artisti
surrealisti: una veglia fin troppo vera, nella quale gli oggetti accomunati fra
loro avranno una nitidezza di colori e linee che ce li farà sembrare più veri
del vero.
Alla base della visione pirandelliana del mondo vi è una concezione vitalistica: infatti, secondo questa idea, la realtà tutta è "vita", "perpetuo movimento vitale", inteso come flusso continuo, come lo scorrere di un magma vulcanico. Tutto ciò che si stacca dal flusso, per Pirandello, assumendo forma distinta e individuale, si irrigidisce e comincia a morire. L'uomo è parte indistinta dell'eterno fluire della vita, ma tende ad assumere forme individuali; non solo un individuo si dà una "forma", ma anche gli altri, vedendolo ciascuno dalla propria prospettiva. Pertanto, si crede di essere "uno", mentre si viene concepiti come tanti individui diversi. Questa frantumazione dell'io è un dato molto importante, poiché nel Novecento entrano in crisi l'idea di una realtà oggettiva, organica, definita, e il soggetto forte, coerente. L'io si disgrega, si smarrisce e questa crisi dell'idea di identità risente delle mutazioni in atto nella realtà contemporanea. L'idea classica dell'individuo creatore del proprio destino ora tramonta: l'individuo, infatti, non conta più, si indebolisce, e diventa nessuno.
L'avvertire di essere "nessuno" provoca nell'uomo un senso di angoscia e orrore, generando un senso di solitudine. Pertanto l'uomo "si vede vivere", si esamina dall'esterno, imponendo una sua maschera, una sua parte. Tutte queste forme sembrano vere e proprie trappole, come un carcere, e in questo contesto Pirandello pensa che la società sia come un'enorme "pupazzata", una costruzione fittizia che impoverisce l'uomo. Le maschere di tutti gli uomini tendono a creare così una differenza fra "persona" - ossia essere umano cosciente di sé, con personalità intera e coerente, fondata su passione e ragione, insomma integrità dell'individuo - e "personaggio", che recita una parte a seconda dell'esigenza, per le convenzioni che sono imposte in ogni contesto. Questa duplicità dell'essere umano evidenza il contrasto fra forma e vita: la forma è quell'insieme di regole e convenzioni che l'uomo si dà per credere che la vita abbia un senso; egli organizza la propria vita secondo questi certi parametri e quindi non vive più in quanto integro, ma è cangiante secondo necessità. Si intersecano così maschera e forma, poiché la maschera diventa la parte recitata e la forma la determinazione della maschera per tutta la vita. La forma blocca lo slancio vitale, che è alla base dell'esistenza umana. Qualsiasi personaggio ha davanti a sé due scelte: la prima è quella di vivere nell'ipocrisia e nell'adeguamento alle forme, la seconda, vivere consapevolmente e autoironicamente la distinzione tra forma e vita, che, inevitabilmente, porta ad avere una visione della vita piuttosto che a vivere la vita. Da qui scaturisce la riflessione, che sarà sempre alla base dell'umorismo, e sarà carattere distintivo della poetica pirandelliana. L'esempio più famoso sulla riflessione umoristica è il seguente: << Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata di abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s'inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l'umoristico>>. Pirandello, dunque, sottolinea la differenza fondamentale tra i diversi modi di fare ridere, il comico e l'umoristico: nel comico, il riso scaturisce da semplice avvertimento del contrario, poiché, appunto, quella situazione o quell'individuo sono il contrario di come dovrebbero essere; nell'umorismo si cerca di andare oltre l'apparente motivo del riso con la riflessione, dalla quale nasce il sentimento del contrario (che è superamento del comico attraverso il comico): riflettendo infatti sulle ragioni per le quali una situazione o un uomo sono il ''contrario''di quel che dovrebbero essere, al riso subentra un sentimento amaro, corrispondente quasi alla pietà. Questa concezione del riso si differenzia anche dalla satira e dall'ironia: nella satira, con la riflessione cesserebbe lo sdegno, ossia l'avversità alla realtà che ogni satira propone (nelle satire, infatti, si mettono in evidenza i difetti degli uomini, cogliendone gli aspetti più negativi, con l'intento di riportare gli uomini sulla retta via); nell'ironia, la differenza tra momento comico e drammatico sta solo nell'accento dato alle parole, in quanto se fosse effettiva, la battuta perderebbe la naturalezza che la caratterizza, assumendo un significato completamente diverso dal proponimento.



![]()
![]()

 Un'altra importante correlazione
tra battuta e sorriso potrebbe condurci al circuito di Faraday: possiamo
paragonare la corrente elettrica che parte dal primo circuito ad una battuta, e
l'effetto che produce ad un sorriso come reazione della stessa. Ponendo come punto
di riferimento il disegno (sopra), abbiamo nel circuito primario una batteria,
un interruttore e una resistenza per variare la corrente, ed al termine del
circuito una bobina con una serie di avvolgimenti intorno ad una barretta di
ferro; il secondo circuito comincia, invece, dagli avvolgimenti della bobina
attorno alla barretta, per terminare in un amperometro, strumento che troveremo
di particolare importanza nella rilevazione del cambiamento di corrente.
Chiudendo ora l'interruttore nel primo circuito, avvieremo la corrente che, sebbene
non ci sia contatto fisico, passerà nel circuito secondario attraverso la
barretta di metallo; la variazione avvenuta sarà rivelata dallo strumento
misuratore, prima che la lancetta torni nuovamente sul valore nullo iniziale.
Questo effetto momentaneo è dovuto appunto alla variazione, che permette poi al
flusso di corrente d'essere costante; la lancetta dell'amperometro resterà sul
valore nullo fino ad un'altra, qualsiasi, variazione. Aprendo l'interruttore e interrompendo così la corrente, avremo una
seconda variazione di corrente, che permetterà alla lancetta di spostarsi
nuovamente, questa volta nella direzione opposta alla variazione precedente, prima
di tornare alla posizione iniziale. Da questo semplice esempio, ricaviamo che
la corrente nel secondo circuito sarà sempre nulla finchè la corrente nel
circuito primario sarà costante (sebbene nulla) e che, al passaggio di corrente
(quando ci sarà una variazione), la lancetta dell'amperometro si muoverà in
sensi diversi a seconda di un aumento o diminuzione di corrente. L'esempio di
Faraday è importante per la scoperta della corrente indotta, ossia quando non
vi è contatto tra due circuiti e, più specificatamente, della forza
elettromotrice indotta, creata da un campo magnetico variabile. Esiste chiaramente
una formula per quantificare la
variazione del campo magnetico, ma prima di arrivarci abbiamo bisogno di una
considerazione sul flusso del campo magnetico. Prendiamo per convenzione un
solo avvolgimento di una bobina (con superficie indeterminata A) e il campo
magnetico B che lo attraversa; potremo avere tre modalità di attraversamento, dipendenti
dall'inclinazione della superficie che deve essere attraversata: infatti, se la
superficie sarà attraversata perpendicolarmente dal campo magnetico, avremo la
formula semplice Ф=BA, mentre se la superficie sarà parallela alla
direzione del campo magnetico il flusso sarà nullo. Questa dimostrazione può
essere spiegata se consideriamo che nella formula semplice è stato annullato il
fattore coseno dell'angolo, che ci permette di conoscere l'inclinazione della
superficie rispetto al campo magnetico: sapendo i valori massimo e minimo del
coseno (1 e -1) concluderemo che quando la superficie è perpendicolare il
coseno sarà uguale a 1, diventando così la formula semplice, mentre quando la
superficie è parallela la componente sarà 0, annullando gli altri valori. Sarà
così importante rilevare sempre la componente coseno di un angolo per conoscere
la quantità di flusso attraverso la superficie presa in considerazione (che per
convenzione sarà, come abbiamo detto, un unico avvolgimento di una bobina).
Dalle due importanti dimostrazioni sulla quantificazione del flusso magnetico e
sulla variazione di esso, ricaviamo la legge di Faraday, dovuta al flusso del
campo magnetico (componente ΔФ) e alla rapidità di variazione nel
tempo (con la componente Δt). Per un solo avvolgimento della bobina la
formula sarà: - ΔФ/ Δt (nella prima sarà calcolato il valore del
flusso finale sottratto a quello iniziale, nella seconda sarà la componente
finale meno quella iniziale del tempo). Sottolineando che nella precedente
formula Ф è il flusso che attraversa un singolo avvolgimento, e che una
bobina ha invece più avvolgimenti, per calcolare la forza elettromotrice
indotta in una bobina si userà la lettera maiuscola N per indicare il numero di
giri.
Un'altra importante correlazione
tra battuta e sorriso potrebbe condurci al circuito di Faraday: possiamo
paragonare la corrente elettrica che parte dal primo circuito ad una battuta, e
l'effetto che produce ad un sorriso come reazione della stessa. Ponendo come punto
di riferimento il disegno (sopra), abbiamo nel circuito primario una batteria,
un interruttore e una resistenza per variare la corrente, ed al termine del
circuito una bobina con una serie di avvolgimenti intorno ad una barretta di
ferro; il secondo circuito comincia, invece, dagli avvolgimenti della bobina
attorno alla barretta, per terminare in un amperometro, strumento che troveremo
di particolare importanza nella rilevazione del cambiamento di corrente.
Chiudendo ora l'interruttore nel primo circuito, avvieremo la corrente che, sebbene
non ci sia contatto fisico, passerà nel circuito secondario attraverso la
barretta di metallo; la variazione avvenuta sarà rivelata dallo strumento
misuratore, prima che la lancetta torni nuovamente sul valore nullo iniziale.
Questo effetto momentaneo è dovuto appunto alla variazione, che permette poi al
flusso di corrente d'essere costante; la lancetta dell'amperometro resterà sul
valore nullo fino ad un'altra, qualsiasi, variazione. Aprendo l'interruttore e interrompendo così la corrente, avremo una
seconda variazione di corrente, che permetterà alla lancetta di spostarsi
nuovamente, questa volta nella direzione opposta alla variazione precedente, prima
di tornare alla posizione iniziale. Da questo semplice esempio, ricaviamo che
la corrente nel secondo circuito sarà sempre nulla finchè la corrente nel
circuito primario sarà costante (sebbene nulla) e che, al passaggio di corrente
(quando ci sarà una variazione), la lancetta dell'amperometro si muoverà in
sensi diversi a seconda di un aumento o diminuzione di corrente. L'esempio di
Faraday è importante per la scoperta della corrente indotta, ossia quando non
vi è contatto tra due circuiti e, più specificatamente, della forza
elettromotrice indotta, creata da un campo magnetico variabile. Esiste chiaramente
una formula per quantificare la
variazione del campo magnetico, ma prima di arrivarci abbiamo bisogno di una
considerazione sul flusso del campo magnetico. Prendiamo per convenzione un
solo avvolgimento di una bobina (con superficie indeterminata A) e il campo
magnetico B che lo attraversa; potremo avere tre modalità di attraversamento, dipendenti
dall'inclinazione della superficie che deve essere attraversata: infatti, se la
superficie sarà attraversata perpendicolarmente dal campo magnetico, avremo la
formula semplice Ф=BA, mentre se la superficie sarà parallela alla
direzione del campo magnetico il flusso sarà nullo. Questa dimostrazione può
essere spiegata se consideriamo che nella formula semplice è stato annullato il
fattore coseno dell'angolo, che ci permette di conoscere l'inclinazione della
superficie rispetto al campo magnetico: sapendo i valori massimo e minimo del
coseno (1 e -1) concluderemo che quando la superficie è perpendicolare il
coseno sarà uguale a 1, diventando così la formula semplice, mentre quando la
superficie è parallela la componente sarà 0, annullando gli altri valori. Sarà
così importante rilevare sempre la componente coseno di un angolo per conoscere
la quantità di flusso attraverso la superficie presa in considerazione (che per
convenzione sarà, come abbiamo detto, un unico avvolgimento di una bobina).
Dalle due importanti dimostrazioni sulla quantificazione del flusso magnetico e
sulla variazione di esso, ricaviamo la legge di Faraday, dovuta al flusso del
campo magnetico (componente ΔФ) e alla rapidità di variazione nel
tempo (con la componente Δt). Per un solo avvolgimento della bobina la
formula sarà: - ΔФ/ Δt (nella prima sarà calcolato il valore del
flusso finale sottratto a quello iniziale, nella seconda sarà la componente
finale meno quella iniziale del tempo). Sottolineando che nella precedente
formula Ф è il flusso che attraversa un singolo avvolgimento, e che una
bobina ha invece più avvolgimenti, per calcolare la forza elettromotrice
indotta in una bobina si userà la lettera maiuscola N per indicare il numero di
giri.
Anche il filosofo Henry Bergson teorizzò il riso in uno dei suoi saggi. Le riflessioni sulla natura della comicità in generale sono esplicitate nel libro ''Il riso. Saggio sul significato del comico''; punti chiave del testo sono chiari e semplici: funzione del ridere, relazione tra riso e diavolo a molla, comicità morale e funzione della commedia, il riso nella metafisica. Bergson collega magistralmente questi punti, in modo tale da esistere uno in funzione dell'altro. Il primo punto verte sull'idea del riso nella società, più particolarmente quale fine lo anima e le occasioni in cui accade; sottolinea tre punti fondamentali: il primo tratta la comicità che fa riferimento puramente all'ambito umano (''non vi è nulla di comico al di fuori di ciò che è propriamente umano''), nel quale ambito riconduciamo anche oggetti che apparentemente non ne fanno parte, come un cappello o di un burattino di legno. Se, però, non ci fermiamo alla constatazione ovvia che siano degli oggetti, ma che il cappello possa far riferimento ad un vizio estetico umano e un burattino ad un uomo che compie gesti impacciati, possiamo aggiungere alla massima antica, secondo la quale l'uomo è l'animale che ride, una moderna: l'uomo è un animale che fa ridere; il secondo punto tratta l'emotività e il disinteressamento nell'azione che porta al riso: l'uomo, secondo il filosofo, potrà ridere di una piccola disgrazia solo quando riuscirà a far tacere per un attimo i sentimenti di pietà o simpatia, porgendosi come semplici spettatori disinteressati (''il comico esige, per produrre tutto il suo effetto, qualcosa come un'anestesia momentanea del cuore''); infine il terzo punto parla dell'attività sociale del ridere, esperienza assolutamente migliore quando si è con altri; Bergson intenderà il riso in queste occasioni come il cemento che tiene unito un gruppo di persone (''il riso cela sempre un pensiero nascosto di intesa, direi quasi di complicità, con altre persone che ridono''). Potremmo in definitiva riunire questi tre punti in un'unica tesi: il comico, e quindi la comicità, nascono quando un gruppo di persone porge l'attenzione su un solo uomo, facendo momentaneamente tacere la propria sensibilità.
Per individuare i motivi del ridere non basta scoprire quando ridiamo, ma dobbiamo scoprirne il perché: è il caso dell'esempio del diavolo a molla, un giocattolo che fa tanto ridere i bambini; Bergson ne esplicita la funzione - lo si schiaccia ed ecco che si raddrizza, lo si ricaccia più in basso ed esso rimbalza più in alto, lo si scaccia sotto il coperchio ed ecco che fa saltare tutto - commentando questa azione come ''conflitto di due ostinazioni, di cui una puramente meccanica finisce ordinariamente per cedere all'altra, che se ne prende gioco''. Un comportamento rigidamente meccanico applicato alla realtà umana: potremmo paragonare, ad esempio, una marionetta che compie gesti goffi e meccanici con un uomo che - arrivato alla fine delle scale - tenta di scendere un ultimo gradino inesistente, con un gesto non motivato, se non dal meccanismo acquisito nella discesa. La comicità sorge anche dalla ripetizione, e dalla staticità, di azioni e pensieri: un tic o una ripetizione di una frase può essere causa di ilarità, così come una frase ripetuta troppe volte, due facce rassomiglianti che però - ammette Bergson - prese singolarmente non fanno ridere, o anche una caricatura che, nella sua staticità, porta al ridere se se ne evidenziano tratti espressivi particolari. Commentando il pensiero bergsoniano, potremmo concludere che nella vita le cose che portano al ridere sono senz'altro quelle frutto di una meccanizzazione della realtà. Da qui, secondo il filosofo, la differenza tra attori tragici, che devono stare attenti ai gesti perché non tradiscano le esigenze della corporeità, e attori comici, che invece potranno servirsi di un singhiozzo fastidioso o un malanno per condurre al riso.
Dalle considerazioni in precedenza fatte possiamo tornare alla domanda
sul fine del riso. Bergson ha osservato che esso ha una funzione sociale, sottolineando
che si tratta di una sorta di contraddizione che deve essere sanata: al riso
spetta il compito di richiamare una parte della società a causa di un
atteggiamento rigido, mentre essa si ostina ad avere un comportamento più
elastico: ''è comico un qualunque individuo che segua automaticamente il suo
cammino senza darsi pensiero di prendere contatto con gli altri.[.]
Bisogna che ciascuno dei membri della
società stia attento a ciò che gli è intorno, si modelli su quello che lo
circonda, eviti di rinchiudersi  nel suo carattere. Perciò essa fa
dominare su ciascuno, se non la minaccia di una correzione, almeno la
prospettiva di una umiliazione.[.] Tale si presenta la funzione del riso.
Sempre un po' umiliante per chi ne è l'oggetto, il riso è una specie di castigo
sociale''. Bergson trova tra commedia e sfera sociale un rapporto strettissimo,
che sfocia nella comicità morale. Spesso i sentimenti ci coinvolgono tanto da
diventare nostri burattinai,da comandare ogni nostro singolo gesto: così appare
nella commedia, dove un personaggio è mosso da un'unica passione, riusciamo
così a prevederne i movimenti, e quindi ridiamo. Da qui nasce la commedia non
dei soliti personaggi che entrano in scena per recitare, ma delle passioni che
li governano: queste dovrebbero portare a correggere i costumi, perché al
contrario delle forme artistiche pure, si contrappone questa forma,
assolutamente spuria, che entra nella vita dell'uomo con una precisa finalità.
L'uomo - secondo Bergson - ha sempre una intenzione non confessata di umiliare,
comunque per correggere: solo il riso appare come una momentanea negazione
della vita per sanarne i problemi.
nel suo carattere. Perciò essa fa
dominare su ciascuno, se non la minaccia di una correzione, almeno la
prospettiva di una umiliazione.[.] Tale si presenta la funzione del riso.
Sempre un po' umiliante per chi ne è l'oggetto, il riso è una specie di castigo
sociale''. Bergson trova tra commedia e sfera sociale un rapporto strettissimo,
che sfocia nella comicità morale. Spesso i sentimenti ci coinvolgono tanto da
diventare nostri burattinai,da comandare ogni nostro singolo gesto: così appare
nella commedia, dove un personaggio è mosso da un'unica passione, riusciamo
così a prevederne i movimenti, e quindi ridiamo. Da qui nasce la commedia non
dei soliti personaggi che entrano in scena per recitare, ma delle passioni che
li governano: queste dovrebbero portare a correggere i costumi, perché al
contrario delle forme artistiche pure, si contrappone questa forma,
assolutamente spuria, che entra nella vita dell'uomo con una precisa finalità.
L'uomo - secondo Bergson - ha sempre una intenzione non confessata di umiliare,
comunque per correggere: solo il riso appare come una momentanea negazione
della vita per sanarne i problemi.
Il grande filosofo tratta, nell'ultima parte del suo libro, un argomento alquanto imprevedibile: si chiede se possa esistere un addestramento che, fin da piccoli, ci insegni di cosa e quando è giusto ridere. Anzitutto, anteponiamo al discorso il già trattato pensiero per cui quando viene suscitato il riso è per castigo sociale, in contrapposizione al ridere di una faccia buffa: il riso castiga anche quando non ce n'è bisogno. In secondo luogo l'autore tratta la diversità di porsi nelle eventuale situazioni comiche: una passione - avarizia, gelosia, per citarne alcune - può talvolta suscitare il riso, talvolta il disprezzo, a seconda del modo in cui essa ci si palesa, e dal momento in cui essa ci viene presentata.
Il riso diventa un gesto sociale, immediato nell'animo umano, che - a detta di Bergson - ''non ha tempo di osservare sempre dove tocca, talvolta castiga certi difetti come la malattia castiga certi eccessi, colpendo gli innocenti, risparmiando i colpevoli, mirando verso un risultato generale, senza preoccuparsi del singolo''. Da qui, la finale considerazione che il riso non sia il frutto di un allenamento, di un addestramento al riso, ma faccia parte di una autentica metafisica della vita.
Dopo aver esaminato in modo interdisciplinare l'argomento mi corre l'obbligo di concludere questo lavoro con considerazioni oltremodo personali, e riportare quindi, in particolar modo, "il sorriso" nella vita quotidiana. Oramai tutti i rapporti personali sono pressocché freddi; la rapidità del succedersi degli eventi non ci da il tempo di soffermarci sui gesti e sui comportamenti che potrebbero dare conforto e coraggio. L'essere pieni di noi stessi non lascia spazio alle emozioni che un sorriso suscita. Eppure basterebbe soffermarsi un momento a riflettere, come durante un dialogo, tra le parole: il sorriso può rafforzare un concetto o un sentimento. E' opinione comune che un sorriso aiuta ad affrontare meglio un momento di difficoltà ed a far volgere al meglio un episodio sgradevole. Il calore che un sorriso procura a chi è ammalato e quello intrigante tra due persone che si vogliono bene non può essere compensato in alcun modo da parole. Non è possibile considerare il sorriso come una forma di compiacimento, il suo valore è enorme se spontaneo; non è difficile interpretare un sorriso, il difficile è mascherare una finalità diversa.
La testimonianza vivente è il tenero sorriso che un bambino restituisce alla sua mamma.

Per concludere questa tesina, ho scelto una poesia di Gino Mazzella, molto profonda e concreta, per rafforzare l'idea che il sorriso nella vita sia tanto importante quanto il vivere stesso.
Un sorriso non costa niente e produce molto arricchisce chi lo riceve,
senza impoverire chi lo da.
Dura un solo istante,
ma talvolta il suo ricordo è eterno.
Nessuno è così ricco da poter farne a meno,
nessuno è abbastanza povero da non meritarlo.
Crea la felicità in casa,
è il segno tangibile dell'amicizia,
un sorriso dà riposo a chi è stanco,
rende coraggio ai più scoraggiati,
non può essere comprato, nè prestato, nè rubato,
perché è qualcosa di valore solo nel momento in cui viene dato.
E se qualche volta incontrate qualcuno
che non sa più sorridere,
siate generoso,dategli il vostro,
perché nessuno ha mai bisogno di un sorriso
quanto colui che non può regalarne ad altri.
Geografia
astronomica: La
luna Inglese:
moon landing

Filosofia:Bergson il riso
Latino:
satira, seneca, persio, giovenale;
marziale Fisica:
circuito primario e secondario; legge di faraday
Arte:
Dada, Duchamp; Surrealismo, Magritte Storia:
new deal
 |
| Appunti su: |
|
| Appunti Archeologia |  |
| Tesine Geografia | 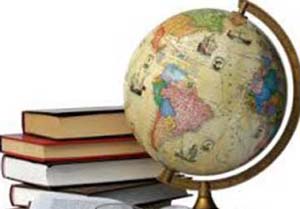 |
| Lezioni Ecologia ambiente |  |