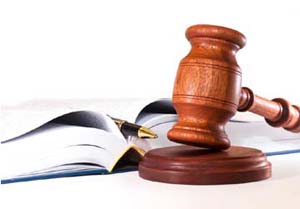Tipologia e posizione delle norme consuetudinarie nel sistema delle
fonti
Anche per quanto concerne il rango spettante alle consuetudini le
soluzioni offerte dalle "preleggi" si dimostrano troppo riduttive. Con quel
fondamento, si potrebbe addirittura sostenere l'ammissibilità delle sole
consuetudini secundum legem. In effetti l'art. 8 primo comma delle disposizioni
preliminari al Codice civile afferma unicamente che "nelle materie regolate
dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da
essi richiamati"; e se per "materie" si intendessero i vari settori
dell'ordinamento giuridico, bisognerebbe escludere che sussista spazio per una
normazione consuetudinaria indipendente. Vero è che delle consuetudini
integrative sarebbe dato ragionare in vista dello stesso art. 8 delle
"preleggi", sostenendo che esso presupponga l'esistenza di "materie" non
disciplinate né in via legislativa né in via regolamentare. Se mai, proprio le
norme consuetudinarie secundum legem sarebbero dotate di maggiore forza nei
confronti di quelle integrative, giacché assumerebbero "l'efficacia stessa
della norma rinviante", legislativa o regolamentare secondo le diverse ipotesi.
Ad arricchire la tipologia delle consuetudini concorre l'art. 10 primo
comma Cost., per cui "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute". Un'autorevole dottrina
ritiene che si tratti di un principio implicante l'adattamento automatico del
diritto italiano all'intero diritto internazionale. Ma la ricostruzione di gran
lunga prevalente è invece nel senso che la conformità prescritta dalla
Costituzione non riguardi i trattati, bensì le sole consuetudini
internazionali. Continua per altro ad imporsi il congegno dell'adattamento automatico:
con la conseguenza che, ogniqualvolta si possa riscontrare la vigenza di una
consuetudine internazionale, ad essa si conforma immediatamente il diritto
interno. La corte costituzionale ha in sostanza fatto propria questa tesi,
sostenendo che nei rapporti fra la costituzione e le consuetudini preesistenti
andrebbe applicato il "principio di specialità", con la conseguenza di
risolvere gli eventuali contrasti a favore delle norme consuetudinarie.
Rispetto alle leggi ordinarie le norme di adattamento al diritto internazionale
generale dispongono di una competenza costituzionalmente riservata. Pertanto le
posteriori norme legislative contrastanti con le consuetudini in esame debbono
ritenersi illegittime.
In secondo luogo anche le consuetudini costituzionali detengono un
rango ben diverso da quello proprio degli usi. Occorre premettere che tutte le
costituzioni scritte presentano lacune più o meno ampie, con particolare
evidenza per ciò che riguarda l'organizzazione costituzionale dello Stato. Ma
anche nel caso delle costituzioni "lunghe" come quella vigente in Italia, le
lacune costituzionali non mancano e non sempre si prestano a venire colmate
dalle leggi, perché la soluzione dei rispettivi problemi dev'essere a volte
rintracciata sul piano costituzionale e non sul piano legislativo ordinario. Si
danno anzi ipotesi in cui la Carta costituzionale sembra disporre in termini
organici e compiuti, ma viene viceversa intesa dagli operatori come se si
trattasse di un testo lacunoso. Non tutte le lacune costituzionali comportano,
però, l'insorgere di altrettanti consuetudini. In un primo tempo, quando ancora
difetta il dato della costante ripetizione, in quegli ambiti sogliono formarsi
puntuali convenzioni, vale a dire accordi fra i titolari degli organi costituzionali.
Più di una di tali convenzioni di rivela in suscettibile di tradursi in
consuetudine: sia perché non si presta a venire ripetuta, sia perché il termine
convenzione può mantenere un valore puramente politico, senza integrare in
alcun modo la Costituzione. Ma laddove l'usus e l'opinio si combinano, le
convenzioni si trasformano in fonti normative; ed è questo, di regola, il
processo formativo delle consuetudini costituzionali. Non vi è dubbio che il
procedimento di formazione del governo sia solo parzialmente regolato dall'art.
92 Cost.; ed è sostenibile che la Costituzione sia stata dunque integrata
mediante consuetudini ormai stabilizzate da vari decenni. Ora consuetudini
siffatte non sono certo subordinate alle leggi ordinarie, bensì sopraordinate
ad esse. Nell'integrare la Costituzione, tali fonti non pongono regole
indifferenti dal punto di vista costituzionale, modificabili o derogabili ad
arbitrio da parte dei medesimi soggetti o ad opera dei medesimi organi che le
hanno poste in essere. Non a caso, la prevalente dottrina ha sostenuto che i
"conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato", vadano affrontati facendo
ricorso alle consuetudini che si fossero formate sul punto; e questa tesi ha
trovato un preciso riscontro sua nella sentenza del 10 luglio con cui la corte
costituzionale ha fatto applicazione dei "principi non scritti, manifestati o
consolidatisi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi".
Diverso, ma non del tutto dissimile nelle conclusioni ultime, è il discorso
da svolgere per le cosiddette "consuetudini interpretative". Tale locuzione è
stata più volte utilizzata nella nostra dottrina, per evidenziare il fatto che
tutte le norme giuridiche rivestono un senso preciso nel momento in cui sono
interpretate ed applicate in un determinato modo piuttosto che in termini
diversi. Ma anche in Italia non vi è dubbio che il momento applicativo delle
varie fonti normative assuma una determinante importanza, sebbene il precedente
giurisprudenziale non rappresenti a sua volta un'autonoma fonte. Nel nostro
ordinamento, quanto alle stesse leggi ed agli altri atti normativi, resta fermo
cioè che il Parlamento e le diverse autorità emananti gli atti in questione
determinano solo le disposizioni. Ma in vario senso può dirsi che le
disposizioni non coincidono con le rispettive norme; ciò che più conta è che da
ogni disposizione si possano ricavare alternativamente norme fra loro diverse.
È un dato di esperienza che la norma vive, nella sua concretezza, "solo nel
momento in cui viene applicata". Ed è un punto fermo che il Parlamento non può
predeterminare integralmente il momento applicativo, sebbene le stesse
disposizioni preliminari al codice civile impongano di intendere la legge nel
senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione
di esse, e dalla intenzione del legislatore". L'interpretazione letterale e
quella fondata sui lavori preparatori si rivelano spesso insufficienti e devono
cedere il passo all'interpretazione logico-sistematica. Ed è per questa via che
si realizza il distacco fra la disposizione e la norma, fra il diritto scritto
e il diritto vivente, in ogni singolo momento storico. Ciò non significa ancora
che le "consuetudini interpretative" prodotte dalla giurisprudenza dominante
vadano confuse con le vere e proprie fonti del diritto. Si tratta piuttosto dei
concreti modi di essere delle norme giuridiche, contrapposte alle
corrispondenti disposizioni normative, fermo restando che le fonti propriamente
dette sono pur sempre le leggi, i regolamenti e via dicendo. Il che spiega come
le "consuetudini" in esame non abbiano rango comune ma facciano corpo con le
varie norme così ricavate.