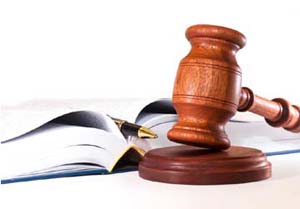Le riserve di legge ed il principio di legalità
Per preferenza di legge si intende nell'ambito della competenza
legislativa ordinaria il caso in cui la legge prevale sulle fonti di rango
inferiore. Tuttavia i rapporti fra le fonti predette si alterano, allorché la
costituzione stabilisce, per la disciplina di determinati oggetti, altrettante
riserve di legge. Tali riserve comportano una limitazione della potestà
legislativa, eliminando o riducendo quella libera scelta fra una disciplina
disposta per legge ed una disciplina demandata dalla legge ad altre fonti,
della quale il parlamento è comunemente dotato. In regime di costituzione
rigida invece, le riserve di legge vincolano precisamente il potere
legislativo; giacché il legislatore che non facesse direttamente fronte al
compito in tal modo conferitogli violerebbe le prescrizioni costituzionali.
Qualora la legge istituisse una potestà regolamentare in materia
costituzionalmente riservata alla legislazione ordinaria, illegittime sarebbero
non solo le norme regolamentari adottate con quel fondamento dal potere
esecutivo, bensì le norme legislative concernenti l'attribuzione della potestà
medesima.
La Corte Costituzionale ritiene infatti che "il principio della riserva
legislativa" sia rispettato quand'anche la materia venga regolata a mezzo di
leggi delegate o di decreti-legge. Per asserire il contrario, non basta una
generica riserva, ma occorre che si tratti di una riserva di legge formale;
tale figura non ricorre se non allorché ci si trovi in presenza di espressi e
tassativi riferimenti costituzionali alle Camere del Parlamento o quando,
comunque, lo esiga la natura delle delibere legislative in questione. Più grave
è il problema se le riserve di legge riguardino la sola legislazione statale
oppure includano anche la legislazione regionale, quanto ai settori di
competenza propria delle regioni ordinarie e speciali. In un primo tempo, la
Corte Costituzionale aveva senz'altro ritenuto che "la Costituzione si
riferisca soltanto alla legge dello Stato". In un secondo tempo tuttavia, il
rigore dell'originario assunto è stato assai temperato: giacché la corte ha
riconosciuto che le regioni possono legiferare negli stessi ambiti
costituzionalmente riservati alla legge. Ancor più fondamentale è poi la
distinzione fra riserve assolute e riserve relative. Le prime comprendono tutti
gli oggetti la cui disciplina debba essere integralmente dettata dalle leggi.
Relative sono invece le riserve in vista della quali il legislatore è tenuto a
dettare soltanto la disciplina di principio, ovvero a fornire la base legislativa
delle conseguenti attività amministrative.
Qualunque sia la natura delle riserve, è da ritenere che il limite
stesso presenti un carattere specifico: cioè non sussista al di fuori delle
ipotesi in cui sia puntualmente riscontrabile. Anche in questo senso può ben
dirsi che vigano riserve implicite, pur dove la Carta costituzionale non
rimandi alla legge. Vero è che in dottrina si suole ragionare di un generale
principio di legalità dell'amministrazione; ma il principio medesimo non deve
essere confuso con le riserve di legge. Innanzitutto si dimostra dubbia e
controversa la stessa portata della legalità di cui si tratta: taluni la
intendono in senso puramente formale; altri affermano che ogni potere
amministrativo dovrebbe trovare puntuale fondamento in una norma attributiva:
altri ancora ritengono indispensabile l'interpositio legislatoris, cui dunque
spetterebbe di fondare ed individuare tutti i potere in questione; e finalmente
vi è chi si spinge fino al punto di considerare costituzionalmente indispensabile
che il legislatore prestabilisca lo schema di ogni attività amministrativa,
intendendo pertanto la legalità in un senso sostanziale e traducendola in un
limite delle leggi stesse.
Stando al diritto "vivente", la legalità può dunque definirsi come un
limite della funzione amministrativa e non come un limite della funzione
legislativa dello Stato.