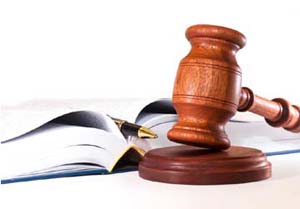I "diritti di famiglia"; i rapporti fra coniugi; le potestà genitoriali
e i rapporti di filiazione
La celebre proposizione costituzionale, per cui la repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ha
offerto lo spunto alle più varie ed antitetiche ricostruzioni. Da un lato, si è
sostenuto che la "società" in questione sarebbe titolare di propri diritti,
distinti da quelli dei singoli individui che la compongono, e dunque
disporrebbe di una propria soggettività, avvicinabile a quella spettante alle
persone giuridiche. Ma, d'altro lato, è stato per contro affermato che la
famiglia ricadrebbe nel novero delle formazioni sociali considerate dall'art. 2
Cost., pur avendo un carattere peculiare ed anzi privilegiato, dato il favor
familiare che informa gli art. 31, 36 e 37; con l'ulteriore conseguenza che i
"diritti della famiglia" non sarebbero altro che una "sintesi verbale", basata
pur sempre sulle posizioni attive e di vantaggio, spettanti a ciascun
componente il gruppo familiare. È tuttavia preferibile l'opinione intermedia,
che intende i "diritti della famiglia" come sinonimo di una sfera di
autodeterminazione, riconosciuta "ai singoli nella specifica qualità di membri
della famiglia" medesima: sfera nella quale la legge non può arbitrariamente
penetrare, sicché i componenti del nucleo familiare hanno appunto il diritto do
organizzarsi senza rispettare modelli precostituiti. Dell'art. 29 si deve
comunque desumere, in altre parole, una "garanzia costituzionale di rispetto
dell'autonomia familiare", pur senza che questa si trasformi in "sovranità". La
comunità garantita dall'art. 29 consiste però nella sola famiglia legittima. La
cosiddetta famiglia di fatto, inclusiva della convivenza more uxorio, non ha in
questa sede rilievo. Senza dubbio, anch'essa rientra fra le formazioni sociali
genericamente riguardate dall'art. 2; ma non ne deriva l'esigenza di
equipararla integralmente alla famiglia legittima. Per società familiare si
intende in maniera ormai pacifica la cosiddetta famiglia nucleare. L'indirizzo
giurisprudenziale privilegia invece la famiglia legittima comprensiva del
coniuge e dei figli, ad esclusione di ogni altro soggetto.
Non meno controverso si è rivelato l'ambiguo e compromissorio capoverso
dell'art. 29: "il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
L'opinione prevalente dice che sia l'eguaglianza coniugale che le
deroghe finalizzate all'unità della famiglia vadano concepite in senso
strettissimo.
Ma il passo determinante è stato fatto in parlamento, con
l'approvazione della legge 19 maggio 1975. Basti qui ricordare che "con il
matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri"; e che "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita
familiare".
Già in partenza, l'affermazione del principio di eguaglianza risultava
assai più netta in tema di rapporti fra genitori e figli minori. Da un lato,
perciò, la costituzione fissa senz'altro il principio della parità dei
genitori. D'altro lato, ciò che si ricava dall'art. 30 primo comma è il
principio della parità dei figli: non avendo alcun rilievo la circostanza che
si tratti di figli legittimi o naturali o anche adulterini o incestuosi. Quanto
ai genitori appare letteralmente chiaro che il loro potere-dovere è dunque un
ufficium, che non può venire usato o trascurato ad arbitrio. Al limite, la
legge 4 maggio 1983 prescrive ora che siano dichiarati "in stato di
adattabilità i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza
morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi".
Quanto invece ai figli, è proprio la costituzione ad escludere che spettino
loro, malgrado il detto principio di parità, posizioni di assoluta eguaglianza
reciproca.