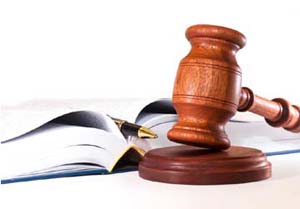Gli organi dello Stato-soggetto
Di fronte ad uno Stato-soggetto ovvero di uno Stato-persona si
ripropone subito il problema, comune a tutte le persone giuridiche, del come
essi possano disporre della capacità di agire, cioè di compiere gli atti di
esercizio delle loro attribuzioni. Secondo l'impostazione tradizionale del
problema, le persone giuridiche difetterebbero di tale attitudine, se questa
non fosse loro fornita da persone fisiche o più generalmente da esseri umani,
collegati ad esse da particolari rapporti: i quali, a loro volta, sono stati e
sono alternativamente costituiti dal rapporto di rappresentanza e dal rapporto
organico. Basti qui ricordare che quello di rappresentanza è un rapporto
"trilatero", che vede agire un soggetto rappresentato, un soggetto rappresentante
ed un soggetto terzo, con la conseguenza che sul rappresentato ricadono solo
gli effetti dell'atto compiuto dal rappresentante, stipulando ad esempio un
contratto con un terzo; al che si aggiunge che, nel nostro ordinamento, il
rappresentato non è vincolato dall'atto del rappresentante altra che "nei
limiti delle facoltà conferitegli". Di più: il rapporto organico può bene
restare fermo pur quando l'atto in questione sia invalido, giacché lo Stato
continua a rispondere di esso nei confronti di terzi.
Negli ultimi decenni viene introdotta l'idea che l'azione degli
apparati statali sia resa possibile da apposite entità, aventi il nome di
organi. Evidentemente gli organi non possono risolversi negli individui in
questione, ma presuppongono apposite strutture delle quali gli individui stessi
facciano parte integrante, agli effetti dei rapporti organici. In questo senso
riesce indispensabile ricorrere alla nozione di ufficio, inteso non tanto alla
stregua di una o più funzioni pubbliche, quanto come articolazione
dell'apparato statale cui spetti l'esercizio di un determinato complessi di
funzioni. Ed ogni organo implica appunto un ufficio munito del suo titolare,
senza di che gli mancherebbe la capacità di porre in essere gli atti da
imputare allo Stato. Viceversa non tutti gli uffici statali corrispondono ad
altrettanti organi: infatti "sono organi solo quegli uffici che le norme
indicano come idonei ad operare l'imputazione giuridica dell'ente". Nello
stesso ambito di attività delle strutture comunemente definite quali organi,
occorre anzi distinguere fra gli atti da imputare all'intero apparato statale e
quelli che i funzionari compiono ai fini dei loro uffici, ma senza che si
determini l'imputazione predetta: come si verifica per le interrogazioni e per
le interpellanze in seno alle assemblee parlamentari.
Anche in questi termini la tipologia degli organi rimane alquanto
varia. Occorre distinguere fra gli organi individuali (come è il Presidente
della Repubblica) e gli organi collegiali, nei quali la volontà dell'organo è
formata da una serie di individui componenti il collegio (come si verifica per
le Camere del Parlamento); ancora, occorre distinguere fra gli organi semplici
e gli organi complessi, a formare i quali concorrono organi minori, tanto
individuali quanto collegiali (come nel caso del Governo della Repubblica).
Giova inoltre notare che certi organi possono essere codipendenti da più
persone giuridiche pubbliche: come può dirsi del Sindaco, che per verso è
l'organo di vertice dell'amministrazione comunale, per l'altro ha la veste di
"ufficiale del Governo".
E' necessario evitare la contraddizione in termini coesistenti
dell'identificazione fra organo e Stato-soggetto, in quanto entrambi muniti di
una propria personalità. In realtà non è dato parlare di "soggettività"
dell'organo, in vista del rapporto organico; piuttosto, si può ragionare di
"soggettività" o di legittimazione di determinati uffici, qualora l'ordinamento
li consideri come parti di giudizi intesi a definire le rispettive sfere di
competenza: nel qual caso però i ricorsi proposti dagli uffici stessi non vanno
qualificati come atti direttamente imputabili allo Stato-soggetto.