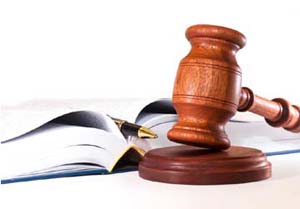Diritti degli animali
La bontà nei
confronti degli animali è diventata una norma sociale solo in tempi recenti,
negli ultimi centocinquanta o duecento anni, e soltanto in una parte del mondo.
Ed è a ragione che si può collegare questa parte della storia alla storia dei
diritti umani, dato che l'interesse per gli animali, storicamente parlando, è
germogliato da interessi filantropici più ampi-nei confronti degli schiavi e
dei bambini, in particolare.
Bisogna, perciò,
innanzitutto intendersi sul significato da attribuire alla parola "diritti".
Secondo la prospettiva utilitaristica e simpatetica i diritti sono l'altra
faccia dei doveri. Se esiste il dovere di non fare soffrire inutilmente gli
esseri sensibili, si può dire che gli esseri sensibili godono del diritto a non
essere fatti soffrire. Alla prospettiva di stampo utilitaristico si contrappone
quella di tipo giusnaturalistico, che postula l'esistenza di diritti naturali
degli animali; e poi, in un progressivo allargamento della coscienza ecologica,
anche delle piante, e dell'ecosistema in genere. Ma, a questo punto, è
importante elaborare una definizione di "valore in sé", che come tale andrebbe
rispettato in maniera assoluta. Tom Regan è autore di uno dei tentativi più
interessanti in tale senso; secondo Regan possedere valore intrinseco significa
essere in grado di condurre una vita che può essere migliore o peggiore per il
soggetto stesso che la vive, in modo del tutto indipendente dalle valutazioni
altrui. I sostenitori della teoria del valore intrinseco affermano che solo
così si riesce a difendere a fondo gli animali, senza le ineliminabili
limitazioni della prospettiva utilitaristica e simpatetica, basate sulle
valutazioni umane, che sono pur sempre soggettive e quindi passibili di errori
e di cambiamenti. Il valore intrinseco è invece un elemento oggettivo peculiare
di ogni singolo vivente, e costituisce una barriera di fronte alle pretese
altrui: è una specie di guscio protettivo
attorno a ciascuno che non può venire infranto se non in casi assolutamente
eccezionali. Anche la posizione giusnaturalista considera, quindi, gli animali
come soggetti morali, e anzi come titolari di diritti in quanto qualità
oggettivamente esistenti.
Ma quali sono
questi diritti? Per forza di cose si deve trattare di una piattaforma minimale
di diritti, relativi a quelle caratteristiche che gli animali hanno in comune
con l'uomo. In primo luogo il diritto a non essere fatti soffrire: e qui si
apre la grossa piaga della vivisezione, o sperimentazione scientifica. Basti
pensare che il numero complessivo annuo su scala mondiale degli animali di
vario tipo, dalle cavie ai ratti, ai cani, ai gatti, alle scimmie e altri
ancora, si aggira sugli ottocento, novecento milioni di esemplari. Il minimo
che si dovrebbe fare da un punto di vista etico è una riduzione massiccia del
numero degli esperimenti nonché la loro progressiva sostituzione con i
cosiddetti metodi alternativi, vale a dire simulazioni su computer e test
eseguiti su tessuti cellulari in vitro. Appaiono assolutamente privi di
necessità anche tutti gli esperimenti compiuti nel campo della cosmesi e dell'industria
bellica. L'altro problema enorme è rappresentato dagli allevamenti intensivi.
Centinai e centinaia di milioni di animali vengono allevati e continuamente
sostituiti per procurarci la carne, il latte, le uova: e di solito vengono
tenuti in condizioni inumane. Basti pensare alle galline ovaiole, esposte
ventiquattro ore su ventiquattro all'illuminazione artificiale, e che hanno a
disposizione uno spazio per ciascuna di 450 cm2, cioè più o meno
l'equivalente di una pagina di un libro. Ulteriori punti dolenti riguardano
l'impiego di animali in spettacoli cruenti, l'esercizio della caccia, l'abbandono degli animali domestici. Il
secondo diritto è quello alla vita. Per gli aderenti alle posizioni basate sul
dovere di non provocare sofferenza, il diritto alla vita degli animali si
presenta più complesso da dimostrare, dato che la morte può venire data
eutanasicamente. Per i più non è un male che essi vengano allevati e uccisi per
scopi alimentari. Secondo Bentham gli animali non sono in grado di prefigurarsi
la morte, e quella che ricevono dalle mani dell'uomo è, o per lo meno potrebbe
essere, più pietosa della morte cui andrebbero incontro in natura. Al cospetto
della morte, nella mente umana si verifica un crollo dell'immaginazione, e quel
crollo dell'immaginazione è alla base della nostra paura della morte. Quella
paura non esiste e non può esistere per gli animali, dato che lo sforzo per
comprendere l'estinzione, e il relativo fallimento, il fallimento
nell'immaginarla, semplicemente non hanno avuto luogo. Per un animale la morte
è solo qualcosa che succede, qualcosa contro cui ci può essere una rivolta
dell'organismo ma non una rivolta dell'anima. È stato però obiettato , in primo
luogo, che anche se si allevano e si macellano gli animali senza farli
soffrire, tuttavia li si depriva della loro vita naturale; e, in secondo luogo,
che con i metodi attuali di allevamento e di macellazione su larghissima scala,
il cui obiettivo principale è quello di ridurre i costi e aumentare i profitti,
appare praticamente impossibile non far soffrire gli animali. Il diritto alla
vita degli animali coinvolge il grosso interrogativo sulla liceità del mangiar
carne. Nel 1847, a Londra, fu fondata la prima Vegetarian Society; e poiché il
suo statuto permetteva di cibarsi di uova e di latte il termine "vegetarismo"
ricoprì e ricopre anche questi prodotti. In seguito coloro che invece
intendevano cibarsi esclusivamente di vegetali coniarono il termine "vegan
esimo". I vegani sostengono la loro posizione soprattutto sulla base del fatto
che, cui si è già accennato, che la produzione di uova, latticini e alimenti
animali in genere molto raramente è pain-free per gli animali. Il terzo diritto
è quello alla libertà, che coincide con il problema degli zoo e dei circhi. Gli
animali selvatici hanno un interesse per la libertà tale da superare i vantaggi
che derivano loro dal trovar cibo e riparo e dall'essere accuditi dall'uomo.
Anche le galline, che chissà perché sono ritenute tra gli animali più stupidi,
messe di fronte a due uscite, una delle quali porta ad un recinto comodo e
pieno di cibo e l'altra a uno spazio aperto, hanno sempre, infallibilmente
scelto la seconda alternativa. L'isolamento in carcere ci fa capire che la
libertà del corpo di muoversi nello spazio coincide con il punto con cui la
ragione può danneggiare in modo più doloroso ed efficace un altro essere. E
infatti gli effetti più devastanti li riscontriamo sulle creature meno idonee a
sopportare l'isolamento, le creature che si conformano dimeno alla
raffigurazione che Cartesio dà dell'anima come un pisello imprigionato in un
baccello, per la quale un'ulteriore prigionia è irrilevante: negli zoo, nei
laboratori, negli istituti in cui non può esserci il posto per il flusso di
gioia che deriva dal vivere non in o come un corpo, bensì semplicemente
dall'essere creature incarnate in un corpo .