 |
|
 |
|
| Visite: 1456 | Gradito: |
Leggi anche appunti:I totalitarismi - hitler: l'illusione di poter creare una "razza" ariana superioreI TOTALITARISMI HITLER: L'ILLUSIONE DI POTER CREARE UNA "RAZZA" ARIANA SUPERIORE Documento: L'impero tedescoL'IMPERO TEDESCO L'assolutismo prussiano assume un carattere militare. Il IL NAZISMO - Le origini, La dittatura, Preludio alla guerraIL NAZISMO Le origini La sconfitta della grande guerra fu pagata a caro |
 |
 |
Con Giolitti al potere, lo Stato italiano non è più il difensore degli interessi padronali.
Il 3 novembre 1903 saliva alla presidenza del consiglio un uomo politico, Giovanni Giolitti (1842-1928), che avrebbe legato al suo nome circa un decennio di storia italiana:.
Nel 1892-93 aveva gia retto per breve tempo le redini del governo, ma era stato sbalzato dallo scandalo della Banca Romana e dalla pesante opposizione condotta da Francesco Crispi.
Nel 1901 Zanardelli lo aveva richiamato a responsabilità di governo come ministro dell'interno ed era apparso subilo evidente che sarebbe stato lui a proseguirne quella politica più aperta e conciliante dopo le reazioni e l'autoritarismo di fine secolo.
La storia italiana agli inizi del sec. XX quindi dominata dalla personalità di questo piemontese, che rimase alla guida del governo per oltre un decennio (1903-1914), quasi ininterrottamente, salvo brevi interruzioni.
Ma il fatto nuovo ed importante è che con Giolitti entrò nella vita politica italiana la diversa impostazione che venne a regolare il rapporto fra lo Stato e le masse lavoratrici
Anche umanamente Giolitti aveva tutt'altra attenzione da quella dei liberali conservatori e rnoderati verso le classi lavoratrici. Egli sapeva bene i gravi sacrifici che avevano sopportato specialmente le plebi rurali nei primi decenni del regno, quando era stato avviato il processo di trasformazione in senso capitalistico dell'economia del paese. In un suo discorso dei 1900, in polemica con Sonnino, aveva detto:
"Quando osservo le condizioni delle classi rurali in gran parte d'Italia e le paragono a quelle dei paesi a noi vicini (), io resto compreso di ammirazione per la longanimità e la tolleranza delle nostre plebi e penso con terrore alle conseguenze di un loro risveglio".
Lo Stato, con Giolitti, non è più il difensore degli interessi padronali a danno delle rivendicazioni economiche degli operai e dei contadini.
Lo Stato per Giolitti dev'essere il giudice sereno, il conciliatore, il tutore dell'ordine sociale.
Quando il Governo - ha scritto nelle sue Memorie Giolitti -, come allora usava, interveniva per tenere bassi i salari, commetteva una ingiustizia, e più ancora un errore economico ed un errore politico. Una ingiustizia, perché mancava al suo dovere di assoluta imparzialità fra i cittadini, prendendo parte alla lotta contro una classe in favore dell'altra. Un errore economico perché turbava il funzionamento della legge economica della domanda e dell'offerta [.].
Ed infine un errore politico perché rendeva nemiche dello stato quelle classi che costituiscono la grande maggioranza del paese.
Il solo ufficio equo e utile dello Stato in queste lotta fra capitale e lavoro è di esercitare un'azione pacificatrice, e talora anche conciliatrice; ed in caso di sciopero esso ha il dovere di intervenire in un solo caso: a tutela cioè della libertà di lavoro, non meno sacra della libertà di sciopero, quando gli scioperanti volessero impedire ad altri operai di lavorare.
Sin dalla primavera del 1901 Giolitti aveva messo alla prova questo suo orientamento, allorché una serie di scioperi era scoppiata nel Mantovano e in tutta la Val Padana, con la partecipazione di circa 600.000 lavoratori.
Giolitti, ministro dell'interno, rispettò la libertà di sciopero, lasciando che il conflitto -venisse risolto fra le parti senza l'intervento dello Stato.
Si era, insomma, all'inizio di nuovo periodo storico, in cui le classi lavoratrici avrebbero potuto conquistare la loro parte di influenza nell'ambito del sistema liberale. C'era naturalmente in questo disegno di Giolitti, oltre ad un più allo senso di giustizia sociale rispetto ai precedenti governi, il tentativo di allargare la base politica su cui doveva reggersi il suo governo.
Giolitti arrivò ad offrire, proprio nel 1903, a Filippo Turati la possibilità di entrare a far pane del governo, ricevendone però un rifiuto motivato dal timore che le masse socialiste e la base dei partito non avrebbero)compreso una svolta così radicale, che avrebbe creato una insanabile frattura all'interno del movimento operaio.
Ma, nonostante il rifiuto di Turati, noli mancò quasi mai al presidente del consiglio l'appoggio e il consenso dei Socialisti turatiani.
Gli inizi del governo Giolitti furono difficili e misero subito alla prova il presidente dei consiglio.
II fatto più grave si verificò nell'estate 1904, caratterizzato da manifestazioni e scioperi che ebbero i momenti di maggiore tensione in Sicilia e in Sardegna, ove la forza pubblica intervenne contro i dimostranti.
Si ebbero alcuni morti. Per cinque giorni, dal 15 al 20 settembre, l'Italia conobbe il primo grande sciopero generale della sua storia, proclamato dal partito socialista, sotto la pressione della corrente rivoluzionaria, che riscosse ovunque l'adesione dei lavoratori. Luigi Albertini, direttore del Corriere della sera parlo di "cinque giorni di follia".
Lo sciopero preoccupò la borghesia e i moderati, che premettero su Giolitti per una prova di forza contro i lavoratori in sciopero. Ma egli resistette alle pressioni, pur essendo irritato per la debolezza dei dirigenti socialisti socialisti che si fecero condurre a rimorchio dalle correnti più estreme.
Per uscire dalla crisi egli ricorse ad uno stratagemma: sciolse la camera ed indisse nuove elezioni, con lo slogan: "né rivoluzione né reazione".
I risultati della consultazione elettorale, svoltasi nel novembre del 1904, diedero ragione a Giolitti: l'estrema Sinistra (socialisti, repubblicani e radicali) passò da 107 seggi a 94. Per la prima volta i cattolici parteciparono alle elezioni politiche, avendo Pio X abrogato parzialmente il non expedit, consentendo ai vescovi di autorizzare i fedeli delle rispettive diocesi a votare, qualora vi fosse stato il pericolo di successo di partiti sovversivi.
Giolitti, comunque, non venne meno al suo programma di riforme.
II decennio politico legato al suo nume presenta una serie ininterrotta di forme sociali, senza precedenti nella storia dell'Italia unita.
Furono emanati provvedimenti a tutela dell'invalidità e vecchiaia, del riposo festivo, e degli infortuni sul lavoro, del lavoro delle donne e dei fanciulli
Nel 1901 venne costituito il Commissariato per l'emigrazione, nel 1906 il Consiglio superiore Del lavoro, cui venne affidato il compito di organo consultivo nei conflitti dei lavoro.
Sul piano economico il programma di Giolitti mirò principalmente a stimolare lo sviluppo industriale e a salvaguardare il bilancio dello Stato. Grazie all'opera di Luigi Luzzati, ministro delle finanze, il bilancio statale fu mantenuto costantemente in pareggio e si ebbero anche momenti di eccedenze attive.
La lira acquistò prestigio per la sua forte stabilità.
Nel decennio giolittiano si assistette poi ad una vera e propria "rivoluzione industriale".
Il valore della produzione delle industrie manifatturiere e quello della produzione metallurgica o meccanica subirono notevolissimi incrementi, pur rimanendo l'industria tessile la voce più significativa dell'economia nazionale.
Un momento di crisi si ebbe intorto al 1907, ma nel 1909 era già in atto la ripresa dello sviluppo industriale.
Sorse, in questi anni, anche un'industria che avrebbe poi avuto un peso notevole sull'economia italiana: l'industria automobilistica.
A Torino, nel 1899 era nata la Fiat. Quindici anni dopo, nel 1914, l'industria automobilistica italiana contava 44 società, con 12.000 operai e con un capitale di 67 milioni. In Italia circolavano 21.000 autoveicoli. Rispetto al 1910 il numero di autoveicoli si era triplicato, mentre 3.000 automezzi all'anno venivano esportati.
Anche la produzione di energia elettrica subì un forte incremento.
Altro aspetto significativo del progresso economico realizzatosi nell'età giolittiana fu l'apparizione e lo sviluppo delle grandi banche, che modificarono la precedente struttura e fisionomia del mercato finanziario
Con il nuovo secolo le banche assunsero in Italia un ruolo fondamentale nel settore degli investimenti industriali (formazione della banca mista). La Banca Commerciale, il Credito Italiano, il Banco di Roma, la Società Bancaria Italiana erano gli istituti finanziari più, attivi ed operavano i loro investimenti non solo in Italia ma anche all'estero.
II peso dell'agricoltura nell'economia nazionale subì una flessione, dal quinquennio 1896-1900 al 1911-15, il contributo dell'agricoltura al prodotto lordo nazionale scese dal 50% al 44%, mentre quello dell'industria salì dal 19,4% al 25,6%.
L'agricoltura, insomma, nonostante l'aumento della produzione e la maggiore richiesta di derrate alimentari da parte del mercato, il miglioramento dei trasporti e dei mezzi tecnici di produzione, con l'impiego di fertilizzanti chimici e di macchinari agricoli, non ebbe lo sviluppo conosciuto dall'industria.
La vita e i problemi sociali delle campagne non subirono miglioramenti di rilievo e le tensioni rimasero acute. Nel 1911 il numero dei contadini era di circa 10 milioni: di questi, 4,4 milioni erano braccianti, privi cioè della terra, 3,2 affittuari e mezzadri, 1,8 proprietari. Le tensioni sociali dell'età giolittiama furono principalmente legate alle lotte contadine.
Il fenomeno dell'emigrazione raggiunse livelli sempre più alti: era costretto ad emigrare soprattutto il contadino di quelle regioni non toccate dallo sviluppo industriale e dal progresso economico.
Dai 300.000 emigrati del 1900, nel 1913 si passò a 873.000. L'emigrazione meridionale non fu un fenomeno stagionale, non si diresse verso i paesi dell'Europa settentrionale, ma verso le Americhe, sradicando i contadini dalle loro terre e compromettendo spesso le unità familiari. S
ul dramma di questa emigrazione meridionale transoceanica parlò alla Camera, il 30 maggio 1909, Pasquale Villari, illustre storico e meridionalista napoletano:
E' necessario ricordarsi che questi emigrati sono, come li chiamano, cafoni, quasi tutti analfabeti, ignoranti, incapaci di difendersi, di provvedere a se stessi ( ..), sfruttati largamente da quei banchisti, camorristi, che si sono formati in quella società.
Essi si affollano nelle città dell'America, e formano una società separata dagli Americani. Questi li considerano come una colonia affatto isolata, e se ne occupano assai poco. Basta che non diano loro noia, li lasciano fare quel che vogliono. Una massa così enorme, quasi tutta di analfabeti, ha bisogno di direzione, ha bisogno di una guida, che non trova in se stessa; quindi sono sorti in essa degli avventurieri, dei banchieri i quali fanno la professione di sfruttare gli emigranti appena arrivano, () è un'Iliade di sventure quella che li colpisce ().
Tornano incapaci al lavoro dei campi, disprezzano il loro paese; non si possono più assuefare alla vita delle nostre popolazioni perché in America hanno fatto i lustrascarpe, gli sterratori, hanno lavorato nelle strade ferrate, nelle fogne! Queste sono le occupazioni che, nelle grandi città, hanno gli emigrati italiani negli Stati Uniti d'America, dando spettacolo poco degno del nostro paese!
I1 parlamento, in questi anni di grandi riforme, sembrò spesso succubo della personalità e del gioco politico di Giovanni Giolitti. Egli riuscì a controllare la sua maggioranza attirando nella propria orbita, di volta in volta, secondo le necessità del momento, i socialisti di Turati, i radicali di, Ettore Sacchi e di Giuseppe Marcora, i cattolici ed i nazionalisti, dando così vita ad un nuovo tipo di trasformismo politico che apparve ad alcuni insigni meridionalisti, come il Salvemini, diseducatore.
L'on. Giolitti - ha scritto Gaetano Salvemini nella sua famosa opera dal significativo titolo Il Ministro della malavita - non è certo il primo uomo di governo dell'Italia una, che abbia considerato il Mezzogiorno come terra di conquista aperta ad ogni attentato malvagio. Ma nessuno è stato mai così brutale, così cinico così spregiudicato come lui nel fondare la propria potenza politica sull'asservimento, sul pervertimento, sul disprezzo del Mezzogiorno d'Italia; nessuno ha fatto un uso più sistematico e più sfacciato, nelle elezioni del Mezzogiorno, di ogni sorta di violenze e di reati.
È un giudizio pesante e severo, tipico di quegli esponenti del meridionalismo italiano, da Salvemini a Luigi Sturzo, Francesco Saverio Nitti ad Antonio De Viti de Marco, che insieme ai liberisti, come Lugi Einaudi ed Edoardo Giretti, condussero la loro opposizione al regime giolittiano, accusato di condurre una politica economica protezionistica e filondustriale a tutto danno delle regioni meridionali.
Salvemini attaccava poi, soprattutto, i sistemi con cui Giolitti manipolava le elezioni nelle province meridionali, attraverso) i prefetti, e con la complicità della camorra, della mafia e dei cosiddetti mazzieri, che con la violenza miravano a limitare la libera volontà degli elettori. Polemica che condusse anche Luigi Sturzo, un sacerdote di Caltagirone, impegnato nelle battaglie sociali ed amministrative in Sicilia e futuro fondatore del partito popolare italiano. Sturzo condannò l'accentramento politico ed amministrativo perseguito da Giolitti, lo stretto controllo con cui il potere centrale annullava di fatto autonomie locali, il clientelismo che avviliva la vita politica del Mezzogiorno e che ritardava la formazione di una coscienza politica e civile nel sud.
Sul piano economico non sempre le soluzioni prospettate dai meridionalisti concordarono. Salvemini, ad esempio, sosteneva la necessità di liquidare la proprietà latifondista, di abolire il dazio sul grano e la politica protezionistica e di organizzare un più vasto e controllato credito agrario.
Sturzo sosteneva che il Mezzogiorno avrebbe potuto rinascere se fosse stata adottata una politica economica e commerciale che valorizzasse, con tecniche moderne e con una vasta riforma agraria, l'agricoltura, favorendo l'apertura di sbocchi commerciali nei paesi gravitanti nell'area mediterranea.
Sturzo era allora contro un'industrializzazione del mezzogiorno fatta con la protezione doganale e i soldi dello Stato: proponeva invece la creazione eli impianti industriali capaci di trasformare prodotti agricoli.
Per Nitti, invece, il problema era di produttività, di industrializzazione coli tutte le nuove prospettive aperte dall'utilizzazione dell'energia elettrica e con l'indispensabile funzione stimolatrice dello Stato. Non erano sufficienti le leggi speciali emanate dal Governo a favore del Mezzogiorno, in quanto non bastava l'incremento di opere pubbliche e sgravi fiscali, ma era necessario un preciso e nuovo indirizzo di politica economica. «L'Italia Meridionale - disse Nitti alla Camera il 15 giugno 1906 - deve produrre di più: occorre quindi non fare riduzioni di imposte a caso, ma stimolare l'attività produttrice e diminuire le forze ritardatarie
Attiva fu anche l'opposizione condotta dalla destra liberale conservatrice, guidata da Sidney Sonnino e che ebbe in Luigi Albertini e nel suo quotidiano, Corriere della Sera, un efficace ed intelligente interprete.
Il «ministro della mala vita» era in buona compagnia negli abusi elettorali. I metodi elettorali di Giolitti gli valsero, com'è ben noto, la qualifica di «ministro della mala vita» attribuitagli da Gaetano Salvemini, che di quei metodi fu il più implacabile
denunciatore, come pure minuzioso, anche se non sempre del tutto sereno, espositore.
Lo statista piemontese, in realtà, non aveva inventato in questo campo nulla di veramente nuovo. Le interferenze e le pressioni governative, specie tramite i prefetti e talora anche i procuratori dei Re presso i vari tribunali, a favore dei candidati ministeriali; i soprusi ed i brogli messi in opera da cricche locali con il beneplacito delle autorità periferiche; l'intimidazione fisica e la violenza scoperta a danno degli oppositori (soprattutto nei collegi meridionali), erano tutte prassi che avevano radici lontane nelle competizioni elettorali italiane e risalivano al primo periodo postunitario, anche se solo a partire dalle prime elezioni politiche svoltesi sotto la sinistra appena arrivata al potere, e gestite dal ministro dell'interno Nicotera con una larghezza di abusi altrettanto spregiudicata quanto senza precedenti, assunsero carattere di cronica gravità ed estensione, pur con differenze qualitative e quantitative a seconda del governo in carica.
Giolitti, fin dalla sua prima esperienza di governo nel 1892, perfezionò il sistema, lo rese con pazienza metodica e burocratica precisione ancor più capillare ed efficiente, mettendo alla frusta i prefetti e gli altri funzionari subalterni con quella sua abituale perentorietà e durezza minacciosa [J. Una novità giolittiana non era neppure il fatto, tante volte sottolineato, che gli abusi elettorali si concentrassero prevalentemente nelle provicie meridionali, mentre nel resto del paese veniva di regola lasciata via libera (ma non senza eccezioni) ad elezioni «pulite».
Anche qui, come in altri campi, la grande differenziazione tra Nord e Sud era di antica data e pure in questo caso Giolitti non fece che consolidare e perfezionare con piglio professionale una linea di tendenza già esistente e ben marcata.
(Alberto Aquarone, L'Italia giolittiana, Il Mulino, Bologna, 1981)
Claudio Treves, uno dei maggiori esponenti della corrente riformista del partito socialista (la corrente cioè che faceva capo a Filippo Turati e che era favorevole ad una politica di graduali riforme sociali a vantaggio dei lavoratori, alla quale si opponevano i massimalisti, che miravano alla conquista rivoluzionaria del potere, al di fuori da compromessi con lo Stato borghese), in un articolo apparso nel 1899 sulla Critica Sociale, esordiva con queste significative parole:
C'è dall'altra riva un uomo che ci ha capito. L'uomo può essere simpatico od antipatico, ispirare fiducia o diffidenza, può essere un furbo o un ingenuo, il movimento di ricomposizione dei partiti può averlo favorevole o contrario, alla testa o alla coda: tutte queste sono singolarità accidentali: l'importante è che l'uomo abbia capito.
Il riferimento a Giolitti era evidente e l'articolo di Treves fu la prova di come, sin dalla fine del secolo, il socialismo riformista fosse disposto ad un tipo di collaborazione con la Sinistra liberale. Di fronte all'atteggiamento assunto dal governo Zanardelli-Giolitti in occasione dello sciopero, della primavera 1901, il 22 giugno dello stesso anno i socialisti votavano a favore del ministero, con un gesto di efficace realismo politico.
Filippo Turati, coadiuvato da Arma Kuliscioff - una domna che esercitò una influenza non trascurabile su Turati e sul socialismo italiano - favorì questa svolta del partito, dopo la crisi di fine secolo.
Per Turati il partito socialista doveva approfittare del nuovo indirizzo governativo, ad esclusivo beneficio del proletariato. Doveva «proteggere» il governo «dalle insidie della reazione cospirante», vigilare perché tenesse fede al suo programma, spingerlo sulla via delle riforme, intensificare la propria azione educatrice presso le masse.
La libertà era, per Turati, al «suo primo esperimento» ed occorreva proteggerla, tutelarla da coloro che, anche nell'ambito del partito stesso, «per impazienza spavalda, arrischiano, per le fatue apparenze della libertà, di compromettere la preziosa sostanza».
Ma all'interno del partito si svilupparono varie tendenze che Turati non riuscì sempre a controllare e da cui, anzi, venne, a volte travolto.
A destra si sviluppò l'orientamento che, sosteneva la necessità di una revisione della dottrina marxista, adattandola allo sviluppo capitalistico ed alle istituzioni borghesi.
In Italia questa tendenza vide come maggior esponente Ivanoe Bonomi («il socialista che si contenta» collie, polemicamente, lo definì Salvemini).
A sinistra di Turati presero piede la corrente massimalista guidata da Enrico Ferri e quella dei sindacalisti rivoluzionari capeggiata da Eurico Leone ed Arturo Labriola, il cui programma teorizzava l'idea dello sciopero, generale come strumento necessario per arrivare alla rivoluzione proletaria.
Al congresso di Firenze del 1908 Turati riprese in mano le redini del partito, grazie soprattutto all'appoggio della Confederazione generale del lavoro (C. G. L.), il sindacato ad ispirazione socialista, sotto la cui direzione erano state riunite, nel 1906, le varie camere del lavoro e le leghe contadine.
L'aspetto più importante nelle vicende del socialismo italiano agli inizi del secolo resta comunque la tacita intesa Giolitti-Turati che favorì i Progressi sociali ed economici del proletariato.
Ad avvantaggiarsene fu in realtà, soltanto il proletariato industriale Nord, mentre ne venne elusa la massa contadina del Mezzogiorno, ma quella intesa rappresentò il primo timido passo verso una politica che mirava a raccogliere e a guidare in maniera consapevole le pressioni e gli impulsi democratici entro la base materiale dello Stato, tanto che si arrivò a considerare, in quegli anni, il socialismo come un evento possibile, senza rivoluzione, all'interno della società capitalistica e borghese.
Benedetto Croce arrivò a scrivere nel 1911 che il socialismo era «morto» e Giolitti alla Carriera affermò che i socialisti avevano «Mandato Marx in soffitta».
Occorre rilevare, comunque, che il socialismo turatiano siera forse cullato troppo in quella idea di essere l'erede naturale della borghesia e non si avvide che, maturando inevitabilmente la crisi ilei sistema giolittiano, la boprghesia stava voltandogli le spalle per appoggiare forze che meglio potessero tutelare i suoi interessi.
La guerra libica svelerà questa crisi e determinerà nel socialismo italiano il definitivo abbandono della linea riformistica di Turati.
Tra la fine (lei sec. XIX e l'inizio del XX avvenne un'improvvisa svolta all'interno del movimento cattolico.
Negli anni ultimi dell'800 si sviluppò e prese piede un movimento che assunse il nome di democrazia cristiana.
Nacque, si può dire, sulla scia della Rerum Novarum di Leone XIII e dietro la spinta delle agitazioni e degli scioperi condotti dai socialisti.
Fu un movimento guidato da giovani cattolici che non avevano vissuto il travaglio della Questione Romana, che sentivano l'esigenza di operare nella società civile portandovi il proprio contributo di idee, che miravano ad un rinnovamento sociale ed organico delle strutture dello Stato liberale (vedi lezione di ripasso 11, paragrafo 11.1).
Nel programma che questi giovani cattolici lanciarono il 15 maggio 1899 si chiedeva la libertà sindacale, l'introduzione della proporzionale nelle elezioni, il referendum ed il diritto d'iniziativa popolare, un largo decentramento amministrativo, una efficace legislazione sociale; la riforma tributaria basata sulla giustizia, la lotta contro le speculazioni capitalistiche, la tutela della libertà di stampa, di associazione, di riunione, l'allargamento del suffragio elettorale, il disarmo generale
Tutto questo - si legge nel documento - noi vogliamo come democratici cristiani, perché le riforme che noi domandiamo corrispondono insieme alle aspirazioni di una vera democrazia e ai principi sociali del cristianesimo. Democrazia cristiana vuol dire applicazione integrale del cristianesimo, ossia del cattolicesimo, a tutta la vita privata e pubblica moderna, e a tutte le sue forme di progresso.
Alla testa del movimento venite ben presto a trovarvi un giovane prete marchigiano, Romolo Murri (1870-1944), che ne fu l'anima. I giovani democratici cristiani trovarono appoggi anche presso la Santa Sede, e Leone XIII sanzionò che il nome di democrazia cristiana poteva essere adoperato dai cattolici, anche se solo limitatamente al terreno sociale, nel significato di lotta e aspirazione alla giustizia. Veniva escluso il significato politico.
II movimento dilagò in tutta Italia: circoli democratici cristiani sorsero un po' dovunque, molto più al Nord che al Sud, anche se il movimento fu attivo soprattutto in Sicilia, ove operava don Luigi Sturzo.
Ma il movimento democratico cristiano incontrò l'opposizione dei vecchi esponenti dell'Opera dei congressi, legati ancora a una mentalità conservatrice e al ricordo della vecchia battaglia dell'intransigentismo post-unitario.
La crisi si acuì con l'avvento al soglio pontificio di Pio X
Il suo predecessore, Leone XIII, aveva invitato i cattolici ad uscire «fuori di sacrestia», a portare in seno alla società civile il contributo delle loro opere e delle loro idee ed aveva aperto loro la strada all'impegno nel campo sociale.
Pio X, invece, volle un laicato obbediente e sottomesso all'autorità diocesana, per cui, allorché le giovani forze democratiche cristiane parvero avere il sopravvento sugli intransigenti in seno al movimento cattolico, il papa ritenne opportuno sciogliere, nel 1904, l'Opera dei congressi, che per trent'anni era stato l'organismo guida dei cattolici militanti (si ricorda, sulla scia del Sillabo e delle posizioni assunte da Pio IX dopo la presa di Roma, vedi lezione di ripasso 11, paragrafo 11.1 e lezione di ripasso 10, paragrafo 10.3).
In questi anni si verificò la prima partecipazione dei cattolici alle elezioni politiche, attraverso una formula che prese il nome di clerico-moderatismo
Infatti, nel 1904, 1909 e 1913 i cattolici parteciparono alle elezioni in appoggio a candidati liberali moderati.
Si trattò di una prima parziale frattura del non-expedit autorizzata dallo stesso Pio X, che prese le mosse, principalmente, dalla paura di un successo dei socialisti nelle elezioni dei 1904, seguite allo sciopero generale.
Questa prassi elettorale rientrava, sotto molti aspetti, nel clima stesso dell'età giolittiana.
Giolitti in sostanza cercava di disorganizzare il movimento cattolico, favorendo indirettamente le alleanze fra clericali conservatori e liberali moderati.
Giolitti però non concesse mai nulla direttamente ai cattolici, non ne riconobbe in nessuna circostanza il ruolo politico, anche se fu evidente allora che una parte dei cattolici italiani si sentiva ormai legata alle sorti dello Stato liberale.
Per la prima volta, nel entrarono alla Camera deputati cattolici, o meglio «cattolici deputati», secondo la formula allora adottata, per significare che questi Cattolici non appartenevano ad un raggruppamento politico ma facevano parte del Parlamento a titolo personale.
In questi anni, furono gettate anche le basi del futuro partito politico dei cattolici italiani, un partito autonomo e democratico. Don Luigi Sturzo, in un discorso tenuto nel 1905 a Caltagirone, suo paese natale, tracciò con formule chiare l'idea di un partito laico aconfessionale, che si ispirasse ai princìpi del cristianesimo, accettasse l'unità nazionale, rigettando le pregiudiziali temporalistiche; un partito, infine, che propugnasse una vasta autonomia degli enti locali (i comuni, le province, le regioni) in uno Stato aperto alle esigenze del mondo dei lavoro.
Ma per ora i cattolici dovevano, per Sturzo, aspettare e prepararsi, impegnandosi nelle battaglie amministrative, per creare una propria coscienza autonoma, che li distinguesse da altre forze politiche.
Per questo egli condannava la pratica elettorale del clerico-moderatismo, che non offriva sufficienti garanzie di tutelare le aspirazioni politiche e sociali dei cattolici e li avviliva in Una condizione subalterna rispetto alle forze del moderatismo liberale.
Anche il movimento sindacale di ispirazione cattolica prese piede e si sviluppò nell'età giolittiana, soprattutto all'interno dei mondo rurale, ed impostò la sua battaglia con i moderni sistemi della lotta sindacale, in concorrenza con le organizzazioni socialiste. Guido Miglioli, Un grande animatore delle rivendicazioni contadine nel Cremonese, ne fu il maggior esponente:con i suoi amici organizzò casse rurali, circoli di studi sociali, leghe contadine (le cosiddette leghe bianche).
Anche il clero fu spesso presente nelle lotte operaie e contadine, soprattutto nel Nord d'Italia. Quando nel 1909 scoppiò a Ranica (Bergamo) uno sciopero a fianco degli operai troviamo il vescovo di Bergamo, uno Radini Tedeschi, di cui era segretario Angelo Roncalli, Giovanni XXIII, che ricorda:
Da un discorso di Sturzo: «una ragione dl vita civile informata ai principi cristiani »
Ora, quando affermo che i cattolici debbono anch'essi, come un nucleo di uomini di un ideale e di una vitalità specifica, proporsi il problema nazionale, che fra gli altri problemi involve in sintesi anche il religioso, io suppongo i cattolici come tali, non come una congregazione religiosa, che propugna da sé un tenore di vita spirituale, né come l'autorità religiosa che guida la società dei fedeli, né come la turba dei fedeli che partecipa attivamente o passivamente alle elevazioni e ai combattimenti di vita spirituale, né come un partito clericale che difende i diritti storici della chiesa, in quanto vitalità umana di diverso ordine e di ragione concreta, specifica; ma come una ragione di vita civile informata ai principi cristiani nella morale pubblica, nella ragione sociologica, nello sviluppo del pensiero fecondatore, nel concreto della vita politica.
Questa concezione è diversa da quella avuta da mezzo secolo a questa parte, quando la ragione cosiddetta clericale faceva i cattolici sostenitori di diritti regi, di tradizioni ecclesiastico-civili, di regimi politico-castali, e li poneva contro le rivoluzioni liberali, che nell'affermarsi di un potere laico assoluto, traente origine dalla presente sovranità popolare, assommava in sé la guerra contro lo spirito della chiesa per abbatterne le forme.
Oggi, compiuta la rivoluzione, assodati i nuovi regimi, dato spazio alle nuove formule politiche, sviluppato il carattere costituzionale della vita esteriore, il tipo clericale nel vecchio ed esteso senso della parola è scomparso; gli avanzi son pochi o ridotti all'impotenza; o per lo meno non può avere sviluppo una qualsiasi reviviscenza clericale nel suo tipo storico. Non è scomparsa però la tendenza larvata, la minuta concezione tradizionale, la visione piccola di una vita che ha perduto la sua ragione; la quale è ingrandita, ingigantita anche dalla confusione dei principi di vita religiosa con le forme storiche esterne e accidentali di essa. (Luigi Sturzo, Discorso del 24/XII/1905).
Nonostante che la Graves de communi [si tratta dell'enciclica con la cuale, nel 1901, Leone XIII aveva negato alla Democrazia Cristiana la possibilità di un impegno politico] apparisse come un richiamo ai democratici cristiani perché rientrassero nell'Opera dei congressi, Murri e i suoi amici, approfittando del fatto che essa lasciava nel vago tutto ciò che si riferiva all'azione concreta, decisero di intensificare il lavoro di organizzazione e di propaganda. Il nuovo giornale, Il Domani d'Italia, cominciò le sue pubblicazioni ed ebbe ben presto una notevole diffusione; fasci e circoli democratici cristiani sorsero in molte città; unioni professionali e leghe cattoliche, controllate dai democratici cristiani, furono fondate in varie regioni, ma soprattutto in Lombardia: alle 5 associazioni sindacali cattoliche nate nel 1899 se ne aggiunsero 6 nel 1900 e 43 nel 1901 (27 nell'industria e 16 nell'agricoltura). Questo movimento, come fu detto in una deliberazione dei congresso regionale della democrazia cristiana tenuto a Milano nell'aprile 1901, riconosceva «il contrasto e la lotta degli interessi e delle classi nella produzione e nella vita pubblica» e accettava «Come mezzo estremo della tutela degli interessi degli umili, la resistenza legale e lo sciopero», ma tendeva a rimuovere «la presente anarchia dei rapporti economici, mediante la costituzione e il riconoscimento legale della rappresentanza degli interessi, l'organizzazione corporativa e la determinazione per legge dei mezzi di intesa e di accordo fra le classi». Perciò la democrazia cristiana si proponeva «di contendere il terreno ai socialisti, di combattere il loro spirito partigiano ed anticattolico, di mettersi essa medesima per quanto è possibile a capo del movimento», raccogliendo il maggior numero possibile di lavoratori nelle sue organizzazioni.
I democratici cristiani insomma tendevano ad entrare in concorrenza coi socialisti sul terreno delle lotte rivendicative, pur conservando una visione corporativistica del fine della lotta stessa. Ma essi volgevano ormai decisamente le spalle alla concezione paternalistica e caritativa, che per decenni era stata la caratteristica di gran parte del movimento cattolico nel campo sociale.
(Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna, vol. VII, Feltrinelli, Milano, 1974).
Al nuovo clima che caratterizzò la politica interna, con l'inizio dei nuovo secolo si accompagnò anche una nuova impostazione della politica estera, tendente soprattutto a preparare quella che era una vecchia aspirazione italiana dopo la perdita della Tunisia nel 1881: la conquista della Libia, territorio soggetto all'impero turco ed unico dell'Africa mediterranea al di fuori dall'influenza di potenze europee.
Negli ultimi anni dell'800 e nei primi anni del '900 erano avvenuti in Europa importanti cambiamenti:
l'Italia, sempre più insoddisfatta del trattamento. che riceveva all'interno della Triplice Alleanza, era andata avvicinandosi alla Francia, superando antiche diffidenze e rivalità;
si era accentuato il contrasto fra l'Inghilterra e la Germania, ambedue miranti alla supremazia mondiale;
in seguito alla sconfitta subita nella guerra russo-giapponese (febbraio 1904), la Russia, anche per risollevare il suo prestigio sul piano internazionale, si era avvicinata alla Francia e all'Inghilterra, stringendo con esse una alleanza. In tal modo si costituì la Triplice Intesa (Gran Bretagna, Francia e Russia), opposta alla Triplice Alleanza (Austria, Germania, Italia);
nell'Impero Ottomano aveva preso piede un movimento nazionalista denominato dei Giovani Turchi ; il cui intento era di europeizzare il Paese (1908). Più tardi, in seguito a due guerre combattute dagli stati balcanici contro la Turchia, questa aveva perso quasi completamente tutti i suoi possedimenti in Europa.
In tale quadro internazionale l'Italia, sotto la guida di Giolitti, pensò di realizzare la sua antica aspirazione di conquistare la Libia.
Sin dal 1907 il governo italiano aveva intrapreso un'opera di penetrazione economica e commerciale in Libia affidandone l'esecuzione al Banco di Roma, un istituto finanziario legato ad ambienti cattolici. Il Banco di Roma, nonostante le molte attività commerciali, industriali e finanziarie intraprese in Libia, non riuscì a raggiungere gli scopi prefissi, anzi attirò su di sé il sospetto delle autorità turche, che presero a boicottare palesemente qualsiasi iniziativa italiana.
Quando nel luglio1911, scoppiò la crisi franco-tedesca, che doveva concludersi con la conquista francese del Marocco, molti in Italia credettero giunto il momento di spingere a fondo sul problema della Libia, spalleggiati anche da una campagna di stampa a favore della conquista, alla quale presero parte tutti i maggiori quotidiani d'informazione.
Questa campagna di stampa, che vide in prima fila il nascente movimento nazionalista, si preoccupò di sostenere la grande convenienza che l'Italia avrebbe tratto dalla conquista della Libia, presentata conte un paese ricchissimo, ove poter indirizzare gli emigranti italiani.
Per i nazionalisti, poi, l'impresa doveva rappresentare il riscatto del prestigio italiano nel mondo dopo la sconfitta di Adua e l'ascesa dell'Italia al ruolo di grande potenza.
Per i cattolici l'adesione alla guerra di Libia rappresentò l'occasione per farsi perdonare tanti anni di opposizione allo Stato unitario: alcuni di essi la presentarono addirittura come una nuova crociata contro i Turchi.
Tranne poche voci, fra cui buona parte del partito socialista, legato alla tradizione pacifista ed antimilitarista, le altre forze politiche non si opposero, anzi sostennero l'iniziativa.
Alla guerra inneggiarono poeti come D'Annunzio, Pascoli e Martinetti.
In un primo momento titubante, Giolitti si convinse dell'opportunità di dar corso alla conquista, giustificandola come una «fatalità storica», volendo con tale formula dimostrare che di fronte agli ingrandimenti coloniali della Francia, della Germania e di altre potenze europee, l'Italia non poteva restare inerte, rinunciando al ruolo di potenza coloniale e mediterranea che la conquista della Libia poteva offrirle, tanto più che le varie potenze europee sembravano non voler intralciare l'iniziativa italiana.
Con un ultimatum piuttosto singolare, il 26 settembre 1911 l'Italia, accusando la Turchia di boicottare le iniziative economiche italiane in Libia, invitò il governo ottomano a consentire l'occupazione italiana. La Turchia, pur rifiutando l'occupazione della Libia, si dimostrò disposta ad ampie concessioni di carattere economico, ma il governo italiano le giudicò dilatorie ed evasive, e dichiarò guerra.
Una volta però messo piede nel territorio africano, l'esercito italiano incontrò non solo l'ostilità delle forze regolari turche, ma della grande maggioranza della popolazione araba locale, che trasformò l'impresa in una guerriglia difficile e pericolosa.
Nuove difficoltà vennero da parte delle potenze europee, in precedenza abbastanza possibiliste, ma timorose adesso che l'azione intrapresa dall'Italia mettesse in pericolo l'equilibrio balcanico, sempre così precario; tutta la stampa europea si schierò contro l'Italia.
Per uscire al più presto dalla difficile situazione, l'Italia avrebbe dovuto costringere la Turchia a cedere, colpendola in alcuni punti vitali, nell'Egeo e nei Dardanelli, ma l'Austria oppose il suo veto e acconsentì l'occupazione italiana di alcune isole dell'Egeo (Dodecaneso), avvenuta nel maggio del 1912.
Finalmente, lo scoppio della tanto temuta guerra balcanica che impensieriva, la Turchia e le potenze europee, permise all'Italia di firmare la pace con i Turchi, a Losanna, il 18 ottobre 1912.
Il trattato di pace dava all'Italia il possesso della Libia, ma la Turchia otteneva che fosse rispettata la libertà religiosa delle popolazioni locali musulmane, che sotto questo aspetto continuavano a dipendere dal sultano.
La completa conquista della Libia fu però possibile solo alla fine del 1913, dopo che fu domata la tenace resistenza degli Arabi
L'Italia mantenne anche il possesso delle isole dell'Egeo, che, nonostante l'esplicita dichiarazione contenuta nel trattato di pace, non vennero restituite alla Turchia.
La Libia non si rivelò il paese che avrebbe potuto risolvere il problema dell'emigrazione italiana. Solo grazie ai grossi investimenti compiuti dal governo fascista fu possibile indirizzarvi coloni italiani, il cui numero non raggiunse mai però grosse cifre.
La guerra di Libia aveva rappresentato, sotto molti aspetti, il successo di un movimento da poco affacciatosi sulla scena politica italiana: il nazionalismo.
Esso cominciò a svilupparsi all'inizio del secolo, fenomeno più letterario che politico, attorno a riviste quali Il Regno e Leonardo, con il compito di risvegliare la borghesia, per condurla verso il suo riscatto, contro il grigiore della vita pubblica italiana, contro il giolittismo, il socialismo, la democrazia ed il parlamentarismo.
Tutti quelli - si legge nel programma nazionalista redatto da Giovanni Papini - che sentono la viltà dell'ora presente, la tristezza della vita della patria, la pochezza degli uomini che reggono la cosa pubblica, tutti coloro che non hanno nessuna intenzione di lasciarsi spogliare e seppellire dalla violenza plebea e dalla burbanza demagogica, tutti coloro che vogliono una vita più ampia, più vasta, più eroici per il nostro paese, tutti coloro che odiano le malinconie della rassegnazione, la politica del piede in casa e della vigliaccheria, tutti quelli infine che sono per la grande vita contro la piccola vita, per la vita intensa ed eroica contro la vita angusta e volgare, siano con noi e per noi e ci apportino l'incitamento del loro entusiasmo e la forza dei loro atti.
Con il passare degli anni queste prime enunciazioni programmatiche, che Croce definì «deviazioni letterarie» e «storture etiche», acquistarono una più chiara dimensione politica, vennero alimentate dal colonialismo, dall'imperialismo, dall'irredentismo ed accentuarono il loro carattere antidemocratico.
Il movimento perse per strada uomini come Papini e Prezzolini e trovò i suoi maggiori esponenti in Corradini, Federzoni, Coppola e Maraviglia che nel che nel 1911 fondarono L'Idea Nazionale.
Accanto al nazionalismo inteso come movimento politico si sviluppò un ambiente letterario insensibile al discorso sociale e teso alla ricerca di un provinciale e velleitario sogno di grandezza.
Soprattutto l'ambiente D'Annunziano studentesco e cittadino fu sensibile ai miti, alle immagini, alle parole seducenti e retoriche, al culto della forza e del dinamismo di cui Gabriele D'Annunzio e Filippo Tommaso Marinetti, il padre del futurismo italiano, furono i portavoce più rappresentativi.
Occorre ricordare che erano gli anni in cui nasceva il mito dell'aeroplano, della velocità, in cui la pratica sportiva, ai suoi albori, era vista come sviluppo ed affermazione della razza e come movimento aggressivo. Dannunziani, futuristi, nazionalisti esaltavano la guerra come un atto catartico, come una specie di mistico bagno che liberava dalle scorie e dalle abitudini della politica del piede in casa.
Nella guerra libica il nazionalismo, che si era costituito ufficialmente come movimento politico al congresso di Firenze del 1910, intravide la possibilità di porsi in primo piano sulla scena politica nazionale, catalizzando attorno a sé simpatie e consensi.
Riscosse anche le adesioni di vari gruppi della Destra antigiolittiana, che miravano ad un più accentuato conservatorismo ed autoritarismo all'interno ed a una politica più decisa nei rapporti internazionali.
Sono qui le premesse di quelle combinazioni che porteranno l'Italia all'intervento nella prima guerra mondiale.
Quanto ai socialisti, la guerra libica aveva riportato in primo piano la corrente massimalista e aveva rafforzato anche quella corrente rivoluzionaria che trovava in Benito Mussolini (poi direttore dell'Avanti!) una figura di primo piano.
Invano Turati cercò di mantenere il partito unito.
Il dialogo con Giolitti era ormai improponibile ed il socialismo italiano riprendeva la sua lotta controllo stato borghese, nel quale, secondo gli ottimisti del periodo aureo dell'età giolittiana, avrebbe dovuto identificarsi.
Le ultime importanti riforme introdotte da Giolitti prima della sua caduta furono il monopolio delle assicurazioni e il suffragio elettorale universale maschile
Il monopolio delle assicurazioni, votato nel 1911 dalla Camera, mirava salvaguardare i risparmiatori dai frequenti fallimenti delle società di assicurazione e stabiliva che gli utili del nuovo istituto (Istituto Nazionale Assicurazioni) sarebbero stati destinati alla cassa di previdenza sociale e invalidità.
La seconda riforma, da tempo sollecitata, la legge per l'introduzione del suffragio elettorale universale maschile, venne promulgata i1 30 giugno 1912: stabiliva il diritto di voto per tutti i cittadini di sesso maschile e maggiorenni (per gli analfabeti il limite di età venne fissato a 30 anni). Il corpo elettorale passava da circa 3 milioni e mezzo a quasi 9 milioni di votanti.
Era naturale che la consultazione elettorale fissata per il novembre 1913, can il nuovo sistema, aprisse problemi di natura politica fino ad allora sconosciuti. L'ingresso delle masse nella vita politica con proprie esigenze e programmi rompeva la vecchia prassi elettorale, ristretta a gruppi chiaramente identificabili.
Le masse non erano più facilmente manovrabili con i sistemi del clientelismo giolittiano.
Per la chiesa poi si poneva il problema della partecipazione alle urne di ingenti masse cattoliche, soprattutto delle plebi rurali del Mezzogiorno.
L'elettorato cattolico doveva quindi essere indirizzato, e non lanciato allo sbaraglio perdendo quell'unità d'intendimenti e d'azione a cui la Chiesa teneva molto.
Nacque da questa esigenza l'idea del Patto Gentiloni, dal nome del presidente dell'Unione elettorale cattolica. Il Patto consisteva in un elenco di sette punti programmatici che ogni candidato cattolico doveva sottoscrivere.
Tra i sette punti ricordiamo:
la difesa della libertà della scuola,
dell'istruzione religiosa
dell'unità della famiglia (in opposizione al divorzio)
il riconoscimento giuridico delle organizzazioni economiche e sociali cattoliche
la riforma tributaria e giudiziaria
Il Patto ebbe successo. Ad usufruirne furono principalmente candidati moderati e giolittiani, tanto che Antonio Gramsci poté scrivere che, con il patto Gentiloni, Giolitti cambiò di spalla al suo fucile, sostituendo all'alleanza con i socialisti, quella con i cattolici.
Per altri il patto rappresentò una specie di andata a Canossa dei liberali, costretti, per sopravvivere, a chiedere l'aiuto dei cattolici.
C'è da aggiungere, però, che i cattolici peccarono, anche in questa occasione, di precipitazione, com'era avvenuto con la loro adesione alla guerra di italo-turca, spinti dal desiderio di cancellare il ricordo della loro tenace intransigenza nei confronti dello stato liberale.
Secondo alcuni dati non ufficiali, ber 228 candidati liberali su 310 erano stati eletti con voti cattolici.
Il partito socialista era salito a 59 deputati, i riformisti a 19, i radicali a 73, i cattolici a 29, i nazionalisti furono 3.
A questa camera, nata da uno dei più grossi compromessi della storia parlamentare italiana, era riservato il compito di essere la protagonista del drammatico periodo dell'intervento italiano nella prima guerra mondiale.
Giolitti smentì un suo diretto intervento nell'operazione elettorale con i cattolici ed escluse che fossero avvenuti accordi tra governo e vaticano.
Allorché alla Camera il socialista Raimondo gli chiese quale compenso avrebbe dato ai Cattolici, Giolitti rispose: «L'aspetteranno un pezzo».
E' indubbio, comunque, che se Giolitti poté mantenere la propria maggioranza in parlamento, ciò fu dovuto principalmente al voto dei cattolici
Ma, nonostante il successo, il clima che aveva caratterizzato l'Italia giolittiana stava cambiando
Giolitti non riusciva più a fronteggiare la situazione, pressato a sinistra da un socialismo più deciso e meno aperto a possibili combinazioni di tipo riformista, a destra dalla vecchia opposizione conservatrice, capeggiata da Sonnino e Salandra, che trovava alleati presso i nazionalisti.
Arturo Labriola, il 9 dicembre 1913, disse alla Camera: «Ella, onorevole Giolitti, ha incarnato una situazione storica, ma ha finito le sue funzioni, e pertanto può prepararsi a fare le valigie». Labriola fotografava in modo brutale, con questa affermazione, la realtà politica di quel momento.
Antonio Salandra (1853-1931) liberal-conservatore raccolse l'eredità di Giolitti (marzo 1914). Il suo programma di governo non si discostava molto da quello giolittiano, ma la prassi era diversa.
Il 7 giugno 1914 ad Ancona la polizia sparò su una manifestazione socialista: tre dimostranti rimasero uccisi.
Lo sciopero generale fu proclamato in tutta Italia: dal 7 ai 13 giugno il paese fu sconvolto da una serie di agitazioni e tumulti, accompagnati anche da episodi di teppismo e da devastazioni di chiese, che ebbero il loro epicentro nelle Marche e nella Romagna e che presero il nome di settimana rossa.
Alla testa del movimento c'era la Sinistra socialista guidata da Mussolini, nuovo direttore dell'Avanti!; ad essa si erano uniti gli anarchici di Enrico Malatesta ed i repubblicani di Pietro Nenni.
Al termine della settimana rossa si contarono 16 morti tra i dimostranti e le forze dell'ordine.
Il movimento ebbe in realtà carattere più repubblicano e anarchico che socialista. Fu confuso e senza chiare prospettive politiche e non ritisci a svilupparsi che nelle zone ai margini dello sviluppo capitalistico. Fu quasi assente nel Mezzogiorno.
La settimana rossa fu comunque il segno della profonda crisi che attraversava il movimento operaio italiano e l'intero paese.
A poco più di un mese da queste agitazioni, lo scoppio della prima guerra mondiale creerà nuovi problemi ed inasprirà maggiormente la già difficile situazione politica interna italiana.
 |
| Appunti su: labriola giolitti fare le valigie, in cosa consiste la riforma tributaria giolittiana 1892-93, |
|
| Appunti Architettura | 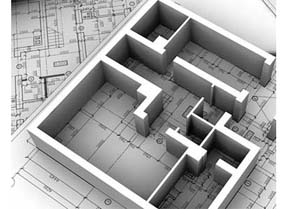 |
| Tesine Aeronautica |  |
| Lezioni Archeologia |  |