 |
|
 |
|
| Visite: 1051 | Gradito: |
Leggi anche appunti:Il mondo nell'etÀ dell'imperialismoIL MONDO NELL'ETÀ DELL'IMPERIALISMO Colonie di popolamento e di sfruttamento Tra Diary of Capt. J. D. Allen, HMS KentDiary of Capt. J. D. Allen, HMS Kent The Gneisenau and Nürnberg came MazdeismoMazdeismo Questa religione è stata quella a lungo più venerata nell'impero |
 |
 |
Come visto i fascisti giunsero alla presa del potere con un atto di forza.
Il 24 ottobre 1922 si riunirono a Napoli alcune decine di migliaia di camicie nere, e Mussolini le arringò in questi termini: «O ci daranno il governo, o lo prenderemo calando su Roma; ormai si tratta di giorni e forse di ore».
Il 27 ottobre un comunicato della direzione fascista (affidata per l'occasione ai quadrumviri Balbo, Bianchi, De Bono e De Vecchi) annunciò agli Italiani che l'esercito delle camicie nere marciava «disperatamente» su Roma.
In verità la disperazione era solo nelle parole, perché la Marcia su Roma (28 ottobre 1922) non incontrò resistenze apprezzabili.
Il re, rientrato precipitosamente a Roma da San Rossore la sera del 27 ottobre, s'accordò in un primo tempo con Facta per la proclamazione dello stato d'assedio, ma la mattina dopo si rifiutò di firmarlo, sicché a Facta non rimase altra alternativa che quella di presentare le dimissioni.
L'incarico di formare il nuovo governo venne allora affidato da Vittorio Emanuele III a Mussolini, quasi si trattasse di un normale avvicendamento di ministeri (31 ottobre).
Il governo formato da Mussolini (31 ottobre 1922) non era composto di soli fascisti, ma da una coalizione nella quale entrarono anche esponenti del liberalismo, del Partito popolare e dell'esercito (il generale Armando Diaz e l'ammiraglio Thaon de Revel). Rimasero all'opposizione i comunisti, i repubblicani e i socialisti, ulteriormente scissi alla vigilia della «marcia su Roma» in massimalisti del P.S.I. e in socialdemocratici del nuovo Partito socialista unitario, guidato da Filippo Turati.
La nomenclatura costituzionale - partiti, sindacati, governo, opposizione - rimaneva indenne, e il fascismo, che s'era affermato attraverso una «rivoluzione», pareva ora rientrare nella normalità e nella legge.
La «normalizzazione» era auspicata soprattutto dai liberal-conservatori che aspiravano a congedare le squadre d'azione, dopo averle utilizzate contro il proletariato.
E la normalizzazione in realtà ci fu: ma consistette semplicemente nell'erezione progressiva del fascismo a regime
Mussolini, infatti, riuscì nel corso di un biennio a svuotare di ogni concreto significato le istituzioni liberali nelle quali pareva volersi inserire, e le sostituì con un complesso apparato che gli consentì l'esercizio di un largo potere personale.
Giocando abilmente sull'equivoco, egli, già nel discorso di presentazione del nuovo governo alla Camera (16 novembre 1922), per un verso espresse la propria deferenza verso i deputati, e impegnò il ministero a combattere contro ogni illegalismo, «anche contro 1'eventuale illegalismo fascista», per l'altro dichiarò a tutte lettere: « Io affermo che la rivoluzione ha i suoi diritti. Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto».
La vantata onnipotenza non esimeva però Mussolini dal «pagare i debiti» ai suoi protettori delle classi ricche mediante una serie di provvedimenti che sancivano:
l'abolizione della nominatività dei titoli (introdotta da Giolitti)
una drastica riduzione delle imposte di successione
l'abrogazione delle imposte sui sovrapprofitti di guerra
lo sblocco dei fitti
la restituzione ai privati della rete telefonica, dell'industria dei fiammiferi e delle assicurazioni sulla vita.
Ma anche più redditizia era, per i capitalisti, l'intimidazione esercitata dal governo sul movimento sindacale, rivolta a minarne la combattività e a permettere quindi un costante abbassamento dei salari.
La politica antiproletaria si esprimeva anche nello sfoltimento (ispirato per lo più a criteri di discriminazione politica) di personale ferroviario e impiegatizio, e persino nella provocatoria abolizione della festività del 1° maggio, sostituita dal Natale di Roma (21 aprile), ossia da una ricorrenza di significato puramente retorico.
Del resto l'infatuazione per l'antica Roma, già largamente presente nella nostra cultura, fu portata dal fascismo oltre i limiti del grottesco. Alla riesumazione del Natale di Roma si accompagnò col tempo la messa a punto di un complesso rituale retorico-archeologico: gli Italiani - esortava un motto mussoliniano - dovevano «sognare l'Italia romana»; i bambini non ancora in età per diventare «balilla» erano «Figli della lupa» (naturalmente capitolina); il «duce» e il re erano spesso designati nelle iscrizioni come DUX e REX; e c'erano poi i consoli, i seniori, le legioni e via dicendo.
Benché il fascismo fosse ormai al governo, continuava anche il terrorismo delle squadre d'azione: fra i numerosissimi episodi di violenza citeremo i fatti di Torino del dicembre 1922, durante i quali gli squadristi - nella più completa impunità - devastarono le sedi delle organizzazioni di sinistra, distribuirono bastonature e purghe, uccisero ben undici persone, bandirono dalla città i dirigenti comunisti, intimarono a tutti gli iscritti ai partiti «sovversivi» di rincasare prima della mezzanotte.
Nel quadro di questa politica, il ministro delle finanze, l'economista liberista Alberto De Stefani che rimase in carica fino al 1925, smantellò le cosiddette «bardature di guerra», ossia eliminò ogni restrizione alla libertà d'impresa, inasprì le imposte indirette, sottopose i salari a imposizione diretta e, sanato il bilancio statale grazie a un uso del fisco che privilegiava vistosamente le classi ricche, creò le condizioni per una rapida espansione dei profitti, degli investimenti e della produzione.
I risultati così conseguiti furono cospicui e, per quanto in parte attribuibili alla ripresa economica che era in corso in campo internazionale, concorsero ovviamente a consolidare il fascismo: fra il 1922 e il 1925 la produzione industriale aumentò di circa il 16% all'anno, mentre notevoli incrementi furono realizzati anche nell'agricoltura.
Procedeva intanto anche la trasformazione del fascismo in regime. Sin dal dicembre del 1922 cominciarono le riunioni periodiche del Gran Consiglio del Fascismo (costituito dalla direzione del P.N.F., integrata dai notabili del partito): un organo collegiale che non aveva all'inizio alcuna veste giuridica, ma che era di fatto una specie di «supergoverno» e usurpava le funzioni del Consiglio dei ministri.
Nello stesso dicembre un decreto regio, emesso su proposta del governo, sanciva l'istituzione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (reclutata fra gli squadristi ed esonerata dal giuramento di fedeltà al re), che era esplicitamente un esercito di parte, legittimato dallo Stato. L'inquadramento nella Milizia, d'altronde, consentiva a Mussolini di tenere sotto controllo la base squadrista che, subornata dai «ras», poteva pur sempre sfuggirgli di mano.
Per portare a compimento l'instaurazione di un potere totalitario, il fascismo doveva però liberarsi anche del Partito popolare che, nel Congresso di Torino dell'aprile 1923, aveva sì ribadito la sua volontà di collaborare col governo, ma aveva altresì espresso delle riserve sul fascismo e aveva riaffermato la propria completa autonomia ideale e politica.
Tanto era bastato al «duce» per estromettere dal governo i ministri popolari, ma rimaneva il fatto che il partito cattolico, in quanto appoggiato dalla Chiesa, non poteva agevolmente essere sottoposto alle stesse vessazioni e stragi riservate ai partiti di sinistra. Bisognava perciò rompere la solidarietà fra la Chiesa e il partito e far leva sui gruppi della destra cattolica, disposti a confluire e a identificarsi col P.N.F.
Di qui le blandizie di Mussolini verso l'autorità ecclesiastica e, nello stesso tempo, l'ostilità e le minacce contro gli esponenti cattolici più decisi a conservare al partito una fisionomia autonoma e un'ispirazione democratica.
Questa tattica ebbe pieno successo, tanto che lo stesso don Sturzo il 10 luglio del 1923, cedendo a pressioni della gerarchia ecclesiastica, abbandonò la vita politica. Tale era il prezzo che i popolari pagavano per i troppo facili successi elettorali del 1919 e del 1921: come allora l'appoggio delle parrocchie li aveva portati d'un balzo a conquistare posizioni che ai socialisti erano costate decenni di lotte, così ora bastava l'intervento ufficioso del Vaticano per costringere un uomo come don Sturzo a dimettersi dalla segreteria del partito.
Padrone di fatto del paese, il fascismo aveva alla Camera una rappresentanza assai inferiore ai consensi progressivamente conquistati presso ampi strati dell'opinione pubblica, ed era perciò abbastanza ovvio che il «duce» mirasse a sciogliere anticipatamente la Camera e a indire nuove elezioni. In questa prospettiva, il governo, fra il luglio e il novembre fece approvare dalla Camera e dal Senato una nuova legge elettorale detta «legge Acerbo» - dal nome del proponente - che prevedeva un larghissimo premio (due terzi dei seggi) per la lista che avesse conseguito la maggioranza relativa i dei consensi.
Si precisa che una lista (o un gruppo o un partito) consegue la maggioranza relativa quando ottiene un numero di voti superiore a quello delle liste concorrenti, considerate separatamente. La maggioranza si definisce invece come assoluta o semplice quando è costituita da più della metà dei votanti. La maggioranza si dice infine qualificata quando è costituita da una frazione dei votanti superiore alla metà e specificamente richiesta dalla legge in casi particolari: è qualificata, ad esempio, una maggioranza di due terzi dei votanti.
Ne gennaio del 1924 la Camera fu pertanto sciolta, e le elezioni vennero indette per il 6 aprile. I fascisti vi si presentarono in coalizione con molti esponenti del vecchio liberalismo e con i cattolici di destra, indipendenti o transfughi dal Partito popolare.
Al cosiddetto listone liberal-clerico-fascista si contrapposero i socialisti del P.S.I. e del P.S.U., i comunisti, i popolari, i liberali democratici antifascisti organizzati da Giovanni Amendola, i repubblicani e altri gruppi minori; uno di questi ultimi era capeggiato da Giolitti che si presentava peraltro come fiancheggiatore del governo.
La campagna elettorale si svolse in un clima di sopraffazione sistematica delle opposizioni, e i risultati, naturalmente, furono ultrafavorevoli al «listone», che conseguì più del 60% dei voti e ottenne 356 seggi sui 535 di cui si componeva la Camera. Per quanto viziati dai metodi impiegati per ottenerli, questi risultati indicavano, quanto meno, che il fascismo godeva di ampi consensi.
Nella nuova Camera, il deputato del P.S.U. Giacomo Matteotti, benché continuamente interrotto dalle minacce e dagli insulti dei fascisti, contestò la validità delle elezioni e fornì un ampio e documentato elenco delle violenze commesse dai fascisti nel periodo preelettorale: l'uccisione del candidato del P.S.I. Antonio Piccinini, i bandi imposti ai candidati di opposizione, le urne affidate in custodia alla Milizia fascista, i soprusi perpetrati durante le operazioni elettorali, il controllo esercitato sugli elettori dai fascisti, che in taluni casi si erano spinti sino ad accompagnarli in cabina.
Matteotti tenne il suo discorso alla Camera il 30 maggio del 1924. Il 10 giugno fu aggredito a Roma da quattro figuri dello squadrismo, rapito in automobile e trucidato. Il suo cadavere fu ritrovato solo il 16 agosto
L'emozione nel paese fu veramente enorme: il governo fu duramente attaccato alla Camera, e il deputato repubblicano Chiesa accusò Mussolini di complicità. Si ebbe uno sbandamento parziale fra le stesse file del fascismo, mentre i gruppi d'opposizione, eccettuati i comunisti, trovavano per la prima volta un denominatore comune e decidevano d'abbandonare la Camera, sulla cui maggioranza gravavano così infamanti sospetti.
Questa secessione - che per analogia con quelle della plebe romana del V secolo a.C. fu detta dell'Aventino - era ispirata all'ipotesi che, travolto dalla squalifica morale e magari per l'intervento del re, il governo dovesse dimettersi.
In realtà Mussolini e i suoi seguaci non erano uomini da cedere di fronte a una condanna morale e, d'altra parte, se si fossero ritirati, non solo avrebbero distrutto il loro avvenire politico, ma avrebbero anche dovuto rispondere di fronte alla legge, se non addirittura di fronte al popolo, delle violenze commesse. Vittorio Emanuele III, poi, aveva già dato ampia prova della sua collusione con il fascismo.
Infatti, dopo un primo momento di perplessità, i fascisti passarono alla controffensiva: Roberto Farinacci, il ras di Cremona, reclamava una «seconda ondata» di violenze; il 10 luglio un decreto-legge assegnava al governo i più ampi poteri di controllo sulla stampa, che d'allora in poi avrebbe potuto essere taglieggiata a piacimento con sequestri, sospensioni e processi ai direttori e ai redattori dei giornali.
Il prestigio dell'Aventino era grande, ma le leve del potere rimanevano in mano al «duce» e ai suoi seguaci. Il braccio di ferro fra queste due forze di così diversa natura durò sino alla fine del 1924, mentre Mussolini, secondo una tattica largamente sperimentata, alternava le promesse di normalizzazione alle minacce.
Quando finalmente gli parve che la «questione morale», protraendosi ulteriormente, potesse diventare pericolosa, egli ruppe gli indugi, e il 3 gennaio del 1925 annunziò alla Camera - assenti gli aventiniani - la cessazione di fatto di ogni garanzia liberale statutaria.
A proposito del delitto Matteotti e delle violenze fasciste in generale, le parole del «duce» furono questa volta chiarissime: «.., dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato una associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere».
Col discorso del 3 gennaio e con i provvedimenti che immediatamente seguirono (arresti di oppositori, scioglimento di associazioni politiche, sequestri di giornali eccetera) si ebbe il trapasso esplicito del fascismo a regime.
La famosa «normalizzazione», di cui tanto si era parlato, si rivelava per quello che era effettivamente: non un ritorno alla legalità liberale, ma l'istaurazione di un regime autoritario.
Il terrorismo reazionario, secondo le previsioni di Gramsci, era finalmente diventato Stato. E non si trattava della tradizionale reazione imposta semplicemente con la polizia e con l'esercito, ma di una reazione veramente nuova ed originale, che aveva nella piccola borghesia la sua base di massa e si ammantava di populismo demagogico.
Mussolini era dunque l'inventore di uno «scenario» che consentiva di contrabbandare come «rivoluzionaria» la più retriva delle politiche. Né egli rinuncerà mai a parlare di «rivoluzione fascista», anzi «vorrà sempre parere, e si illuderà forse sempre di essere, socialista».
Nel giro di alcuni anni il fascismo completò la propria edificazione in regime totalitario, e ogni residua libertà politica e sindacale venne a cessare.
La stampa fu progressivamente imbavagliata mediante censure, sospensioni delle pubblicazioni, sequestri, allontanamento coatto di direttori non graditi all'autorità. In un primo tempo si pretese dai giornalisti solo una professione di lealtà al fascismo, ma più tardi si impose loro la più smaccata adulazione: le informazioni venivano trasmesse tramite l'«agenzia Stefani», strumento del regime, e il Ministero della Cultura Popolare, istituito nel giugno del 1937, inviava ai giornali minute istruzioni sul rilievo tipografico da conferire alle notizie, sui commenti e persino sul tono col quale dovevano essere presentate ai lettori.
Persino in campo cinematografico il fascismo fece ampio ricorso alla censura, mediante la quale permetteva di proiettare solo film che si armonizzassero con la morale corrente e lo spirito nazionalistico, diffondendo un ideale di ottimismo piccolo-borghese. Con l'avvento del sonoro, però, Mussolini pensò di usare il mezzo cinematografico per scopi di esplicita propaganda politica, e nel 1934 nominò Luigi Freddi alla direzione dei cinegiornali, allora chiamati film-Luce dal nome dell'Istituto che ne aveva il monopolio (L'Unione Cinematografica Educativa). Tali film dovevano obbligatoriamente precedere le proiezioni, presentando le immagini, i riti, le cerimonie e le opere del regime.
L'importanza del mezzo radiofonico fu molto grande per la propaganda politica fascista. Nel 1927 fu fondato l'EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche): un ente statale che aveva il monopolio delle trasmissioni. Soprattutto negli anni '30, il regime utilizzò la radio come un vero e proprio mezzo di comunicazione di massa, dotando gratuitamente di apparecchi radiofonici scuole, municipi, case del fascio, per far arrivare al maggior numero di persone possibile radiocronache di avvenimenti, servizi di attualità, ma soprattutto i discorsi del duce e gli incensamenti continui del regime.
La politica culturale del fascismo fu diretta dal filosofo Giovanni Gentile, che diede impulso ad una serie di importanti iniziative, volte ad ottenere il consenso degli intellettuali attorno al fascismo: tra queste la più rilevante fu l'elaborazione dell'Enciclopedia italiana.L'Enciclopedia nacque fra il '29 e il '38 dalla collaborazione di quasi tutti gli intellettuali italiani più famosi: l'eccezione più clamorosa fu costituita dal Croce.
Naturalmente a tanta perfezione il regime arrivò solo attraverso diverse tappe, delle quali ci limiteremo a ricordare le principali.
Tra il febbraio e il settembre del 1926 due disposizioni di legge, concernenti rispettivamente i piccoli e i grandi comuni, sostituiscono ai sindaci e ai consigli comunali, elettivi, i «podestà» e le «consulte», di nomina governativa.
Il 3 aprile 1926 viene istituita l'Opera Nazionale Balilla (sostituita nel 1937 dalla Gioventù Italiana del Littorio), che ha il compito di monopolizzare l'educazione della gioventù e di «forgiare» le nuove generazioni secondo gli ideali del militarismo fascista.
Nella stessa data si ha il riconoscimento giuridico dei sindacati fascisti e delle rappresentanze padronali fasciste. Scioperi e serrate vengono proibiti, e ogni vertenza sui contratti nazionali di lavoro (che impegnano anche i non iscritti alle associazioni) viene deferita alla corte d'appello, che per l'occasione funge da Magistratura del Lavoro. Altre associazioni di mestiere possono continuare ad esistere di fatto, cioè senza riconoscimento giuridico, ma in realtà, per il sistematico boicottaggio cui vengono assoggettati i loro aderenti, devono ben presto sciogliersi: come farà nel gennaio del 1927 la stessa Confederazione Generale del Lavoro, costatando che «in Italia non c'era posto per l'organizzazione di mestiere non riconosciuta».
Nell'aprile del 1927 il Gran Consiglio del Fascismo approva una Carta del Lavoro, che ufficialmente segna l'atto di nascita del cosiddetto Stato corporativo e viene vantata come «una rivoluzione sociale pacifica». In realtà essa contiene solo generici aforismi e dichiara, per esempio, che la nazione è «una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista»; che «nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà fra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione»; oppure - in termini assai più chiari - che «Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro», e che «Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione».
Delineato fra il 1926 e il 1927, lo Stato corporativo fu attuato giuridicamente nel 1934 con l'istituzione di 22 Corporazioni, grazie alle quali le rappresentanze delle categorie economiche sostituito le «superate» rappresentanze politiche del vecchio liberalismo. Sulla base di questa premessa, nel gennaio del 1939 la Camera dei deputati venne sostituita da una Camera dei Fasci e delle Corporazioni - formata dai componenti del Consiglio Nazionale del P.N.F. e del Consiglio Nazionale delle Corporazioni - nella quale le votazioni avvenivano sempre in modo palese e, molto spesso, per acclamazione.
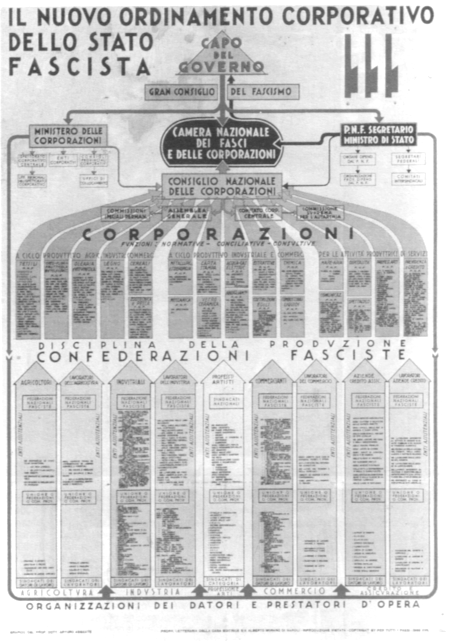
Secondo le vanterie di Mussolini, le corporazioni avrebbero rappresentato milioni di lavoratori e di produttori, ma in verità esse rappresentavano solo il regime, perché i loro capi dovevano essere per legge «di sicura fede nazionale», cioè fascisti.
Pertanto lo Stato corporativo non si fondò affatto sulla rappresentanza delle categorie economiche e sulla «collaborazione fra capitale e lavoro», ma piuttosto sulla subordinazione delle categorie economiche al regime, e in definitiva, dati i legami organici intercorrenti fra capitalismo e regime, sulla subordinazione coatta dei lavoratori al padronato.
Il 31 ottobre del 1926 il quindicenne Anteo Zamboni attentò a Bologna alla vita del «duce» e venne immediatamente linciato dai fascisti.
Ne seguì una nuova ondata di violenze in tutta la penisola e una serie di provvedimenti, rivolti all'ulteriore fascistizzazione dello stato:
i deputati dell'opposizione, già ridotti alla più completa impotenza, vennero addirittura dichiarati decaduti dal mandato parlamentare;
tutti i partiti e le associazioni non fasciste vennero sciolti e dichiarati illegali;
fu reintrodotta la pena di morte (già abolita con il codice Zanardelli);
fu istituito il confino di polizia, vale a dire la deportazione di persone invise al regime dal luogo di residenza abituale in località per lo più sperdute, nelle quali i «condannati» erano soggetti a uno speciale regime di controlli e di vigilanza. La condanna al confino era comminata con un semplice atto amministrativo, senza che alla vittima venisse contestato alcun reato: di fronte a un simile arbitrio non c'era dunque nessuna possibilità di difesa.
fu istituito un Tribunale speciale per la difesa dello Stato (presieduto da un generale e formato da cinque consoli della Milizia) contro le sentenze del quale non era ammesso il ricorso. Decine di condanne a morte e 28 115 anni di carcere furono irrogati dal Tribunale speciale agli oppositori del regime. Fra i più colpiti furono i comunisti. Granisci fu condannato nel 1928 a più di vent'anni di reclusione.
Se il totalitarismo fascista si affermava compiutamente nel controllo delle attività statali, non per questo riusciva peraltro a conquistare profondamente tutti gli Italiani ai suoi miti e alle sue parole d'ordine.
L'indifferenza politica di vasti strati della popolazione, che nei primi tempi aveva facilitato l'avvento del fascismo, opponeva ora una barriera insormontabile alla diffusione della mistica fascista, che, per quanto propagandata da scuole apposite (una Scuola di mistica fascista fu inaugurata a Milano nel novembre del 1931) rimase appannaggio di pochi esaltati.
In tal modo, per il tramite fortemente negativo dell'apoliticità, molti salvarono almeno il buon senso e si rifiutarono di accettare i deliri pseudoreligiosi proposti del fascismo.
La lotta attiva contro il fascismo, che poteva costare il carcere o la vita, fu invece condotta solo da un'esigua élite, costretta ovviamente alla clandestinità o all'esilio. Il fuoruscitismo, iniziato ancor prima della «marcia su Roma», andò aumentando negli anni successivi e raggiunse la massima intensità fra il 1926 e il 1927. Tutto lo stato maggiore antifascista fu costretto a rifugiarsi all'estero e si orientò prevalentemente verso la Francia: in complesso gli emigrati per motivi politici furono circa 10.000. In Parigi, principalmente per iniziativa dei socialisti e dei repubblicani, si costituì una Concentrazione antifascista, che peraltro conseguì risultati pratici assai modesti.
Diversa vicenda ebbe il Partito comunista che, già organizzato in modo semiclandestino, si convertì alla completa clandestinità nel 1926 e, mentre la direzione si trasferiva in Francia, mantenne anche in Italia dei centri organizzativi.
La guida del partito, inizialmente tenuta da Bordiga, passò in seguito a Gramsci, a Togliatti e al loro gruppo, che risultò nettamente maggioritario nel Congresso di Lione (1926). In tale congresso fu elaborata un'attenta e differenziata analisi del fascismo, intesa a metterne in evidenza le contraddizioni e quindi a individuare gli spazi per una prosecuzione della battaglia comunista. Mentre Bordiga aveva considerato il fascismo come una semplice variante della dittatura borghese, in sostanza non dissimile dal parlamentarismo, già Gramsci ne aveva colti i caratteri specifici di eccezionale violenza e aveva quindi aperto la strada per una considerazione non settaria della stessa democrazia borghese.
A conclusioni analoghe giunse più tardi Togliatti, specie dopo che il VII Congresso del Komintèrn (Mosca, 1935), - per allargare il fronte dell'antifascismo e combattere più efficacemente contro il nazismo tedesco - superò le precedenti preclusioni nei confronti della socialdemocrazia e dei movimenti genericamente progressisti. Si preparava in tal modo la svolta che il Partito comunista avrebbe attuata durante e dopo la seconda guerra mondiale, e per il momento si individuavano possibilità d'azione negli stessi organismi di massa del fascismo (sindacati, organizzazioni giovanili eccetera), nei quali i comunisti tentarono costantemente di infiltrarsi per recuperare quei «fratelli in camicia nera» che erano stati ingannati dallo scenario demagogico del fascismo. Per conseguire questi risultati, attivisti del partito, muniti di documenti falsi, mantenevano i rapporti con l'Italia, incappando peraltro molto spesso nelle reti della polizia fascista.
Sul terreno della cospirazione e della lotta pratica contro il fascismo si posero anche i gruppi di «Giustizia e Libertà» fondati a Parigi da Carlo Rosselli. Questi, traendo ispirazione dalla Rivoluzione liberale di Piero Gobetti, tentò una sintesi delle più profonde esigenze liberali e socialiste, e si propose di combattere il fascismo non per restaurare lo status quo, ma per promuovere un radicale rinnovamento della società italiana.
Per la repressione dell'antifascismo il regime organizzò a sua volta l'O.V.R.A. (probabilmente: Opera Vigilanza Repressione Antifascismo): una polizia segreta che provvedeva efficacemente a individuare i nemici militanti del regime e contribuiva altresì, per l'alone di mistero che la circondava, a dare a tutti gli Italiani l'impressione di essere costantemente vigilati (tanto che l'abitudine di parlare a bassa voce e di guardarsi le spalle non appena la conversazione sfiorasse argomenti politici ebbe allora ampia diffusione).
Accanto all'opposizione dichiaratamente politica non cessò mai in Italia una larvata opposizione culturale, promossa dai pochi intellettuali che, mentre i più preferivano accordarsi col fascismo e goderne i favori, si astenevano da ogni incensamento e manifestavano nei libri e nelle riviste la loro più o meno esplicita avversione al fascismo. In questo campo fu particolarmente rilevante l'opera di Benedetto Croce che, dopo aver a lungo coltivata la speranza di una conversione del fascismo al liberalismo, si avvide dell'errore e fu costante esempio di autonomia di giudizio e di dignità morale.
In linea di principio, nessun accordo sarebbe stato possibile fra il cattolicesimo, per il quale alla persona umana competono diritti naturali che l'autorità politica non può disconoscere, e il fascismo che professava apertamente la totale subordinazione dell'individuo al cosiddetto Stato etico. In linea di fatto, invece, il fascismo, se non riuscì mai ad ottenere la subordinazione della Chiesa alle proprie pretese totalitarie, fu però largamente favorito dall'atteggiamento benevolo e conciliante della gerarchia ecclesiastica e dello stesso papa Pio XI (1922-1939).
A questa paradossale convergenza pratica concorsero molteplici ragioni, ma principalmente il fatto che il fascismo si presentava come una controrivoluzione preventiva contro il comunismo ateo, recentemente affermatosi in Russia.
Nell'ordine materiale, inoltre, provvedimenti come l'abolizione della nominatività dei titoli avevano giovato alla potenza finanziaria della Chiesa e degli ordini religiosi non meno che al capitalismo laico, mentre, d'altra parte, numerosi erano i cattolici che, unendo strettamente la loro pratica religiosa alla causa della conservazione sociale, premevano per un accordo col fascismo.
Dalla parte di Mussolini i motivi che spingevano all'accordo erano più semplici ed immediati. Malgrado il suo superficiale e violento anticlericalismo, egli considerava la Chiesa come una tradizionale forza d'ordine, di disciplina, di gerarchia, pericolosissima come avversaria quanto preziosa come alleata, e voleva pertanto trasformarla in un pilastro del regime, salvo poi tener sotto controllo, con i metodi consueti, gli eventuali «eccessi» di religiosità irriducibile.
Dalle due parti esistevano dunque ragioni di convergenza ma anche di fondamentale dissenso: e riserve e condanne si alternavano perciò ad atti e parole di distensione.
Così, per esempio, il papa, al concistoro del 14 dicembre 1925, protestò contro la politica sindacale del fascismo, che emarginava le organizzazioni cattoliche, e contro ogni «concezione politica che facendo la società e lo stato fine a se stessi è facilmente, per non dire fatalmente, portata a sacrificare ed assorbire i diritti individuali», ma ribadì anche che la Chiesa era «aliena dall'anarchia, alla quale liberalismo e socialismo, da essa condannati indeprecabilmente, conducono e travolgono». Un anno dopo, riferendosi alle rappresaglie squadristiche seguite all'attentato dello Zamboni, ancora una volta Pio XI protestò contro la «tempesta di violenze e devastazioni contro persone e cose», ma definì anche Mussolini come colui «che con tanta energia governa le sorti del Paese, da far giustamente ritenere periclitare il Paese stesso ogni qualvolta periclita la sua persona» (periclitare significa essere in pericolo).
A sua volta il fascismo alternò alle blandizie la maniera forte e, per esempio, con provvedimento del 9 aprile 1928 vietò ogni organizzazione giovanile che non fosse inquadrata nell'Opera Nazionale Balilla, stroncando così le organizzazioni sportive cattoliche e, in particolare, i Giovani esploratori cattolici.
Tra i cattolici italiani il fascismo fu accolto in maniera controversa: in alcuni ambienti ci si adattò al nuovo regime, riponendovi addirittura speranze di rigenerazione morale e politica, mentre una significativa parte della cultura cattolica si orientò verso atteggiamenti di opposizione e velato rifiuto, soprattutto dopo l'approvazione dei Concordato. L'Azione Cattolica, in particolare, osteggiava sotterraneamente il regime organizzando commissioni per lo studio delle attività sociali, e cercava di sottrarre ai fascisti il monopolio dell'educazione della gioventù. Nel 1931 il regime reagì a queste forme di dissenso ordinando ai prefetti di sciogliere i circoli cattolici ed espellendo gli appartenenti alla F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) dai G.U.F. (Gruppi Universitari Fascisti). Pio XI protestò con forza contro le azioni repressive, e gli uomini del regime cercarono un nuovo accordo, firmato poi il 2 settembre 1931, in cui si limitava notevolmente l'autonomia dell'Azione Cattolica, pur lasciandole la possibilità di gestire iniziative per l'educazione della gioventù.
Nonostante questi screzi, i contatti iniziati sin dal 1926 per una conciliazione fra Stato e Chiesa, che ponesse termine alle ostilità apertesi dopo l'occupazione di Roma, venivano portati a buon segno, e l'11 febbraio 1929 Mussolini e il cardinale Pietro Gasparri, rappresentanti delle due parti, firmavano gli accordi conclusivi, articolati in un trattato, in una convenzione finanziaria e in un concordato.
Con il trattato si abrogava la legge delle guarentigie e si riconosceva alla Santa Sede «la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano creandosi per tal modo la Città del Vaticano»; la Chiesa dichiarava a sua volta definitivamente risolta la questione romana e riconosceva il Regno d'Italia, retto dalla dinastia dei Savoia e avente in Roma la propria capitale.
Con la convenzione finanziaria l'Italia si obbligava a versare alla Santa Sede la somma di circa due miliardi di lire (pari a circa 1450 miliardi in lire 1986), a titolo di indennizzo per l'occupazione dello Stato Pontificio avvenuta nel 1870.
Con il concordato (rimasto in vigore fino al 1984) si garantiva la più assoluta libertà alla Chiesa nell'esercizio delle sue funzioni religiose e spirituali, si assicurava ai vescovi la più ampia possibilità di comunicazione con il clero e con i fedeli, e alla Santa Sede quella con l'intero mondo cattolico, mentre i chierici venivano esonerati dall'obbligo del servizio militare e lo Stato si impegnava ad usare speciali riguardi nel caso di procedimenti penali contro gli ecclesiastici. Particolarmente importanti, perché intaccavano in parte la sovranità dello Stato, erano l'art. 5, per il quale i preti apostati o irretiti da censura non potevano esercitare alcun ufficio che li mettesse a contatto immediato col pubblico (per esempio l'insegnamento); l'art. 34, con il quale lo Stato riconosceva «al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili»; l'art. 36, con il quale l'Italia si impegnava a considerare come «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica» (e ne conseguiva l'introduzione dell'insegnamento religioso anche nelle scuole secondarie).Sempre illiberale, ma per ragioni opposte, era l'art. 43, con il quale le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica venivano riconosciute dallo Stato italiano, in quanto esse svolgessero «la loro attività al di fuori di ogni partito politico per la diffusione e l'attuazione dei princìpi cattolici». Se infatti per gli altri aspetti il concordato sembrava restaurare in Italia uno Stato semiconfessionale, l'art. 43 riduceva l'Azione Cattolica sul terreno di un apostolato del tutto staccato da quelle attività sociali e, in alto senso, politiche, che necessariamente derivano da ogni autentica ispirazione religiosa. In questo modo almeno lo intendeva il fascismo, che nel 1931 fece oggetto delle consuete violenze le istituzioni dell'Azione Cattolica, senza risparmiare neppure i più venerati simboli della fede. La pace fu presto ristabilita a condizione che l'Azione Cattolica rinunciasse ad ogni sua autonoma presenza sul terreno sociale e si impegnasse anzi a collaborare «alle finalità sociali e nazionali che, in un paese cattolico, lo Stato coll'attuale ordinamento si propone di raggiungere».
Intanto però, poco dopo la firma dei Patti che si dissero «lateranensi» dal palazzo del Laterano dove furono sottoscritti, in un discorso del 14 febbraio 1929, Pio XI poté dire che il concordato era «se non il migliore di quanti ce ne potessero essere, almeno fra i migliori» e parlò di Mussolini in termini altamente elogiativi, dicendo che per la conciliazione «forse ci voleva un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare, un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale».
Nel marzo del 1929 si svolsero in Italia le nuove coatte elezioni: su lista unica proposta addirittura dal Gran Consiglio del Fascismo. Si trattava evidentemente di una finzione, come dimostrarono i risultati: oltre 8 milioni e mezzo di voti favorevoli contro solo 13000 contrari. Comunque, in quell'occasione molti esponenti del mondo cattolico e l'autorevole rivista dei gesuiti, Civiltà cattolica, esortarono i fedeli ad esprimere con il loro voto favorevole l'approvazione ai Patti Lateranensi.
In un bilancio complessivo, dunque, la «conciliazione» ebbe nell'immediato un esito disastroso, perché contribuì potentemente a consolidare il regime.
In una più ampia prospettiva storica, essa ebbe invece, un significato parzialmente positivo, in quanto contribuì ad eliminare il traumatico dissidio fra lo Stato italiano e la Chiesa, pur però attraverso una sorta di "riclericalizzazione" dello stato.
La politica di De Stefani, nel quadro antiproletario già illustrato, aveva conseguito fra il 1922 e il 1925 risultati notevolissimi, fondati in buona parte sull'aumento delle nostre esportazioni che compensava largamente il calo della domanda interna, derivante dalla compressione dei salari.
Il punto debole dell'economia italiana - cioè la necessità di importare materie prime e grano da paesi a valuta forte - era peraltro rimasto intatto e poteva costituire un grave pericolo qualora la lira avesse perduto capacità di acquisto, come appunto accadde intorno al 1925[1].
La lira, infatti, che già durante la guerra aveva subìto una pesantissima svalutazione, dopo un periodo di stabilità riprese a deprezzarsi fra il 1925 e il 1926, quando la sterlina passò dal cambio contro 120 lire al cambio contro più di 153 lire (e il dollaro passò da 23 a più di 31 lire). Tale deprezzamento, se per un verso conservava la competitività dei nostri prodotti sul mercato internazionale, per l'altro rendeva rovinoso per l'Italia l'acquisto all'estero delle materie prime e del grano, e nello stesso tempo falciava i risparmi dei ceti medi, che costituivano la base di massa del regime.
II governo pensò dunque di correre ai ripari e - sostituito alle finanze al liberista De Stefani il ministro Giuseppe Volpi, di diverso orientamento - decise di difendere ad oltranza la lira, mediante manovre monetarie e mediante provvedimenti intesi a contenere le importazioni di grano, petrolio, minerali e cellulosa, grazie alla compressione dei consumi, all'incentivazione della cerealicoltura (battaglia del grano), al più intenso sfruttamento delle assai misere risorse minerarie nazionali e ad altri espedienti analoghi (come quello, recentemente riproposto, di miscelare la benzina con alcol).
Il traguardo di quota novanta - così definito perché i portò il cambio con la sterlina a poco più di novanta lire - fu annunciato dal «duce» al paese in un discorso a Pesaro (18 agosto 1926), nel quale egli s'impegnò a difendere la lira «fino all'ultimo sangue».
Senonché il «sangue» fu però quello dei salariati: per rivalutare rapidamente la lira e per conservare la competitività internazionale dei nostri prodotti, il modo di gran lunga «più comodo» era infatti quello di comprimere ulteriormente i salari, di aumentare lo sfruttamento e di diminuire i costi di produzione mediante «opportuni» licenziamenti.
Infatti, meno lire circolano, più la lira vale. Comprimendo gli stipendi si fa appunto diminuire la circolazione delle lire. Ma non solo la gente non è entusiasta, bensì accade anche che la domanda interna diminuisca, dato che la maggior parte dei consumatori vive di salari o di stipendi, sicché il ciclo stesso della produzione rischia di bloccarsi per mancanza di clienti. A meno che lo stato non intervenga a sostenere la domanda, per esempio con commesse belliche, come accadde appunto in questo caso.
Però l'unico modo per utilizzare i cannoni, che non sono strumenti di produzione, è la guerra. E anche la guerra seguì infallibilmente. I successi economici del fascismo negli anni 1922-25, fondati sulla compressione dei salari, implicavano, in ultima analisi, questo risultato finale.
Il costo della deflazione - si diceva - avrebbe comportato un calo nel costo della vita e avrebbe quindi restituito ai salari la loro capacità d'acquisto, ma in realtà le cose procedevano diversamente, perché, anche quando si aveva effettivamente un calo considerevole nei prezzi all'ingrosso, questo, per gli alti costi di distribuzione e la forte incidenza delle imposte indirette, si ripercoteva solo in misura limitatissima sui prezzi al minuto.
La diminuzione dei salari, già iniziata dalla classe padronale nel 1926, subì un'impennata nel 1927, quando il segretario del P.N.F. Augusto Turati rimproverò gli agricoltori d'aver reso impossibile la diminuzione dei prezzi per non essere stati capaci di ridurre le paghe dei contadini.
Immediatamente i sindacati fascisti risposero a questo monito proponendo una diminuzione del 10% delle paghe dei contadini, e innescarono così una «gara di virtù» (come la definì il Salvemini) che ebbe diffusione nazionale in tutte le categorie di lavoratori.
Il bilancio dell'operazione, portata a termine fra il 1927 e il 1931, comportò una riduzione del 16,5% dei salari industriali, una diminuzione anche più drastica dei salari dei contadini e una decurtazione del 12% degli stipendi degli impiegati statali, mentre il costo della vita subiva flessioni comparativamente irrilevanti.
Con l'inizio della grande crisi del 1929 (che studieremo più avanti nelle sue origini statunitensi), la politica economica fascista entra in una nuova fase, connotata da un sempre più massiccio intervento dello stato nelle attività produttive e finanziarie.
Poiché le banche ordinarie si trovano in gravissime difficoltà e rischiano il fallimento, nel 1931 viene fondato l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), che è finanziato dallo stato e subentra alle banche nel concedere all'industria crediti a medio e lungo termine. Ma naturalmente i crediti facilitati sono concessi dallo stato soprattutto alle grandi aziende, mentre le medie e le piccole aziende, falciate dalla crisi, falliscono o vengono riassorbite dalle concorrenti più forti. Pertanto il processo di concentrazione industriale, già in corso, subisce una forte accelerazione, resa anche più drastica da un decreto del giugno del 1932 che rende obbligatoria la fusione delle aziende quando ne facciano richiesta quegli impresari o quelle società che, in un dato ramo, forniscono il 70% della produzione complessiva. Come corollario di questa limitazione delle libertà di impresa (di impresa piccola e media, si badi, perché le grandi imprese sono in grado di determinare e di controllare le fusioni), nel gennaio del 1933 una legge subordina l'apertura di nuovi impianti e l'ampliamento dei già esistenti all'autorizzazione governativa; sicché «ogni forma di concorrenza, ogni forma di dinamismo viene a mancare, perché sono gli interessi costituiti di un determinato settore che possono cristallizzare la situazione, evitando che nuovi impianti - i quali potrebbero essere più moderni, a costi minori, e potrebbero quindi costituire un fattore dinamico nel settore - vengano in vita» (F. Grassini).
Nascono così potentissimi trust, in condizione di monopolio o di quasi monopolio, come quello delle industrie idroelettriche che riesce a tener alte le tariffe dell'energia con ovvio svantaggio della produzione globale, come quello degli zuccherieri, protetto dalle dogane, o come la Società Montecatini che, con l'appoggio dello stato, può superare la crisi e anzi si amplia e si consolida. Il processo presenta anche un aspetto positivo, perché facilita la formazione di complessi industriali di dimensioni adeguate alle esigenze della produzione più avanzata.
Nello stesso gennaio del 1933 viene fondato anche l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) che, col danaro dei contribuenti, sostiene soprattutto le industrie siderurgiche, cantieristiche e meccaniche. Complessivamente l'intervento dello stato nell'economia è così ampio che alla vigilia della seconda guerra mondiale nessun paese al mondo, ad eccezione dell'URSS, ha, proporzionalmente, un numero di aziende statizzate maggiore dell'Italia; ma con questa caratteristica: che nello stato fascista la mano pubblica viene usata in vista della difesa di interessi privati e addirittura settoriali.
Meno massicci, ma pur sempre assai rilevanti, furono gli interventi dello stato nel campo dell'agricoltura. La battaglia del grano, iniziata come abbiamo detto sin dal 1925, era rivolta a diminuire l'importazione di grano che incideva pesantemente sulla nostra bilancia commerciale. Ampiamente propagandata e sostenuta con incentivi, essa conseguì notevoli risultati, culminati nel 1933 con una produzione che copriva quasi per intero il fabbisogno nazionale (mentre nel 1922 si erano dovuti importare oltre 22 milioni di quintali di frumento).
Da un punto di vista globale, però, essa determinò la conversione alla cerealicoltura anche di terreni poco adatti, sicché il grano raggiunse sul mercato interno prezzi di molto superiori a quelli del mercato internazionale, con ovvio svantaggio immediato delle classi meno abbienti, costrette a comprimere i consumi, e con svantaggio indiretto dello sviluppo generale della produzione.
Dal 1934 Mussolini persegue l'obiettivo di rendere il più possibile autosufficiente la produzione nazionale di beni e servizi, proteggendola dalla concorrenza estera. Dai dati statistici si rileva infatti che le importazioni e le esportazioni calano notevolmente: si passa dai 26 miliardi di lire di importazioni del 1926 ai 6 miliardi del 1936, mentre le esportazioni vanno da 18,5 miliardi nel 1926 a 5,5 miliardi nel 193 (Poiché nel frattempo la politica di «quota novanta» aveva determinato una notevole rivalutazione della lira, il calo reale dell'export-import fu un po' meno vistoso; infatti le cifre soprindicate, tradotte in lire 1986, assumono questi valori approssimativi: import 1926=16000 miliardi, import 1936=5300 miliardi; export 1926=11600 miliardi; export 1936=4900 miliardi).
Soprattutto dopo la crisi economica iniziata nel 1929 il regime fascista intensificò la propaganda a favore di un aumento della produzione agricola, facilitando, attraverso alcune leggi, la vendita e il collocamento dei prodotti. Con una legge del 1932 furono infatti istituiti dei consorzi agrari, che raccoglievano i prodotti agricoli, soprattutto cereali, offrendo agli agricoltori anticipi sulle vendite e assicurando la collocazione delle derrate sul mercato. La produzione subì un reale incremento: mentre nel 1923 si producevano in Italia circa 59 milioni di quintali di frumento, nel 1933 se ne produssero 79 milioni di quintali.
In questo clima culturale e politico si inseriscono anche le iniziative di bonifica di terreni incolti e malarici per una superficie di oltre 4 milioni e mezzo di ettari.
Nel 1928 fu anche iniziato un ambizioso programma di bonifica integrale, per il quale lo stato avrebbe provveduto alle opere fondamentali (risanamento di terreni paludosi, rimboschimenti, drenaggio e controllo delle acque, rete centrale d'irrigazione) lasciando ai privati il compito di completare a proprie spese la bonifica con piantagioni, dissodamenti, costruzioni rurali, allacciamento ai canali d'irrigazione eccetera; senonché, per l'inadempienza dei proprietari, il progetto rimase in buona parte inattuato o si risolse in una serie di finanziamenti a fondo perduto a vantaggio dei grandi agrari.
Esito nettamente positivo ebbe invece la bonifica dell'Agro Pontino, che trasformò oltre 60 000 ettari di terre incolte, malariche e scarsamente popolate, fra Roma e Terracina, facendovi sorgere circa 3000 poderi, adeguatamente sistemati e attrezzati. I lavori, iniziati nel novembre del 1931, furono portati avanti alacremente secondo progetti razionali, e contribuirono fra l'altro ad alleviare la disoccupazione che, a causa della crisi, era enormemente aumentata (dai 300.000 disoccupati del 1929, si passò infatti al milione e più del 1932-33).
Allo stesso scopo, fra il 1929 e il 1934 il fascismo diede un particolare impulso ai lavori pubblici, sviluppando la rete stradale, autostradale e ferroviaria (come avveniva in tutti i paesi industrializzati per motivi meramente tecnici) e incrementando l'edilizia pubblica (municipi, poste, palazzi di giustizia, scuole) con opere di proporzioni talvolta grandiose, ma di dubbia funzionalità e di gusto monumentale e retorico.
La battaglia del grano, il ricorso a dogane protettive, la rimessa in funzione di miniere nazionali antieconomiche prefiguravano il disegno del regime di rendere l'Italia il più possibile autonoma dal punto di vista economico. Questa tendenza all'autarchia ebbe forte accentuazione a partire dal 1935, cioè dalla guerra d'Etiopia e dalle cosiddette «sanzioni» (di cui parleremo più ampiamente in seguito): d'allora in poi l'economia fu mobilitata per conseguire «il massimo possibile di autonomia soprattutto nel settore della difesa», senza alcun riguardo per i costi, che naturalmente salirono alle stelle (basti pensare che l'acciaio «autarchico» costava circa il doppio di quello del mercato internazionale). L'autarchia si spiegava in realtà solo in riferimento ai propositi imperialistici del regime, che infatti intensificò di molto le spese per gli armamenti, sostenendo così la domanda interna, falcidiata dalla compressione dei salari, e dando un'artificiosa «boccata d'ossigeno» all'economia.
Con la scelta dell'autarchia e delle spese militari il scelta fascismo si avviava alla guerra; esattamente secondo quanto era stato previsto fin dal 1926 nel documento elaborato dai comunisti a Lione, nel quale si leggeva fra l'altro: «Coronamento di tutta la propaganda ideologica, dell'azione politica ed economica del fascismo è la tendenza di esso all' "imperialismo". Questa tendenza è l'espressione del bisogno sentito dalle classi dirigenti industriali-agrarie italiane di trovare fuori del campo nazionale gli elementi per la risoluzione della crisi della società italiana. Sono in essa i germi di una guerra che verrà combattuta, in apparenza, per l'espansione italiana, ma nella quale in realtà l'Italia fascista sarà uno strumento nelle mani di uno dei gruppi imperialisti che si contendono il dominio del mondo».
Nel quadro economico-politico che abbiamo delineato le velleità mussoliniane di «andare verso il popolo» non poterono mai superare i limiti del paternalismo e della demagogia. Distrutto ogni autentico sindacalismo, infatti, la stessa legislazione sociale del fascismo fu per lo più violata nei fatti, e le proteste talvolta elevate da alcuni fascisti «di sinistra» furono messe a tacere. Il regime approvò comunque leggi che stabiliva no in otto ore la durata quotidiana del lavoro nelle aziende industriali (16 marzo 1933), che elevavano da 12 a 14 anni l'età minima per l'assunzione dei giovanissimi e imponevano norme di tutela per i lavori notturni, o pericolosi, o dannosi alla salute (26 aprile 1934), e che miglioravano le disposizioni riguardanti gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, l'invalidità e la vecchiaia.
Più autentiche cure il regime dedicò alla maternità, che fu assistita dall'Opera Nazionale per la maternità e per l'infanzia, fondata il 10 dicembre 1925. Tale assistenza rientrava nella politica demografica del fascismo, mirante ad assicurare la potenza dell'Italia attraverso l'aumento numerico dei suoi abitanti. Che il numero fosse di per sé potenza era affermazione mussoliniana priva di senso, nel mondo moderno ad alto sviluppo tecnico, e comunque implicante una volontà di guerra e di espansione, che del resto il regime non nascondeva. Per l'aumento demografico fu messa in atto tutta una serie di provvedimenti, che andavano dall'imposta sul celibato alle facilitazioni fiscali per le famiglie numerose, dalle condizioni di favore riservate ai coniugati alla premiazione delle madri prolifiche, e simili.
II regime perseguì con tenacia ossessiva la campagna per l'incremento demografico, promossa nella convinzione che una popolazione più numerosa avrebbe comportato una maggiore potenza produttiva e militare. Mussolini mise in moto a questo scopo messaggi propagandistici martellanti e di pessimo gusto, e stabilì una serie di remunerazioni economiche a chi metteva al mondo molti figli. E' proprio questo il quadro in cui fu fondata l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia.
Delle più importanti iniziative del regime nel campo della politica estera parleremo più avanti, in riferimento al contesto internazionale. Per ora ci limiteremo a fornire alcune indicazioni generiche.
Ottenuto il potere, il Mussolini dovette moderare alquanto i toni minacciosi usati negli anni precedenti per accattivarsi i consensi dei nazionalisti o, più esattamente, poté a parole continuare a sfidare l'intero mondo per dare all'interno l'impressione di una fermezza e di una forza militare che non esistevano, ma dovette, nei fatti, seguire una linea molto più prudente.
Così, per esempio, nel 1923, di fronte al veto inglese, dovette abbandonare Corfù, improvvisamente occupata dalle nostre truppe per reagire al massacro di una nostra missione militare; questa era stata aggredita in territorio greco, probabilmente da banditi, mentre, dietro incarico internazionale, procedeva alla delimitazione dei confini fra la Grecia e l'Albania.
Anche il revisionismo dei trattati di pace, contro i quali il fascismo aveva elevato le più violente proteste, dovette essere alquanto moderato dopo che il fascismo fu salito al potere: si ebbero solo alcune modeste rettifiche dei confini coloniali in Somalia e in Libia, e un nuovo accordo con la Iugoslavia, che portò all'annessione di Fiume (27 gennaio 1924), costituita in città libera dal precedente trattato di Rapallo.
In generale, mentre dal 1924 si andavano guastando i rapporti con la Iugoslavia e con la Francia, rimasero buoni, sino alla spedizione etiopica del 1935-1936, quelli con l'Inghilterra, i cui circoli conservatori vedevano pur sempre in Mussolini il provvidenziale antidoto contro il dilagare del bolscevismo.
Fu appunto l'amicizia con l'Inghilterra che indusse il fascismo a moderare, nei fatti se non nelle parole, la sua fondamentale avversione alla Società delle Nazioni, che l'Italia abbandonerà, come vedremo, solo dopo la conquista dell'Etiopia e l'accostamento alla Germania nazista.
Il rapporto di scambio fra le monete incide direttamente sulle relazioni commerciali internazionali. Illustriamo il concetto con un esempio assolutamente astratto. Posto che in Italia un paio di calze costi 5000 lire e che il cambio lira-dollaro sia 2000:1, un commerciante americano potrà acquistare quelle calze al prezzo di 2,5 dollari il paio. Se il rapporto lira-dollaro diventa 1250:1, lo stesso commerciante pagherà quelle calze 4 dollari il paio, e forse a questo nuovo prezzo l'acquisto non sarà più conveniente per lui. Se viceversa il cambio diventasse di 2500 lire contro 1 dollaro, gli basterebbero 2 dollari per acquistare un paio di calze.
 |
| Appunti su: mone del famoso sppeaker radiofonico dell eiar nel regime fascisti, |
|
| Appunti Archeologia |  |
| Tesine Astronomia cosmologia |  |
| Lezioni Aeronautica |  |