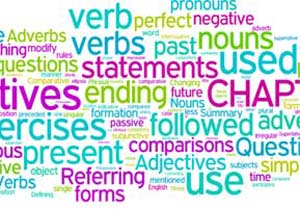SENECA
A differenza degli scrittori contemporanei, Seneca
si sforza per buona parte della vita di partecipare all'attività politica. Per
questo nelle sue opere si confronta ripetutamente con un tema da sempre
fondamentale nella cultura romana: il rapporto fra vita attiva e vita
contemplativa. Le risposte non saranno univoche; spesso, anzi, oscillanti e
perfino opposte. C'è tuttavia un principio al quale Seneca resta sempre fedele:
compito dell'uomo è rendersi utile agli altri uomini (principio fondamentale
della filosofia stoica, che discendeva da quello dell'uguaglianza umana sancita
dalla legge naturale). L'uomo virtuoso pertanto deve cercare in ogni modo di
non sottrarsi alle sue responsabilità umane e civili. Il De Clementia rappresenta il tentativo più esplicito di dar
soluzione al problema del rapporto tra principe e sudditi: il re governa lo Stato
come la mente divina regola provvidenzialmente l'universo, dunque egli deve
essere istruito e reso saggio, compito che spetta alla filosofia.
Per quanto riguarda il problema della vita
interiore, Seneca sostiene che l'esistenza umana va misurata su un piano
spirituale e morale, e che saggio è colui che si sottrae all'urgenza delle
passioni rendendosi libero e padrone di sé. La vera saggezza, cioè la libertà
interiore, implica il distacco dalle cose del mondo. Tuttavia il saggio cui
pensa Seneca non è un individuo che si pone sprezzantemente al di sopra del
mondo, ma un uomo che cerca umilmente di migliorarsi giorno dopo giorno.
Infine, sbagliano coloro che si lamentano della brevità della vita: essa è
breve solo se si fa un cattivo uso del proprio tempo. La morte, inoltre,
rappresenta il più autentico strumento di libertà concesso all'uomo, pertanto
non è da temere.
Per quanto riguarda lo stile, Seneca si allontana
dai parametri della tradizione classica utilizzando uno stile elaborato e
persino teatrale, ricco di artifici retorici.