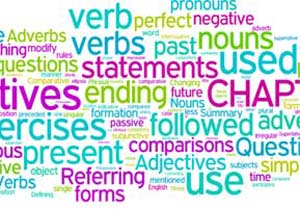La
concezione del Bello nel Neoclassicismo
Dal punto di vista filosofico, è il filosofo
illuminista Immauel Kant a dare una spiegazione molto dettagliata del
concetto di bello e del connesso concetto di sublime. Nella sua Critica del
Giudizio, infatti, Kant, analizzando il giudizio estetico riferito alla Natura,
parla del bello come qualcosa che piace senza interessi, universalmente, come
qualcosa di collegato alla finalità stessa dell'oggetto e come il soggetto di
un piacere necessario; successivamente analizza anche il concetto di sublime,
cioè un qualcosa che genera un sentimento non positivo (causato dal bello),
bensì un sentimento negativo, di attrazione e meraviglia.
Dal punto di vista artistico, si assiste ad
una ripresa dei modelli classici, con lo scopo di trarne ispirazione per lavori
del tutto nuovi; massimo teorico del nuovo gusto Neoclassico è il tedesco Johann Joachim Winckelmann, il
quale definiva il culmine dell'arte quella greca: quindi l'unico modo per
divenire grandi era imitare, cioè ispirarsi e non copiare, tali modelli. Per
Winckelmann l'opera d'arte, in particolar modo quella greca, ha due
caratteristiche: la nobile semplicità
e la quieta grandezza. Connesse a
queste affermazioni ci sono le teorie sulla rappresentazione del soggetto
nell'istante precedente o successivo l'azione, in cui la bellezza non è scossa
dalle tensioni fisiche o emotive.
Massima espressione delle teorie di
Winckelmann fu lo scultore Antonio Canova, che incarnò profondamente
nella sua opera gli ideali neoclassici. Sua opera forse più famosa è il gruppo
scultoreo Amore e Psiche, in cui
vediamo i due amanti sospesi nell'attimo immediatamente prima o, forse, appena
dopo il bacio: essi si sfiorano appena, si contemplano. Dalla visione frontale
si nota la perfetta struttura geometrica dell'opera; tuttavia è necessario
osservare l'opera da più angolazioni per apprezzare a fondo la perfezione di
questo gruppo scultoreo, impreziosito dall'uso perfetto del marmo da parte del
Canova, che attraverso un opportuno utilizzo della cera riesce a creare un
perfetto effetto di incarnato.
Proprio a Canova è dedicata una delle opere di
Ugo Foscolo, Le Grazie, dallo spiccato gusto neoclassico. Il poema è
stato composto e rielaborato dal Foscolo in vari momenti della sua vita, senza
mai giungere al completamento del progetto; in base ad esso l'opera si sarebbe
dovuta articolare in un unico inno, ma poi il Foscolo la divise in tre inni,
dedicati rispettivamente a Venere, a Vesta e a Pallade. Alla base delle Grazie,
oltre alla chiara matrice classicista, vi è il culto della bellezza, della
quale le Grazie sono la rappresentazione allegorica. Nel verso vi è anche la
ricerca di ciò che il poeta stesso chiama "melodia pittrice", in particolare nell'elaborazione
di un verso di grande musicalità che trasmetta anche suggestioni visive.
Inoltre è da notare anche in quest'opera del Foscolo un intento civile della
poesia: infatti è idoleggiata la bellezza come mezzo di fuga da un presente
straziato dalle guerre napoleoniche.