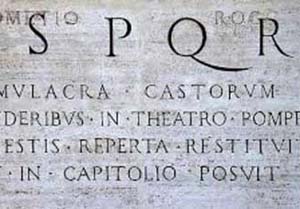PETRONIO
Nulla sappiamo di
certo a proposito di Petronio, non esistono elementi oggettivi per stabilire
l'età in cui visse né con tutta sicurezza si può identificare il Petronio di
cui parla Tacito con l'autore del Satyricon.
Tacito parla di Petronio in termini molto chiari: di giorno riposava, di notte
si dedicava alle occupazioni e ai piaceri. La sua trascuratezza ostentata gli
procurò non poche simpatie; eppure seppe governare la Bitinia con gran dignità;
quando lasciò le cariche, fu accolto tra i pochi intimi di Nerone, che lo
considerò arbitro del buon gusto. Tutto ciò suscitò l'invidia del potente
Tigellino: Petronio fu accusato di essere compartecipe della congiura di
Pisone. Non riuscendo a tollerare l'ansia per il giudizio del Principe,
Petronio scelse la morte: si fece tagliare le vene e intanto discuteva con gli
amici di frivolezze. Nel suo testamento non adulò nessuno anzi compilò un
elenco dettagliato delle depravazioni di Nerone e fece tutti i nomi delle
amanti e degli amanti del Principe.
SATYRICON
Da ciò che scrive
Tacito, possiamo identificare Petronio con l'autore del Satyricon. L'opera non segue un preciso genere letterario, ma è una
parodia del genere romanzo greco. Petronio sostituisce alla coppia del romanzo
greco una coppia omosessuale, formata da Encolpio e Gitone; i due sono
accompagnati, durante un lungo viaggio in cerca di avventure per lo più
erotiche, da Ascilto e da Eumolpo. La vicenda è ambientata dapprima a
Marsiglia, poi a Napoli e infine a Crotone. A parte la scelta di una coppia
omosessuale, l'elemento parodico va ricercato sia nella mancanza di serietà e
di moralità dei personaggi sia nell'assenza della benché minima castità nelle
vicende narrate.
Il racconto ha
inizio nella scuola di un retore, Agamennone: qui Encolpio, che è in viaggio
con Gitone e con Ascilto, discute con Agamennone sulla decadenza dell'arte del
dire. Appena più tardi, Encolpio e Ascilto sono al mercato, dove riescono a
sbarazzarsi di un mantello rubato e a ritrovare la tunica che era stata loro
sottratta e che conteneva il loro gruzzolo. Rientrati in albergo i tre ricevono
l'invito per una cerimonia in cui bisogna placare l'ira del dio Priapo; ma
dalla cerimonia troppo lunga i tre riescono a svignarsela grazie al servo di
Agamennone, che giunge per annunziare che sono stati invitati a cena da
Trimalchione, un liberto arricchito. La cena procede tra il susseguirsi delle
portate e il vino abbondante, che fa cadere il padrone di casa nell'ebbrezza e
subito dopo nella tristezza: i discorsi vertono ora sulla morte e Trimalchione
legge il suo testamento. Segue una gran confusione, approfittando della quale
il terzetto se la dà a gambe. Nella parte successiva Encolpio rimane solo e in
una pinacoteca incontra Eumolpo; insieme visitano la pinacoteca e discutono
sulla decadenza delle arti. Poco dopo ricompaiono Gitone e Ascilto. La
narrazione procede attraverso altre avventure fin quando il gruppo si imbarca
sulla nave di Lica e di Trifena, due coniugi dissoluti. In seguito a una
tempesta la nave viene spinta sulle coste di Crotone: qui Encolpio si innamora
di Circe, una bella fanciulla che non riesce a conquistare per l'ostinata ira
di Priapo. L'ultima parte dell'opera tratta della guerra civile tra Cesare e
Pompeo.
Dal punto di vista
strutturale e stilistico il Satyricon costituisce un vero e proprio caso
letterario: l'opera non può essere facilmente classificata all'interno dei
generi tradizionali. In precedenza abbiamo sostenuto che potrebbe trattarsi di
una parodia del genere romanzo, ma, in effetti, il Satyricon appare come
un'opera composita che possiede alcuni elementi sia della Fabula Milesia sia
della Satura Menippea: della fabula presenta il carattere licenzioso ed
erotico; della satura utilizza essenzialmente la forma, una mistione di prosa e
di versi. Petronio presenta e ritrae un mondo corrotto, popolato da personaggi
anonimi e squallidi, che traggono soddisfazione solo dai piaceri più immediati
ed essenziali. In essa è presente un'analisi di tipo estetico: ciò si evince
dalla I e dalla II parte in cui si discute della decadenza dell'arte del dire,
e della decadenza delle arti. Anche la lingua di Petronio è un fatto composito:
l'autore sa servirsi, a seconda delle situazioni, di tutti i registri
linguistici.
LATINO CLASSICO: NOTIZIE SU DUE TERREMOTI di Plinio il
Vecchio