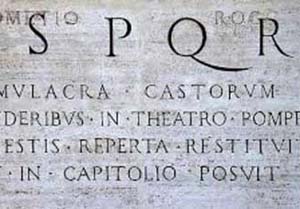COMMEDIE
Plauto è il primo poeta latino a dedicarsi
interamente ad un solo genere teatrale: scrive solo palliate. Egli imita, cioè,
traduce, rielabora o riadatta copioni attici della Commedia nuova: Menandro,
Difilo, Filemone e altri (IV-III sec. a.C.).
La sua attività si svolge in un arco
di tempo che va, all'incirca, dalla ripresa delle ostilità con Cartagine (218,
inizio della seconda guerra punica) ad un momento compreso tra il 186 (nella
commedia intitolata Cosina si allude
al senatusconsultum de Bocchonalibus, che
in quell'anno vietò il culto di Dioniso) e la morte, avvenuta nel 184.
Già nel II secolo a.C. circolavano
sotto il nome di Plauto ben centotrenta commedie. Il dibattito sulla loro
autenticità fu uno dei primi affrontati dalla nascente filologia latina: liste
di commedie da ritenersi genuine proposero, ad esempio, il grammatico Elio
Stilone (famoso anche per aver sostenuto che «se le Muse avessero parlato in
latino, lo avrebbero fatto con la voce di Plauto»), il tragediografo Accio, che
fu anche un filologo e uno storico del teatro, e molti a1tri. Ma l'intervento
decisivo fu quello del reatino Marco Terenzio Varrone (116-127 a.C.), che
stabilì la lista, divenuta poi canonica, delle ventuno commedie sicuramente
genuine: a esse Varrone aggiungeva un'altra ventina di dubbie, cioè di incerta
o solo parziale plautinità.
Il prestigio di Varrone fece sì che
le ventuno, dette appunto «varroniane», si imponessero sulle altre. Nel I
secolo d.C. si leggevano ancora commedie non incluse nelle varroniane, ma nel
II secolo si leggevano ormai solo le varroniane. Queste, raccolte nel IV e V
secolo su singoli rotoli di papiro ma tutte di seguito in uno stesso codice di
pergamena, poterono giungere sino a noi pressoché integre - ad eccezione
dell'ultima, la Vidularia,
di cui rimangono solo un centinaio di versi frammentari, e di qualche
lacuna in Amphitruo, Aulularia,
Bacchides, Casina.
Sulla cronologia
delle commedie è possibile dire ben poco. Alla prima fase della produzione
plautina, coincidente con gli anni della seconda guerra punica (218-201), nei
quali l'unica occasione per spettacoli teatrali era offerta dai ludi Romani (15-18 settembre), appartengono
probabilmente l'Asinaria e il Mi]es g]oriosus (qui, un'allusione al
poeta Nevio prigioniero rinvia agli ultimi anni di guerra), forse anche la Cistellaria e il Mercator. A partire dal 200 a.C. le occasioni teatrali si
moltiplicano: in quell'anno vengono resi scenici, cioè aperti alle
rappresentazioni, i ludi plebeii (15
novembre), e Plauto, come si ricava dalla «didascalia» della commedia (cioè
dalla notizia coi dati essenziali: autore, titolo, festività e magistrati ad
essa preposti, capocomico), vi figurò con lo Stichus: inaugurando la seconda fase, quella postbellica, della
propria produzione, nella quale rientrano le restanti quindici varroniane.
Anche dello Pseudolus s'è conservata
una breve didascalia, che colloca la commedia nei Megalenses del 191: questi ludi
erano stati resi scenici nel 194. Per una serie di allusioni in esse
contenute, è probabile che cadano in epoca posteriore, cioè negli ultimi anni
del poeta, l'Amphitruo, le Bacchides, il Persa, il Trinummus e la Casina (185-184).