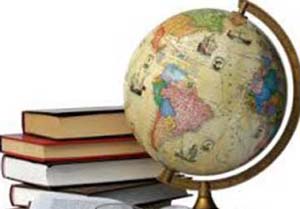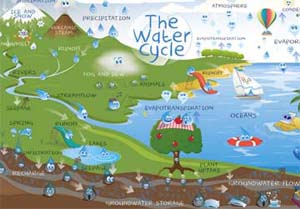Globalizzazione, un fenomeno contrastabile
Globalizzazione.
Una parola usata molto spesso, specie negli ultimi tempi, che trova ormai ampio
spazio su giornali, libri, trasmissioni televisive. ma al di là del prendere
atto delle sempre più frequenti manifestazioni anti-globalizzazione e del
cercare lo scoop giornalistico con immagini shock che documentino gli scontri
di piazza (Seattle, Davos, Napoli.), qualcuno si è preoccupato di spiegarci
cosa sia veramente questa famigerata globalizzazione dell'economia, chi
coinvolga, quali siano i suoi pregi e difetti? E' solo un fattore che coinvolge
gli addetti ai lavori del mondo economico ed amministrativo o colpisce anche
noi? Cerchiamo di fare un po' di chiarimento, di comprendere realmente di cosa
si tratti e del perché ci tocchi da vicino in quanto cittadini del mondo.
Partiamo
innanzitutto con l'individuazione dei soggetti interessati dalla
globalizzazione, che sono imprese, governi e popolazioni. E diciamo pure che la
globalizzazione è sinonimo di mondializzazione, quindi essa è stata favorita
dall'enorme progresso nel campo delle telecomunicazioni, dall'evoluzione del
settore dei trasporti e dall'enorme accrescimento dell'importanza della
telematica, verificatisi soprattutto nell'ultimo decennio. Può aiutarci questo
a comprendere? Certamente sì, dato che grazie a tutti questi progressi il mondo
è "diventato più piccolo", con sempre maggiore facilità è possibile mettersi in
contatto con persone che magari vivono dall'altra parte del mondo e scambiarsi
informazioni; ma cosa più importante ancora, riguardante l'aspetto economico, è
la possibilità di scambiare dati ad una velocità impressionante da un angolo
all'altro del pianeta, con un conseguente enorme vantaggio per le grandi
imprese dislocate su più luoghi. La direzione aziendale si è scorporata ed è
stato possibile impiantare sedi distaccate in siti prima impensabili, il
collegamento con l' "unità madre" è stato garantito dalla telematica e quindi
dal progredire delle reti informatiche. Ed ecco il primo punto da fissare:
grazie a questo dislocamento e decentramento produttivo, sono le grandi imprese
multinazionali a diventare le più importanti protagoniste dell'economia
globale; infatti, per queste imprese è possibile essere presenti in territori
in cui il mercato del lavoro è a loro favorevole, grazie soprattutto a bassi
costi del lavoro e limitata forza delle organizzazioni sindacali. Ecco quindi
avanzare il predominio mondiale del capitalismo industriale avanzato, ecco
quindi avanzare una nuova forma di colonialismo atta ad esportare un modello
puramente occidentale e filo-statunitense in paesi meno sviluppati e spesso
incapaci di assimilare tali modelli. Se è vero che per molti paesi prima
esclusi dall'industrializzazione la mondializzazione dell'economia vuol dire
trovare uno sbocco nel mercato mondiale, ciò porta anche ad una radicale
modificazione del mercato del lavoro, che si attua principalmente secondo due
percorsi: da una parte nei paesi di antica industrializzazione il numero dei
disoccupati tende a crescere, dall'altra i flussi migratori, favoriti
dall'enorme evoluzione del sistema dei trasporti, si intensificano portando ad
ovvie tensioni sociali ed a fenomeni di razzismo e di incomprensione culturale.
Chiariamo però un nodo fondamentale: la globalizzazione dell'economia ha potuto
attecchire specialmente in determinati paesi per tutta una serie di cause.
Innanzitutto, la maggior parte di questi paesi è ex-coloniale e quindi molto
spesso caratterizzata da condizioni economiche abbastanza disastrose: questo è
un fattore molto importante, in quanto spesso in questi paesi l'arrivo di
capitali stranieri è visto come la possibilità di risollevare l'economia
nazionale; inoltre, per alcuni di questi paesi l'arrivo di capitalisti
occidentali non è visto come un pericolo o un problema, perché abituati appunto
alla dominazione straniera in quanto una volta colonie. E allora, quali sono
gli svantaggi per queste popolazioni? Innanzitutto il basso livello dei redditi
porta ad una situazione economica stagnante. Sempre più spesso i governi dei
paesi in via di sviluppo tengono ad attuare politiche del mercato del lavoro
che mirino a tenere basso il costo della manodopera per favorire l'afflusso di
imprese straniere. Tale livello dei redditi non consente alcuna possibilità di
risparmio o investimento, con un conseguente rallentamento della crescita
economica; l'importazione di moderne tecniche produttive determina poi il
ridursi dell'impiego di forza lavoro locale, le scarse capacità manageriali e
l'insufficiente preparazione dei lavoratori fanno il resto riducendo le imprese
nazionali ad un ruolo puramente marginale e di spettatore inerme di fronte allo
strapotere delle multinazionali. Alla crisi delle imprese nazionali
contribuisce anche un aspetto psicologico: l'immagine dell'impresa
multinazionale è spesso per le popolazioni dotate di scarse conoscenza e bassa
cultura l'immagine di un lavoro stabile, sicuro e ben retribuito. Nodo cruciale
è anche la scarsissima potenza contrattuale dei sindacati: se, soprattutto in
Europa, le lotte sindacali hanno portato ad un deciso miglioramento delle
condizioni dei salariati, nei paesi sottosviluppati la mancanza di forti
organizzazioni che riunissero i lavoratori ha fortemente condizionato la loro
possibilità di far valere le proprie ragioni. Le grandi imprese multinazionali
hanno tutto l'interesse che la situazione rimanga tale, in modo da non dover
fare fronte a lunghe vertenze per il rinnovo dei contratti: la filosofia
aziendale messa in atto è sempre stata quella di far accettare passivamente ai
lavoratori qualsiasi condizione, dietro la minaccia non molto velata del
licenziamento. Il lavoratore, trovandosi già in situazione economica precaria,
preferisce accettare in silenzio tutto ciò che gli viene imposto dall'alto
piuttosto che perdere l'impiego.
I sostenitori della
globalizzazione ritengono che l'esportazione del modello economico occidentale
non possa che giovare alle popolazioni dei paesi sottosviluppati, in quanto
apporta un miglioramento delle condizioni di vita ed appaga il loro desiderio
di ricchezza e prosperità. Sono però le stesse persone che ammettono che questo
progresso è ottenuto attraverso condizioni di lavoro e di vita precarie: si può
quindi parlare di vero e proprio progresso? Evidentemente no, anche perché chi
cerca di far passare la mondializzazione dell'economia sotto le mentite spoglie
dell'aiuto a popolazioni più povere, mente spudoratamente. Tutto è subordinato
al pensiero unico del profitto, le multinazionali sono ben lontane
dall'intenzione di promuovere l'uso ottimale delle risorse materiali,
immateriali e delle risorse umane dei paesi meno avanzati; il soddisfacimento
dei bisogni della collettività non è l'obiettivo principale della politica
economica dei paesi più industrializzati, che hanno tutto l'interesse di
mantenere la periferia del mondo nelle condizioni attuali, cioè scarsamente
consapevole delle proprie possibilità e privata di alcun mezzo per opporsi alle
logiche del mercato globale. Su scala mondiale le grandi decisioni, le priorità
economiche e sociali, vengono stabilite da grandi lobbies corporative (Banca
Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, World Trade Organization, OCSE) e
vengono dettate sotto forma di "raccomandazioni" ai governi, nelle cui mani
restano ancora formalmente le politiche di distribuzione del reddito, ma che
sempre più spesso si trovano ridotti ad un ruolo esecutori materiali degli
interessi del capitale transnazionale. La stessa forma stato è quindi
attraversata da profonde mutazioni che ne valorizzano il ruolo di 'agenzia
di servizi' per gli interessi dell'impresa ed efficace garante dell'ordine
sociale. Una delle grandi caratteristiche della globalizzazione è quindi il
passaggio da governi nazionali a governi transnazionali, controllati però dagli
interessi delle grandi organizzazioni del commercio e della proliferazione
economica. Ovviamente la globalizzazione dell'economia non porta a conseguenze
solo in termini di denaro, ma investe moltissimi altri campi. La
precarizzazione nelle condizioni di vita e di lavoro aumenta mentre cala
progressivamente il potere d'acquisto dei salari, il sistema formativo come
quello sanitario vengono sempre più ristrutturati secondo un'ottica
aziendalista che non lascia spazio al pensiero critico e ai bisogni sociali.
Soprattutto nelle aree rurali assistiamo ad un accrescersi delle situazioni
critiche: i sistemi agrari tradizionali vengono smantellati e soppiantati da
tecniche agricole moderne e spesso inadatte all'ambiente nel quale vengono
importate, con conseguenti problemi di ordine ambientale e sanitario. La
crescita del lavoro nero è stata esponenziale negli ultimi anni: il lavoro
sottratto a qualsiasi controllo da parte delle autorità statali è una ottima
fonte di guadagno per i capitalisti stranieri che lo sfruttano soprattutto per
il piccolo artigianato tessile e meccanico. Le aree urbane risentono molto dei
flussi migratori e ciò porta a enormi squilibri soprattutto a causa della
formazione di vastissime "baraccopoli" alle periferie delle metropoli. Le
scarse condizioni sanitarie colpiscono in maggior parte gli strati più deboli
della popolazione come anziani e bambini: malnutrizione e mortalità infantile
crescono ad un ritmo vertiginoso di pari passo con la diffusione di malattie ed
epidemie. Ma il problema più grande portato dalla globalizzazione è quello di
aumentare il divario tra la parte ricca e la parte povera della popolazione,
creando una disparità enorme di condizioni: i ceti più alti possono accedere ai
servizi essenziali, mentre i ceti bassi ne rimangono esclusi e sono costretti a
sopravvivere in condizioni di vita disastrate; si tratta di un fenomeno in
forte crescita non solo nei paesi sottosviluppati, bensì anche nei paesi
evoluti, dove la differenza tra ricchi e poveri è continua fonte di contrasto
sociale.
Ma allora, ci sono
solo problemi o la globalizzazione porta anche dei vantaggi? I benefici ci
sono, ma sono a stretto appannaggio delle imprese multinazionali e degli stati
che le sostengono: la gestione finanziaria comune permette la riduzione e la
frammentazione dei rischi imprenditoriali, consentendo così di convogliare
secondo convenienza i profitti verso l'una o l'altra sede dislocata nel mondo;
l'aggiramento delle barriere doganali e l'incremento delle vendite portato
dall'inserimento su nuovi mercati permette lo smaltimento delle eccedenze; gli
aiuti economici forniti ai governi dei paesi sottosviluppati permettono
l'aggiramento di talune norme che normalmente non permetterebbero l'esercizio
di determinate attività. Quindi, possiamo tranquillamente convenire che, se le
imprese multinazionali si presentano come portatrici di benessere e libertà per
i lavoratori, sono invece portatrici di gravi problematiche e squilibri, non
solo sul piano economico, bensì anche sul piano culturale e sociale. Se è vero
che da un lato la popolazione può contare su redditi più alti, dall'altro
bisogna calcolare il prezzo pagato dai salariati in termini di precarietà e
rispetto dei diritti umani: francamente, questo prezzo è eccessivo.
Ma siamo sicuri che
gli svantaggi della globalizzazione riguardino solo ed esclusivamente i paesi
meno sviluppati? Non siamo anche noi soggetti di questo grande meccanismo? Lo
siamo eccome, soprattutto per quanto riguarda il paino culturale. Dire che noi
europei siamo influenzati eccessivamente dalla cultura statunitense non è una
presa di posizione politica, bensì il prendere atto di una realtà persistente
ormai da decenni. L'inizio dell'egemonia degli Stati Uniti nei confronti
dell'Europa può essere individuato con l'istituzione del piano Marshall di aiuti
agli stati europei distrutti dopo la seconda guerra mondiale; da quel momento
in poi, l'influenza culturale economica, politica e culturale americana si è
fatta sempre più strada, riuscendo a provocare profonde trasformazioni nel
nostro modello di vita. La cultura dominante è la cultura
scientifico-tecnologica avanzata, portata avanti da decenni dagli Stati Uniti,
incentrata molto spesso sulla produzione di beni effimeri; i concetti di
flessibilità, di lavoro temporaneo fino a pochi anni fa sconosciuti in Europa
sono stati importati e se potevano funzionare nel paese di origine, perché
ormai radicati da tempo immemorabile, trovano difficoltà ad evolversi da noi,
abituati a forme di lavoro fisso e stabile; la "new economy" è un concetto di
evoluzione economica e tecnologica prettamente statunitense favorito da uno
strumento di comunicazione di massa di proporzioni enormi, Internet, che può
rivelarsi un'arma a doppio taglio: da un lato crea nuova occupazione e
l'accrescimento del livello dei redditi, dall'altro però svilisce e svuota
completamente il ruolo fondamentale della rete come mezzo di comunicazione per
assoggettarla a logiche di mercato; inoltre la cultura europea è sempre stata
orientata verso lo stato sociale, assistenziale, radicalmente rifiutato dal
modello nordamericano, incentrato anche nei settori della sanità e
dell'istruzione sulle logiche del profitto. IL "sogno americano" ha portato un
profondo sconvolgimento nella cultura europea e nelle aree gravitanti attorno
agli Stati Uniti: basti pensare all'impianto di imprese americane in Messico o
nel sudamerica. Ovviamente la globalizzazione economica non è a stretto
appannaggio dei soli Stati Uniti, ma è messa in atto anche da altri paesi
fortemente industrializzati e caratterizzati da un'economia fortemente
capitalista quali il Giappone e molti altri paesi europei.
E' possibile uscire
dalla globalizzazione, e ciò non vuol dire rimanere esclusi perché scarsamente
redditizi. E' possibile pensare ad altri modelli di cooperazione internazionale
e di mondializzazione, è quindi attuabile un "cambiamento" della
globalizzazione. Non basta aiutare i paesi meno sviluppati fornendo loro aiuti
in denaro o dotandoli delle attrezzature che consentano una crescita economica
e della produzione: sarà un circolo vizioso, perché tali paesi, privi delle
conoscenze specifiche e di una mentalità imprenditoriale, continueranno a
mantenersi in uno stadio di sviluppo bassissimo e continueranno ad indebitarsi
con il mondo occidentale. Piuttosto che regalare un aratro e basta, pensando di
aver fatto una buona azione, bisogna insegnare alle popolazioni come usarlo,
come ottimizzare la produzione ottenuta grazie all'aratro e come produrne un
altro. Tale principio è attuabile solo mediante un interessamento concreto e
disinteressato da parte dei paesi sviluppati, che non sia dettato da logiche di
profitto, ma che sia realmente volto al progredire economico,
all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse materiali, immateriali e della
forza lavoro. L'obiettivo principale deve quindi diventare il soddisfacimento
dei bisogni della collettività, senza opere di "missionarismo" rivolte ad un
mutamento culturale, degli usi e dei costumi dei paesi meno avanzati: tali
obiettivi sono perseguibili solo grazie ad una effettiva presenza sul territorio,
senza che ciò limiti in alcun modo la sovranità nazionale. Deve piuttosto
verificarsi una vera e propria integrazione non degli usi locali con quelli
importati, bensì al contrario: nella loro opera di "insegnamento" gli inviati
occidentali devono sapersi adattare alle realtà locali senza cercare di
sconvolgerle, anzi cercando un'armoniosa pacificazione e collaborazione. Il
tutto nel totale rispetto dei diritti umani: non devono più essere tollerate
tecniche invasive sottratte ad ogni forma di controllo democratico che
prefigurino nuove frontiere nello sfruttamento dell'uomo e dell'ambiente e che
intacchino la coscienza intellettuale. L'oppressione e lo sfruttamento, di
qualsiasi natura siano, vanno eliminate per permettere l'effettiva ripresa economica
di questi paesi e lo scongiuramento di un nuovo colonialismo dettato da logiche
di profitto. Alla globalizzazione "totale" e "cieca" va sostituita una
globalizzazione "intelligente" che tenga conto delle diversità tra i singoli
paesi e le singole popolazioni, delle diverse impostazioni culturali e delle
concretezze locali, agendo di conseguenza. Le decisioni non possono essere più
esclusiva competenza di poche "elites", devono essere i popoli, debitamente
forniti delle conoscenze adatte e dei mezzi necessari, a poter decidere in
autonomia ed in piena coscienza il proprio cammino.