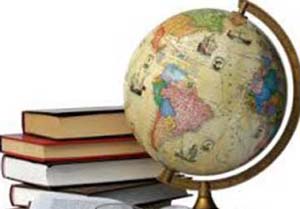La deflessione dei raggi luminosi
La prima verifica sperimentale della
deflessione dei raggi luminosi da parte di campi gravitazionali venne
effettuata nel 1919 da parte della Royal Astronomical Society. Questa
organizzò, nonostante la guerra e le ristrettezze economiche, una spedizione
proposta e diretta da Eddington durante
un'eclissi totale perfettamente visibile dall'isola di Principe, isolotto
portoghese situato a largo delle coste occidentali dell'Africa. L'intento era
quello di sfruttare l'oscuramento del Sole per vedere una stella che secondo la
meccanica classica in quel dato giorno avrebbe dovuto essere coperta dal nostro
astro. Se si fosse riusciti a vedere tale stella avrebbe significato che
qualcosa aveva deviato la sua luce, facendole compiere un tragitto non previsto
da Newton ma previsto da Einstein. Questi infatti sosteneva che:
"Un raggio di luce deve subire un
incurvamento del suo percorso allorché passa attraverso un campo
gravitazionale, incurvamento simile a quello subito dal percorso di un corpo
che sia proiettato attraverso un campo gravitazionale."
 Il riscontro di tale curvatura avrebbe
sancito l'effettiva esistenza di un
incurvamento dello spazio tempo causato da una massa, per l'appunto quella del
Sole. Ma dal momento che la luce da questo emessa non avrebbe permesso di
individuare quella più flebile di un stella posta molto vicino alla sua corona,
l'unica occasione sfruttabile era quella dell'eclisse. In realtà la stessa registrazione fotografica non fu semplice, in quanto le deviazioni relative
che ci si poteva attendere fra le fotografie prese durante l'eclisse e le
fotografie di confronto, ammontavano soltanto a pochi centesimi di millimetri.
Era dunque necessaria una grandissima precisione nell'eseguire queste
fotografie e nel compiere le successive misurazione su di esse. Nonostante
tutto, i risultati di queste misurazioni confermarono la teoria in modo del
tutto soddisfacente per l'epoca.
Il riscontro di tale curvatura avrebbe
sancito l'effettiva esistenza di un
incurvamento dello spazio tempo causato da una massa, per l'appunto quella del
Sole. Ma dal momento che la luce da questo emessa non avrebbe permesso di
individuare quella più flebile di un stella posta molto vicino alla sua corona,
l'unica occasione sfruttabile era quella dell'eclisse. In realtà la stessa registrazione fotografica non fu semplice, in quanto le deviazioni relative
che ci si poteva attendere fra le fotografie prese durante l'eclisse e le
fotografie di confronto, ammontavano soltanto a pochi centesimi di millimetri.
Era dunque necessaria una grandissima precisione nell'eseguire queste
fotografie e nel compiere le successive misurazione su di esse. Nonostante
tutto, i risultati di queste misurazioni confermarono la teoria in modo del
tutto soddisfacente per l'epoca.
Oggi in realtà non è più accettabile tale
esperimento a dimostrazione della relatività generale in quanto i fotoni
luminosi venivano sì deviati dal Sole della quantità prevista dalle equazioni,
ma le osservazioni avevano un errore
medio dello stesso ordine di grandezza dell'effetto considerato. La prima vera
conferma, invece, fu la spiegazione del moto di precessione del perielio di Mercurio,
inspiegabile con la gravitazione Newtoniana, ma previsto dalla relatività
generale.


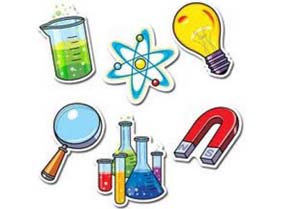

 Il riscontro di tale curvatura avrebbe
sancito l'effettiva esistenza di un
incurvamento dello spazio tempo causato da una massa, per l'appunto quella del
Sole. Ma dal momento che la luce da questo emessa non avrebbe permesso di
individuare quella più flebile di un stella posta molto vicino alla sua corona,
l'unica occasione sfruttabile era quella dell'eclisse. In realtà la stessa registrazione fotografica non fu semplice, in quanto le deviazioni relative
che ci si poteva attendere fra le fotografie prese durante l'eclisse e le
fotografie di confronto, ammontavano soltanto a pochi centesimi di millimetri.
Era dunque necessaria una grandissima precisione nell'eseguire queste
fotografie e nel compiere le successive misurazione su di esse. Nonostante
tutto, i risultati di queste misurazioni confermarono la teoria in modo del
tutto soddisfacente per l'epoca.
Il riscontro di tale curvatura avrebbe
sancito l'effettiva esistenza di un
incurvamento dello spazio tempo causato da una massa, per l'appunto quella del
Sole. Ma dal momento che la luce da questo emessa non avrebbe permesso di
individuare quella più flebile di un stella posta molto vicino alla sua corona,
l'unica occasione sfruttabile era quella dell'eclisse. In realtà la stessa registrazione fotografica non fu semplice, in quanto le deviazioni relative
che ci si poteva attendere fra le fotografie prese durante l'eclisse e le
fotografie di confronto, ammontavano soltanto a pochi centesimi di millimetri.
Era dunque necessaria una grandissima precisione nell'eseguire queste
fotografie e nel compiere le successive misurazione su di esse. Nonostante
tutto, i risultati di queste misurazioni confermarono la teoria in modo del
tutto soddisfacente per l'epoca.