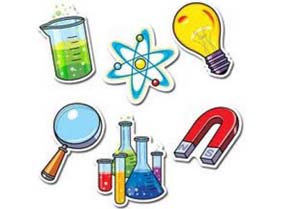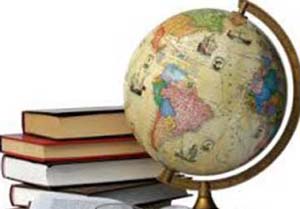Cenni
storici circa la teoria della luce
Nella seconda metà
del XVII secolo la Fisica era dominata da due grandi personaggi: Isaac Newton fig.(2-a) e l'astronomo olandese
Christian Huygens fig.(4-a). Quest'ultimo ipotizzò che la luce si propagasse
come un'onda pura e semplice e che tutte le sue proprietà osservabili, come ad
esempio la sua deviazione in presenza di un corpo materiale, derivassero da
fenomeni di interferenza distruttiva o costruttiva.
Più complessa era
invece la concezione newtoniana dei fenomeni luminosi. Lo scienziato Inglese
era infatti un atomista e nel "l'Ottica", il suo trattato sulla natura della
luce, scrisse: "Mi sembra probabile che
Dio al principio abbia dato alla materia forma di particelle solide, massicce,
dure, e impenetrabili, talmente dure da non logorarsi né frantumarsi mai,
poiché nessuna potenza ordinaria è capace di dividere ciò che Dio ha reso uno
fin dalla prima creazione".
Dunque sarebbe
stato naturale per Newton supporre che anche la luce fosse costituita da
particelle materiali che si muovessero in linea retta. Erano presenti, però,
alcuni fenomeni, quali ad esempio la diffrazione, che rendevano questa teoria
particellare della luce molto difficile da sostenere, persino la spiegazione fornita
dallo stesso Newton è molto complessa ed artificiosa.
Fino al XIX secolo,
quindi, gli scienziati sono rimasti divisi e schierati, chi dalla parte della
teoria ondulatoria chi dalla parte di quella corpuscolare. Nell'800 un giovane
di nome Thomas Young, nato nel 1773, pubblicò alcuni articoli sulla natura
della luce analizzando proprio il fenomeno della diffrazione. Dopo molte
verifiche sperimentali la maggioranza dei fisici abbandonò la teoria
corpuscolare in favore di quella ondulatoria nel momento in cui gli esperimenti
di Young furono realizzati anche da altri scienziati i quali ne convalidarono i risultati. Nel 1868 anche un
altro illustre fisico, James Clerk Maxwell, aveva pubblicato un lavoro sulla
natura della luce nel quale quest'ultima era descritta come un'onda
elettromagnetica trasversale, composta, quindi, da una natura di tipo elettrico
e da una di tipo magnetico, che si propagava nell'Etere. Fu solamente Albert
Einstein nel 1905 a
pubblicare un trattato nel quale sanciva la doppia natura della luce come
fenomeno sia corpuscolare che elettromagnetico. Per fare questo dovette però
abbattere la comoda convenzione dell'esistenza dell'Etere.