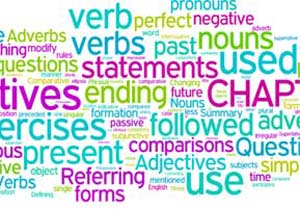VOLTAIRE
(pseudonimo di Francois Marie Arouet)
Scrittore e filosofo francese (Parigi 1694-1778). Ultimo dei cinque
figli di un notaio parigino, a sette anni perdette la madre. Dal 1704 al 1711
studiò presso i gesuiti, dando prova di un ingegno precocissimo. In seguito fu
introdotto dal suo padrino nella società parigina, che il giovane conquistò col
suo spirito mordace e brillante. Preoccupato per questi successi sospetti, il
padre, uomo pio e all'antica, cercò di avviarlo all'avvocatura e poi alla carriera
diplomatica, ma dovette farlo rientrare subito dall'Aia, per tagliare corto a
un'avventura amorosa. Alcuni versi irriverenti, diretti in particolare contro
il reggente Filippo d'Orléans, costarono al giovane Arouet prima soggiorni
forzati presso castelli di influenti protettori e poi addirittura un anno di
detenzione alla Bastiglia (1717-1718). Il successo dell'Edipo, rappresentato
nel 1718, e del poema La Lega (1723), nel quale ultimo l'imprudente autore
esaltava i protagonisti protestanti delle guerre di religione, gli procurò
protezioni e pensioni, ma anche nuove inimicizie di potenti. Arricchitosi
frattanto attraverso speculazioni fortunate e ormai noto col nome di Voltaire
(anagramma di Arouet le Jeune), lo scrittore incorse nelle ire del cavaliere di
Rohan, offeso dai suoi sarcasmi. Il nobile lo fece bastonare dai servi, gli
rifiutò la riparazione in duello e riuscì a farlo rinchiudere di nuovo nella
Bastiglia (1726). Voltaire ottenne la liberazione solo a patto di andare in
esilio in Inghilterra, dove rimase tre anni (1726-1728). Il soggiorno inglese
fu un periodo di fondamentale importanza nella formazione di Voltaire, che
respirò a pieni polmoni l'aria di libertà intellettuale e politica e frequentò
filosofi come Berkeley e Clarke e scrittori quali Swift, Pope, Gay e Young. Il
frutto più diretto di quelle esperienze furono le Lettere filosofiche o Lettere
sugli Inglesi pubblicate in inglese nel 1733 e in francese nel 1734, attraverso
le quali il vento d'oltre Manica entrò con forza sconvolgente nella Francia
dell'assolutismo monarchico e della filosofia cartesiana. Il periodo
immediatamente successivo al ritorno dall'Inghilterra e gli anni trascorsi a
Cirey, ospite della sua amante marchesa du Chatelet, videro Voltaire impegnato
in un'attività intellettuale intensissima. Pubblicò poemi, fra cui la
Enriade(1728), nuova versione della Lega, opere storiografiche (la Storia di
Carlo XII è del 1731), e fece rappresentare con successo numerose tragedie,
quali Zaira(1732), La morte di Cesare (1735), Alzira (1736), Maometto ovvero Il
fanatismo (1741), Merope(1743). Nel 1745 fu ricevuto a corte dal re e l'anno
seguente fu accolto fra gli 'immortali' dell'Accademia. La morte
della marchesa du Chatelet (1749) e la stima tiepida e condizionata del re e della
Pompadour lo indussero in seguito ad accettare l'invito del re di Prussia
Federico II, presso il quale visse tre anni (1750-1753). Alla corte del
'Salomone del Nord' portò a termine, fra l'altro, il Secolo di Luigi
XIV (1751) e scrisse il racconto Micromega (1752). Venne poi l'urto fra le due
forti personalità e alla rottura definitiva contribuì anche l'inimicizia del
Maupertuis, fatto dal re presidente dell'Accademia di Berlino e ferito da
Voltaire con gli strali velenosi della Diatriba del Dottore Akakia medico del
papa (v. AKAKIA). Tornato non senza difficoltà dalla Prussia, il filosofo si
stabilì nel territorio di Ginevra (1755), dove aveva comperato la tenuta detta
'Les Délices'. Uscirono in quegli anni La pulzella (1755), il Poema
del disastro di Lisbona (1756), il Saggio sui costumi e lo spirito delle
nazioni (1756). La simpatia dimostrata in questo ultimo scritto per Miguel
Servet, il dissidente fatto bruciare da Calvino a Ginevra, gli fece conoscere
una Svizzera meno tollerante e 'ragionevole' di quella che egli aveva
in principio entusiasticamente salutato. Incupito dalle delusioni (il romanzo
Candido satira dell'ottimismo filosofico, è del 1759), cercò rifugio in Francia
e lo trovò acquistando la villa di Ferney, a pochi passi dal confine. Qui visse
per venti anni circondato da una piccola corte personale e divenuto ormai
'il patriarca di Ferney', riverito dai potenti d'Europa e visitato da
innumerevoli ammiratori. Con energia indomabile scrisse ancora satire, opere
teatrali, racconti filosofici e libelli, diretti soprattutto allo scopo di
'écraser l'infame', di schiacciare cioè il fanatismo e l'intolleranza
della Chiesa cattolica; denunciò con interventi appassionati le insufficienze
dell'apparato giudiziario, ottenendo, fra l'altro, la riabilitazione di Calas
(1762); continuò a lottare per il trionfo della 'raison' con opere
memorabili, come il Trattato sulla tolleranza (1763) e il Dizionario filosofico
(1764); pubblicò L'Ingenuo (1767) e La principessa di Babilonia (1768);
intrattenne una vastissima corrispondenza (circa 6.000 lettere), confortando le
vittime della sorte e delle ingiustizie e dimostrandosi sempre un abile gestore
dei propri beni e della propria gloria. Chiamato a Parigi nel 1778 per una
rappresentazione dell'Irene, vi morì in mezzo al frastuono delle accoglienze
trionfali. Fu inumato fuori città, avendogli il clero parigino rifiutato la
sepoltura religiosa. Le sue spoglie furono fatte trasferire nel 1791 nel
Panthéon dalla Costituente.
Voltaire scrittore ha dato il meglio di sé nelle opere storiche, delle
quali la cultura moderna apprezza sempre più la forza innovatrice, negli
scritti polemici e nell'epistolario. Le tragedie si riducono a una debole
imitazione di Corneille e di Racine; le commedie sono di una piattezza che
contrasta con la consueta arguzia dell'autore; la critica letteraria rivela un
gusto troppo condizionato dai modelli classici. Su Voltaire filosofo è un luogo
comune d'obbligo la premessa che a lui non si deve nessun reale avanzamento del
pensiero e che il suo mondo concettuale è interamente costruito con materiali
tratti da Locke, Bayle, Clarke, Shaftesbury, Newton. E tuttavia le intenzioni
riduttive implicite in osservazioni di questo genere, così come l'usuale
definizione di Voltaire 'grande giornalista', vanno accolte con
qualche cautela e riserva. In primo luogo Voltaire è una sorta di archetipo
della funzione dell'uomo di lettere nella società moderna, un punto di
riferimento obbligato dinanzi alle tentazioni del silenzio e del disimpegno. In
secondo luogo egli riassume in sé e vive come nessun altro i grandi temi
culturali del suo tempo. Deista in religione, utilitarista in etica, moderato
in politica, ammiratore dell'Inghilterra costituzionale, diffidente verso gli
impulsi irresponsabili della 'populace' ('plebaglia'),
Voltaire preferisce la linea mediana perché non si fa illusioni sull'uomo e sul
mondo. I poteri dell'uomo sono molto limitati e il male e il negativo stanno in
agguato dappertutto. Ma vivere bisogna, e con impegno coscienzioso
'coltivare il proprio giardino'. La dignità dell'uomo sta nel
difendere i diritti sovrani della ragione, la quale si afferma nel corso della
storia attraverso un drammatico alternarsi di vittorie e di sconfitte. La
modernità dell'etica di Voltaire (ha osservato C. Bo a proposito del Candido)
sta proprio nella determinazione umile e coraggiosa, priva di tracotanti
certezze: la nostra vita è un mistero, ma noi possiamo comunque renderla
migliore.