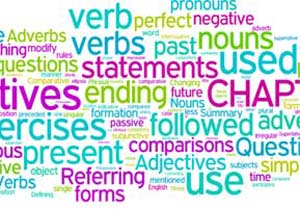"L'età imperiale", "Seneca"
Possiamo osservare
come, non solo nel corso della storia contemporanea, ma anche epoca antica,
molto spesso la struttura e l'organizzazione della società hanno costituito un
fattore di limitazione della libertà individuale. Ciò ha influito in maniera
profonda condizionando l'agire di tutti individui, ma in particolare ha
ristretto fortemente la libertà di espressione degli intellettuali, io cui
pensiero spesso era in contrasto con gli interessi di chi gestiva il potere.
Per quanto riguarda la storia antica, esempi molto rilevanti possono essere
riscontrati nell'analisi della struttura della società dell'età imperiale
romana. In seguito all'instaurazione del principato, infatti, la vita
intellettuale venne ad essere sempre più strettamente condizionata e
controllata dal potere politico. La dipendenza dei letterati da personaggi
socialmente, economicamente, politicamente influenti ed autorevoli era stata
assai rilevante già in epoca repubblicana; sotto l'impero tuttavia divenne
ancora più stretta e vincolante in conseguenza del fortissimo accentramento
della gestione del potere nelle mani dell'imperatore: ne conseguì infatti una
drastica riduzione di quegli spazi di libertà e autonomia che prima si aprivano
nel quadro complesso e variegato della vita politica, culturale e sociale.
Mentre sotto la repubblica molti uomini politici, oltre ad essere scrittori
essi stessi, erano stati attivi promotori di cultura, sotto l'impero tale
funzione venne assolta quasi esclusivamente dai principi, il cui potere era
assoluto e la cui autorità tendeva a controllare attivamente e severamente la
vita intellettuale. Già sotto Augusto, quando venne meno la preziosa opera di
mediazione tra gli intellettuali e il principe attuata da Mecenate, sembrò
spezzarsi quell'equilibrio che si era potuto realizzare fra le esigenze e le
pressioni del potere politico da una parte e la libertà e l'autonomia degli
intellettuali dall'altra. Si manifestarono, quindi, evidenti segni di disagio
nei rapporti tra i letterati e l'imperatore. Uno degli intellettuali che segnò
più profondamente quell'età fu sicuramente Seneca, che visse durante il regno
di Caligola, Claudio e Nerone. Il filosofo (nato a Cordova nel 4 a.C. e morto a Roma nel 65,
proprio per volere di Nerone), ebbe rapporti molto stretti con la dinastia dei
regnanti, e svolse ruoli di assoluto rilievo nella gestione dell'impero, in
particolare dopo la nascita di Nerone, del quale gli era stata affidata
l'educazione. Proprio in virtù dei suoi contatti con la famiglia imperiale,
ebbe modo di analizzare dall'interno le modalità di gestione del potere, ed
espresse il suo pensiero politico in diverse opere, quali il De ira, l'Apokolokyntosys e il De
clementia. Attraverso tali scritti, il filosofo volle indicare a chi
deteneva il potere assoluto quale fosse il modo migliore per amministrarlo, per
non permettere che si sviluppassero regimi tirannici. Nel primo affronta il tema dell'ira
riferendosi all'uomo di potere; a costui consiglia la moderazione, intesa come
autocontrollo; il referente di Seneca è ovviamente l'imperatore, che gode di un
potere illimitato, e che in tal modo viene invitato a porre un freno alle
proprie passioni ed alle proprie collere. Non è un caso, infatti, che egli
operi un paragone tra Caligola, autore di frequenti azioni incontrollate, e
Augusto, esempio di regnante moderato.
La seconda opera,
invece, scritta dopo la morte di Claudio, costituisce e una condanna del modo
tirannico di gestire il potere; nell'aldilà, infatti, quest'ultimo viene
giudicato da Augusto, il che dimostra la predilezione di Seneca per un ritorno
ai valori della prima età dell'impero, intonata alla moderazione ed alla
tolleranza. D'altra parte, però, Nerone viene presentato come colui che saprà
realizzare nella vita dell'impero una nuova età dell'oro; ciò viene sia
considerato come un omaggio servile nei confronti del nuovo imperatore, del
quale Seneca cerca di ottenere la benevolenza, sia come un augurio di una nuova
età politica fondata sui principi della moderazione, della tolleranza e della
libertà. Un'altra opera fondamentale nell'ambito del pensiero politico di
Seneca è sicuramente, come si è detto, il De
clementia, in cui l'autore ci presenta il frutto più maturo delle sue
riflessioni politiche; egli non affronta il tema se il principato sia o meno la
forma di governo più adatta, ma si limita ad consigliare all'imperatore,
Nerone, il modo migliore per amministrare il suo potere, teorizzando ed
esaltando una forma di monarchia che potrebbe essere definita "illuminata".
Egli consiglia di fondare la propria condotta politica sulla clementia, se vuole essere un rex iustus. Essa non è la generica bontà
o moderazione, ma un consapevole e illuminato atteggiamento politico; essa
consiste in un'autolimitazione, da parte dell'imperatore, del proprio potere.
Tale forma di autocontrollo produce un miglioramento nei rapporti del sovrano
con i sudditi, permettendo di ottenere la simpatia della gente e la pax sociale. La clementia, quindi, viene vista come l'unico antidoto alla nascita
di un potere tirannico, un dono del principe per i suoi sudditi, nei confronti
dei quali si comporta come un padre affettuoso, reputando il suo potere come un
peso da sopportare, spendendo la sua vita nell'esclusivi interesse delle stato.
Per fare in modo che la clementia diventi
una componente basilare del mondo morale del principe, la sua educazione deve
essere affidata alla figura del filosofo, considerato da Seneca un "forgiatore
di coscienze".
Soltanto attraverso
questo tipo di gestione del potere, quindi, poteva essere garantita la presenza di una società liberale e non
oppressiva della libertà del cittadino, sebbene fosse retta da un potere di
tipo assolutistico.