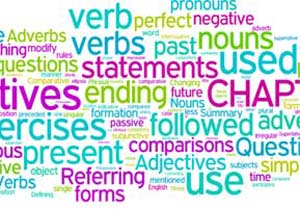Foscolo, Ugo (Zante 1778 - Turnham Green,
Londra 1827), poeta italiano. Nato nell'isola greca di Zante, l'antica Zacinto,
allora possedimento venziano, Foscolo si trasferì a Venezia nel 1792; qui, a
contatto con letterati allora famosi (Ippolito Pindemonte, Melchiorre
Cesarotti, traduttore di Ossian), si formò una solida cultura e iniziò il suo
apprendistato poetico. Le sue idee giacobine e rivoluzionarie lo costrinsero a
ritirarsi nel 1796 sui colli Euganei e, dopo la rappresentazione della tragedia
Tieste (1797), che gli valse una certa notorietà, fu costretto a
riparare a Bologna nella Repubblica Cispadana, dove pubblicò l'ode A
Bonaparte liberatore. Tornò poi a Venezia, dove era nato un governo
democratico, ma le speranze di libertà vennero stroncate dal trattato di
Campoformio (novembre 1797), col quale Napoleone cedette Venezia all'Austria.
Amareggiato lasciò la città e si recò a Milano, capitale della Repubblica
Cisalpina.
L'ORTIS
Fu la caduta delle speranze in un rinnovamento politico da parte di Napoleone a
ispirargli Le ultime lettere di Jacopo Ortis (la prima edizione completa
è del 1802 e quella definitiva, la quarta, è del 1817), il primo romanzo
italiano. Si tratta di un romanzo epistolare orientato sui modelli di
Jean-Jacques Rousseau (Giulia o la nuova Eloisa) e di Goethe (I
dolori del giovane Werther), ma con l'originale inserzione della tematica
politica, le cui radici stanno nella storia contemporanea e nelle vicende
autobiografiche cui si è fatto cenno. Il romanzo, che presenta un autoritratto
dell'autore e denuncia una forte sensibilità preromantica, è stato definito dal
critico letterario Mario Fubini una 'tragedia alfieriana in prosa':
il protagonista, di fronte alla tirannia di Napoleone, che gli toglie la
patria, e alla tirannia delle convenzioni sociali (incarnate dal padre di
Teresa), che gli tolgono la donna amata, afferma la propria libertà attraverso
il suicidio, secondo il modello alfieriano. Foscolo era tanto legato a questo
testo, rimaneggiato nell'arco di un ventennio, che negli ultimi anni di vita
ancora meditava di riscriverlo.
I SEPOLCRI
A Milano conobbe Giuseppe Parini, ormai vecchio, e frequentò Vincenzo Monti, lo
scrittore più autorevole nella Milano napoleonica. Qui, nel 1803, apparvero le Poesie
di Foscolo: dodici sonetti, di cui alcuni tra i maggiori di tutta la nostra
tradizione, e due odi, di impianto neoclassico. Dopo due anni trascorsi in
Francia, in occasione dell'estensione all'Italia nel 1806 dell'editto di Saint
Cloud, che imponeva la collocazione dei cimiteri fuori dall'abitato e una
regolamentazione egualitaria delle tombe, Foscolo compose il suo testo più
intenso, il carme, in 295 endecasillabi sciolti, Dei Sepolcri, l'unico
testo che non abbia avuto una composizione per interventi successivi. Pur
muovendo da una concezione materialistico-meccanicistica, l'autore celebra la
funzione del sepolcro nella storia dell'umanità sia sul piano individuale
illusorio (si tengono vivi i defunti oltre la morte), sia su quello storico
oggettivo (il sepolcro è una delle istituzioni che segnano il passaggio
dell'umanità dalla preistoria alla storia), sia su quello della funzione civile
e politica (le tombe dei grandi sepolti in Santa Croce), sia su quello del
sepolcro come fonte di poesia (mito di Omero), capace questa di trascendere il
momento della distruzione implicita nelle leggi della materia.
DIDIMO CHIERICO
Nel soggiorno francese sulla Manica (1804-1806) Foscolo aveva tradotto il Sentimental
Journey through France and Italy di Laurence Sterne (Viaggio
sentimentale di Yorick lungo la
Francia e l'Italia), il cui penetrante umorismo indusse
Foscolo a una svolta stilistica che avrebbe trovato espressione anche in
scritti successivi. La pubblicazione di questa traduzione (1813) era
accompagnata da una Notizia intorno a Didimo Chierico, ironico
autoritratto in cui l'autore si presenta in una dimensione psicologica opposta
a quella di Jacopo Ortis: tanto questi era passionale, emotivo, incontenibile
(anche sul piano espressivo), tanto Didimo è misurato, ironico, disincantato, e
tuttavia ancora capace di covare una tensione interiore.
Nel 1808 Foscolo aveva ottenuto la cattedra di eloquenza all'Università di
Pavia. Fu un'esperienza brevissima, ed egli vi tenne solo la prolusione (Dell'origine
e dell'ufficio della letteratura italiana, 1808), ma tra le carte rimasero
due Lezioni sulla letteratura e la lingua e tre lezioni Della morale
letteraria, in cui definisce la propria ideologia culturale.
IL PERIODO INGLESE: LE GRAZIE
Quando gli austriaci tornarono a Milano nel 1814, il Foscolo resistette alle
loro proposte di collaborazione e partì in volontario esilio attraverso la Svizzera (1815) verso
l'Inghilterra (1816). Qui riprese a lavorare a un poema, Le Grazie, che
rimase incompiuto in uno stato intenzionalmente (così oggi si interpreta)
frammentario. Esso voleva essere una sintesi totale delle tematiche foscoliane,
sviluppate attorno all'idea centrale della funzione civilizzatrice della
bellezza, capace di vincere non solo la barbarie della preistoria ma quella
immanente nella storia umana e, ancora, quella insediata in ciascuno di noi,
dunque capace di consolare l'uomo nel dolore inevitabile dell'esistenza. La
frammentarietà del testo, all'interno di un'intelaiatura logica chiara,
conferisce spessore ai singoli brani e apre a una modernissima ricerca dell'analogia.
Del resto lo sforzo continuo di Foscolo fu quello di dare compostezza (e ordine
e grazia) a una tensione conoscitiva e vitale che lo apparenta, nonostante la
sua poetica classica, alla dispiegantesi sensibilità romantica.